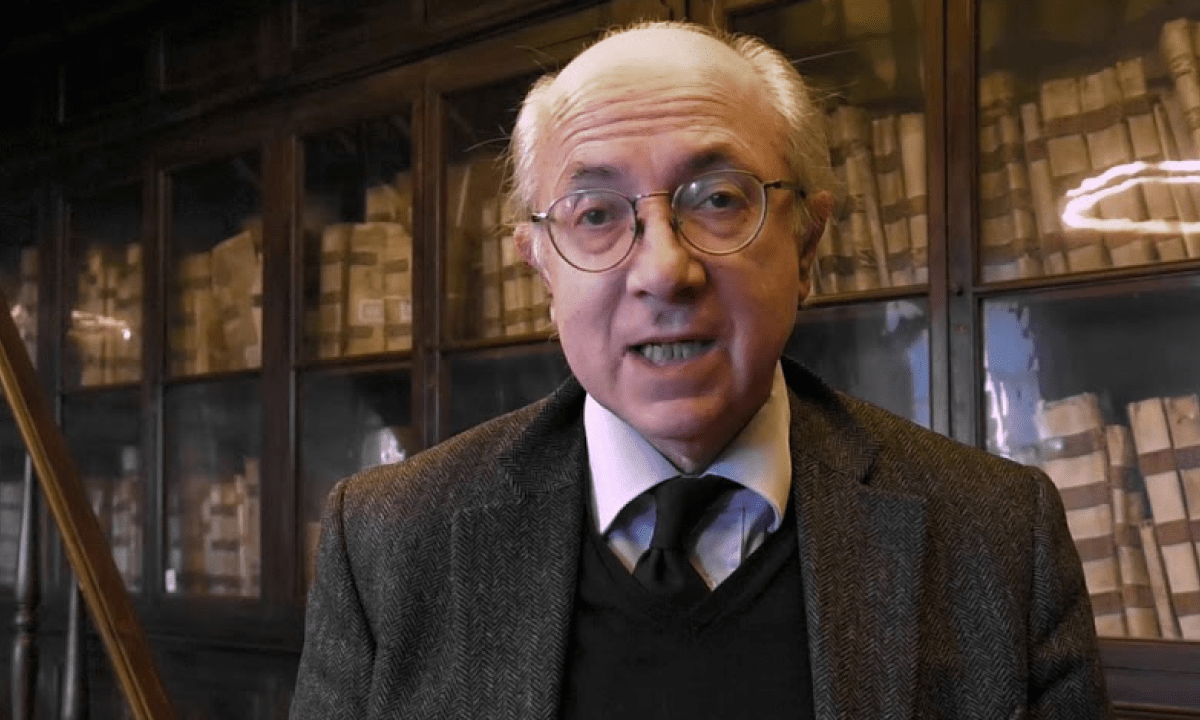L’effetto più tremendo in tutta questa calamità era lo scoramento, quando ci si accorgeva di essere colpiti (abbandonavano subito ogni speranza, si ritenevano senz’altro spacciati, e non opponevano nessuna resistenza al male); e il fatto che, curandosi a vicenda, morivano di contagio, come avviene tra le bestie. Era appunto al contagio che si doveva la più intensa mortalità. [5] Quelli che per paura evitavano i contatti morivano in solitudine (e molte famiglie furono spazzate via perché nessuno volle far loro da infermiere). Quelli che non li evitavano vi rimettevano la vita: specie coloro che tenevano a mostrare una certa nobiltà di sentimenti. Spronati dal senso dell’onore essi arrischiavano la propria esistenza visitando gli amici; mentre invece perfino i familiari, alla fine, oppressi ed esauriti dall’orrore del male, arrivavano a trascurare persino le lamentazioni sui propri morti. [6] A ogni modo maggiore pietà di questi familiari mostravano, verso chi moriva e chi lottava col male, coloro che ne erano scampati, per l’esperienza fatta, e perché ormai si sentivano al sicuro. Giacché il male non tornava la seconda volta: o almeno non tornava con esito letale. Gli altri li consideravano felici: ed essi stessi nell’esaltazione del momento si abbandonavano senza riflettere alla vaga speranza che anche per l’avvenire nessun’altra malattia se li sarebbe mai più portati via.
53. [1] L’epidemia diede il segnale al dilagare della scostumatezza in Atene. Gli istinti, prima occulti, si sfrenarono dinanzi allo spettacolo dei rapidi cambiamenti: di ricchi subito morti, di nullatenenti a un tratto ereditieri. [2] La vita e il denaro avevano agli occhi della gente lo stesso effimero valore. Godere si voleva: in fretta, materialmente.
[3] La prospettiva di spendere tempo e fatica per uno scopo degno, quando il suo raggiungimento poteva essere arrestato dalla morte, non attraeva più nessuno. Il piacere immediato e tutto ciò che facilitasse l’arrivarvi: questo solo appariva utile e degno. [4] Nessun timore divino, nessuna legge umana li tratteneva. Empietà o religione erano tutt’uno per chi vedeva che tutti ugualmente perivano. E quanto al castigo delle colpe, nessuno si attendeva di viver tanto da scontarle: ben più tremenda sentenza pesava ormai sul loro capo, e prima che scoccasse l’ora valeva la pena aver vissuto.
In quel momento si udì una voce for te e secca, voce di qualcuno che, dal tono, sembrava abituato a dare ordini. Veniva da un altoparlante fissato sopra la porta da cui erano entrati. Fu pronunciata tre volte la parola Attenzione, poi la voce attaccò, Al Governo rincresce di essere stato costretto a esercitare energicamente quello che considera suo diritto e suo dovere, proteggere con tutti i mezzi la popolazione nella crisi che stiamo attraversando, quando sembra si verifichi qualcosa di simile a una violenta epidemia di cecità, provvisoriamente designata come mal bianco, e desidererebbe poter contare sul senso civico e la collaborazione di tutti i cittadini per bloccare il propagarsi del contagio, nell’ipotesi che di contagio si tratti, nell’ipotesi che non ci si tro vi unicamente davanti a una serie di coincidenze per ora inspiegabili. La decisione di riunire in uno stesso luogo tutte le persone colpite e, in un luogo prossimo, ma separato, quelle che con esse abbiano avuto qualche tipo di contatto, non è stata presa senza seria ponderazione. Il Governo è perfettamente consapevole delle proprie responsabilità e si aspetta da coloro ai quali questo messaggio è rivolto che assumano anch’essi, da cittadini rispettosi quali devono essere, le loro responsabilità, pensando anche che l’isolamento in cui ora si trovano rappresenterà, al di là di qualsiasi altra considerazione personale, un atto di solidarietà verso il resto della comunità nazionale. Detto ciò, richiamiamo l’attenzione di tutti alle istruzioni che seguono, primo, le luci si manterranno sempre accese, sarà inutile qualsiasi tentativo di manovrare gli interruttori, non funzionano, secondo, chi abbandonerà l’edificio senza autorizzazione verrà immediatamente passato per le armi, ripeto, immediatamente passato per le armi, terzo, in ogni camerata esiste un telefono che potrà essere usato solo per richiedere all’esterno prodotti per l’igiene e la pulizia, quarto, gli internati laveranno manualmente i propri indumenti, quinto, si raccomanda l’elezione di responsabili di camerata, si tratta di una raccomandazione, non di un ordine, gli internati si organizzeranno come meglio credono, purché rispettino le suddette regole e quelle che verranno enunciate qui di seguito, sesto, tre volte al giorno saranno depositate razioni di cibo alla porta d’ingresso, a destra e a sinistra, destinate rispettivamente ai pazienti e ai sospetti di contagio, settimo, tutti gli avanzi dovranno essere bruciati, considerandosi avanzi, all’uopo, non solo ogni tipo di cibo avanzato, ma anche le casse, i piatti e le posate, che sono di materiale combustibile, ottavo, l’operazione dovrà essere effettuata nei cortili interni dell’edificio o nel recinto, nono, gli internati sono responsabili di tutte le eventuali conseguenze di tali operazioni di incenerimento, decimo, in caso di incendio, sia esso fortuito o intenzionale, i pompieri non interverranno, undicesimo, gli internati non dovranno contare su alcun tipo di intervento dall’esterno nell’ipotesi che fra di essi si verifichino malattie, nonché l’insorgere di disordini o aggressioni, dodicesimo, in caso di morte, qualunque ne sia la causa, gli internati sotterreranno senza formalità il cadavere nel recinto, tredicesimo, la comunicazione fra l’ala dei pazienti e l’ala dei sospetti di contagio avverrà tramite il corpo centrale dell’edificio, lo stesso da cui siete entrati, quattordicesimo, i sospetti di contagio che dovessero diventare ciechi passeranno immediatamente nell’ala destinata a coloro che già lo sono, quindicesimo, questa comunicazione sarà ripetuta tutti i giorni, a questa stessa ora, per conoscenza dei nuovi ammessi. Il Governo e la Nazione si aspettano che ciascuno compia il proprio dovere. Buonanotte.
I flagelli, invero, sono una cosa comune, ma si crede difficilmente ai flagelli quando ti piombano sulla testa. Nel mondo ci sono state, in egual numero, pestilenze e guerre; e tuttavia pestilenze e guerre colgono gli uomini sempre impreparati….. Il flagello non è commisurato all'uomo, ci si dice quindi che il flagello è irreale, è un brutto sogno che passerà. Ma non passa sempre, e di cattivo sogno in cattivo sogno sono gli uomini che passano, e gli umanisti, in primo luogo, in quanto non hanno preso le loro precauzioni. I nostri concittadini non erano più colpevoli d'altri, dimenticavano di essere modesti, ecco tutto, e pensavano che tutto era ancora possibile per loro, il che supponeva impossibili i flagelli. Continuavano a concludere affari e a preparare viaggi, avevano delle opinioni. Come avrebbero pensato ala peste, che sopprime il futuro, i mutamenti di luogo e le discussioni? Essi si credevano liberi, e nessuno sarà mai libero sino a tanto che ci saranno i flagelli.
Il peggio erano i vivi, che sembrava avessero perduto occhi e anima sotto il peso dello spavento e dell'ansia della morte. Dappertutto il viandante udiva e vedeva cose strane ed orrende.
Genitori che avevano abbandonato i figli colti dal male, mariti che avevano abbandonato le mogli. I monatti e gli sbirri d'ospedale dominavano come carnefici, predavano nelle case lasciate vuote dalla morte, a loro capriccio ora lasciavano i cadaveri insepolti, ora strappavano dai letti i vivi prima che avessero esalato l'ultimo respiro e li gettavano sui carri funebri. Fuggiaschi vagavano solitari, abbrutiti, evitando ogni contatto con gli uomini, cacciati dalla paura della morte. Altri si riunivano in una gioia di vivere eccitata e sgomenta, tenevano orge e celebra- ii vano feste da ballo e d'amore, in cui la morte sonava la viola. Altri, trascurati nella persona, piangenti o imprecanti, con gli occhi smarriti, stavano accovacciati davanti ai cimiteri o alle loro case spopolate. E peggio di tutto: ognuno cercava per quell'insopportabile calamità un capro espiatorio, ognuno affermava di conoscere gli scellerati ch'erano i colpevoli e malvagi promotori della pestilenza.
Uomini diabolici, si diceva, provvedevano con gioia maligna alla propagazione della strage, prendendo il veleno dai cadaveri degli appestati e fregandolo sui muri e sulle maniglie delle porte, o avvelenando le fontane e il bestiame. Chi cadeva in sospetto di compiere tale mostruosità era perduto se, avvisato in tempo, non riusciva a fuggire; era punito con la morte dalla giustizia o dalla plebe. Inoltre i ricchi davano la colpa ai poveri e vice-versa, oppure si diceva che i colpevoli erano gli ebrei o i latini o i medici. In una città Boccadoro, col cuore indignato, vide ardere tutta la via degli ebrei, una casa dopo l'altra, mentre intorno il popolo urlava e i fuggiaschi atterriti venivano ricacciati nel fuoco con la forza delle armi. Nella follia ella paura e dell'esasperazione, dappertutto si uccidevano, si bruciavano e si torturavano innocenti. Boccadoro assisteva con furore e disgusto: il mondo pareva sovvertito e avvelenato, pareva che non esistessero più gioia, innocenza e amore sulla terra. A volte si rifugiava nelle feste turbolente di chi voleva godere la vita.
Dappertutto sonava la viola della morte; egli imparò presto a conoscerne il suono; a volte prendeva parte a quei festini disperati, a volte sonava anch'egli il liuto o ballava alla luce delle torce a vento, nelle notti febbrili.
Paura non ne sentiva. Una volta aveva provato l'ansia della morte, in quella notte d'inverno sotto gli abeti, mentre le dita di Vittore gli stringevano la gola, e anche in altre due giornate del suo vagabondaggio, nella neve e nella fame. Quella era una morte con cui si poteva com-battere, da cui ci si poteva difendere, ed egli si era difeso, con le mani e i piedi tremanti, con lo stomaco vuoto, con le membra esauste; si era difeso, aveva vinto, era sfuggito.
Ma con la morte causata dalla peste non si poteva lottare bisognava lasciarla infuriare ed arrendersi, e Boccadoro si era arreso da un pezzo. Non aveva paura, sembrava che non gl'importasse più nulla della vita, da quando aveva lasciato Lena nella capanna ardente, da quando avanzava giorno per giorno nel paese devastato dalla morte.
Ma una straordinaria curiosità lo spingeva e lo teneva desto; era instancabile nel contemplare la grande mietitrice, nell’ascoltare il canto della caducità; non si tirava mai da parte, sempre lo afferrava la stessa tacita passione d'essere presente e di camminare con gli occhi aperti attraverso l'inferno. Mangiava pane ammuffito nelle case spopolate, cantava e trincava nelle orge folli, coglieva il fiore del piacere presto appassito, guardava negli occhi fissi ed ebbri delle donne, guardava negli occhi fissi e melensi degli ubriachi, guardava negli occhi che si spegnevano dei morenti, amava le donne disperate e febbricitanti, per un piatto di minestra aiutava a portar via i morti, per pochi quattrini aiutava a gettar terra sopra i cadaveri nudi. Tetro e selvaggio s'era fatto il mondo, la morte cantava urlando la sua canzone, Boccadoro ascoltava con l'orecchio teso, con passione ardente.
Smanioso di sapere qualcosa di nuovo e di esatto sull’andamento e sui progressi della sciagura, vagabondava in cerca, nei caffè della città, dei giornali del suo paese, che erano da parecchi giorni scomparsi dalla tavola di lettura nell’atrio dell’albergo. Vi si alternavano affermazioni e smentite. Il numero dei casi di malattia e di morte pareva ammontasse a venti, quaranta, addirittura cento e più, ma poi la comparsa dell’epidemia veniva, se non contestata in modo chiaro e preciso, tuttavia fatta risalire a casi isolatissimi, importati da fuori. Vi si leggevano pure moniti e proteste contro il gioco pericoloso delle autorità italiane, ma certezza non se ne poteva raggiungere.
Già da parecchi anni il colera indiano aveva manifestato maggiore tendenza a propagarsi e a migrare.
Generata dai caldi terreni paludosi al delta del Gange, aumentata dalle esalazioni mefitiche di quel rigoglioso e inutile luogo selvaggio preistorico e insulare, disertato dagli uomini, nei cui canneti si cela la tigre, l’epidemia aveva imperversato con violenza continua e insolita in tutto l’Indostan, invadendo a levante la Cina e a ponente l’Afghanistan e la Persia e portando, sulle piste delle principali carovaniere, il terrore fino ad Astrakan e addirittura fino a Mosca. Ma, mentre l’Europa tremava nel timore che lo spettro potesse introdursi da laggiù via terra, era comparso, propagato via mare, da navi mercantili siriane, quasi contemporaneamente, in parecchi porti mediterranei, sollevando la testa a Tolone e Malaga, mostrando la sua maschera più volte a Palermo e a Napoli, sembrando pure che non volesse più ritirarsi dalla Calabria e dalla Puglia. Il nord della penisola era stato risparmiato. Tuttavia alla metà di maggio di quell’anno, a Venezia furono trovati, nello stesso giorno, i terribili vibrioni nei cadaveri consunti e nerastri d’un mozzo e d’una fruttivendola. I casi vennero taciuti. Ma dopo una settimana ce n’erano dieci, venti, trenta e pure in diversi sestieri. Un austriaco che per diporto s’era trattenuto qualche giorno a Venezia, ritornato nella sua cittadina, morì con sintomi inequivocabili, e il fatto causò la comparsa sui giornali tedeschi delle prime voci sulla disgrazia nella città lagunare. Le autorità veneziane fecero rispondere che le condizioni sanitarie della città non erano mai state migliori, e presero le necessarie misure di sicurezza. Ma probabilmente generi alimentari, verdure, carne e latte erano già infetti, perché, nonostante smentite e occultamenti, la morte si estese distruggendo nelle anguste calli, e il caldo estivo, subentrato prematuro, intiepidendo l’acqua dei canali, favorì in modo particolare la diffusione. Sembrava addirittura che l’epidemia si fosse rinvigorita di forze, raddoppiata di tenacia e fertilità. I casi di guarigione erano rari; l’ottanta per cento dei colpiti moriva, e pure in modo orrendo, perché il male insorgeva con estrema violenza, presentando spesso quella forma pericolosissima detta «asciutta». In tale eventualità il corpo non riusciva neppure a espellere l’acqua secreta in abbondanza dai vasi sanguigni. In poche ore il malato, insecchitosi, soffocava per il sangue divenuto viscido come la pece, tra crampi e lamenti rauchi. Era da reputarsi fortunato se, come talvolta accadeva, all’accesso seguiva, dopo un leggero malessere, un deliquio profondo dal quale non si svegliava più, o quasi.
Al principio di giugno furono riempiti tacitamente i padiglioni d’isolamento dell’ospedale civico, nei due orfanotrofi cominciavano a mancare i posti, tra la riva delle Fondamenta Nuove e San Michele, l’isola del cimitero, regnava un movimento d’intensità spaventosa. Ma il timore di una rovina troppo generale, il riguardo per l’esposizione di pittura recentemente aperta nel parco pubblico, per le enormi perdite che, in caso di panico e proscrizioni, avrebbero minacciato gli alberghi, i negozi, tutta la molteplice industria turistica, si mostrarono nella città più potenti dell’amore per la verità e del rispetto delle convenzioni internazionali; ebbero il potere di far persistere ostinate le autorità nella politica del silenzio e della smentita.
Indignato, il più alto ufficiale sanitario di Venezia aveva rassegnato le dimissioni ed era stato sostituito alla chetichella da un uomo più arrendevole. La cittadinanza sapeva; ma la corruzione dei maggiorenti insieme con la regnante incertezza generale, con lo stato d’emergenza in cui la morte vagabonda aveva trasferito la città, produsse una certa depravazione degli strati inferiori, un incoraggiamento a impulsi foschi e antisociali, che si manifestò con sfrenatezza, impudicizia e crescente criminalità. Contro il solito la sera si notavano molti ubriachi; gentaglia malvagia, dicevano, rendeva di notte le strade malsicure; c’erano stati ripetuti casi di rapina e persino d’omicidio, in quanto già due volte era stato scoperto che persone presunte vittime dell’epidemia, erano state invece eliminate con il veleno dai loro propri familiari; la sciatteria professionale assumeva forme sfacciate e dissolute, prima d’allora mai conosciute in quei posti, mentre erano state di casa nel sud del paese e in Oriente.
La 'peste' era scoppiata a Napoli il 1 ottobre 1943, il giorno stesso in cui gli eserciti alleati erano entrati come liberatori in quella sciagurata città. Il 1 ottobre 1943 è una data memorabile nella storia di Napoli: perché segna l'inizio della liberazione dell'Italia e dell'Europa dall'angoscia, dalla vergogna, e dalle sofferenze della schiavitù e della guerra, e perché proprio in quel giorno scoppiò la terribile peste, che da quell'infelice città si sparse a poco a poco per tutta l'Italia e per tutta l'Europa. L'atroce sospetto, che lo spaventoso morbo fosse stato portato a Napoli dagli stessi liberatori, era certamente ingiusto: ma divenne certezza nell'animo del popolo quando si accorse, con meraviglia confusa a superstizioso terrore, che i soldati alleati rimanevano stranamente immuni dal contagio. Essi si aggiravano rosei, tranquilli, sorridenti, in mezzo alla folla degli appestati, senza contrarre lo schifoso morbo: che mieteva le sue vittime unicamente fra la popolazione civile, non soltanto della città, ma delle stesse campagne, allargandosi come una macchia d'olio nel territorio liberato, di mano in mano che gli eserciti alleati andavano faticosamente ricacciando i tedeschi verso il Nord.
Ma era severamente proibito, con la minaccia delle più gravi pene, insinuare in pubblico che la peste era stata portata in Italia dai liberatori. Ed era pericoloso ripeterlo in privato, sia pure a bassa voce, poiché fra i tanti e schifosi effetti di quella peste, il più schifoso era la matta furia, la voluttà golosa della delazione. Appena toccato dal morbo, ognuno diventava la spia del padre e della madre, dei fratelli, dei figli, dello sposo, dell'amante, dei congiunti e degli amici più cari; ma non mai di se medesimo. Uno tra i caratteri più sorprendenti e ributtanti di quella straordinaria peste, era infatti quello di trasformare la coscienza umana in un orrido e fetido bubbone.
Per combattere il morbo, le autorità militari inglesi e americane non avevano trovato altro rimedio, se non quello di proibire ai soldati alleati le zone più infette della città. Su tutti i muri si leggevano le scritte Off limits, Out of bonds, sormontate dall'aulico emblema della peste: un cerchio nero dentro il quale erano dipinte due nere sbarre incrociate, simili alle due tibie incrociate sotto il teschio nelle gualdrappe dei carri funebri.
In breve tempo, tranne poche strade del centro, tutta la città fu dichiarata Off limits. Ma le zone più frequentate dai liberatori erano proprio quelle Off limits, cioè quelle più infette e perciò vietate, poiché è nella natura dell'uomo, specie dei soldati di tutti i tempi e di qualunque esercito, preferire le cose proibite a quelle permesse. Talché il contagio, o che fosse stato portato a Napoli dai liberatori, o che da questi fosse trasportato da un luogo all'altro della città, dalle zone infette a quelle sane, raggiunse ben presto una violenza terribile, cui davano un carattere nefando, quasi diabolico, i suoi grotteschi, laidi aspetti di macabra festa popolare, di kermesse funebre: quelle danze di negri ubriachi e di donne quasi nude, o nude addirittura, nelle piazze e nelle strade, fra le rovine delle case distrutte dai bombardamenti; quel furor di bere, di mangiare, di godere, di cantare, di ridere, di scialare, e di far baldoria, nel lezzo orrendo che esalavano le centinaia e centinaia di cadaveri sepolti sotto le macerie.
Era, quella, una peste profondamente diversa, ma non meno orribile, dalle epidemie che nel medioevo devastavano di quando in quando l'Europa. Lo straordinario carattere di tal nuovissimo morbo era questo, che non corrompeva il corpo, ma l'anima. Le membra rimanevano in apparenza intatte, ma dentro l'involucro della carne sana l'anima si guastava, si disfaceva, Era una specie di peste morale, contro la quale non pareva vi fosse difesa alcuna. Le prime ad essere contagiate furono le donne, che, presso ogni nazione, sono il riparo più debole contro il vizio, e la porta aperta ad ogni male. E ciò parve cosa meravigliosa e dolorosissima, poiché durante gli anni della schiavitù e della guerra, fino al giorno della promessa e attesa liberazione, le donne, non a Napoli soltanto, ma in tutta l'Italia, in tutta l'Europa, avevano dato prova, nell'universale miseria e sciagura, di maggior dignità e di maggiore forza d'animo che non gli uomini. A Napoli, ed in ogni altro paese d'Europa, le donne non s'erano date ai tedeschi. Soltanto le prostitute avevano avuto commercio con i nemici: e neppure pubblicamente, ma di nascosto, sia per non dover subire le dure reazioni del sentimento popolare, sia perché tale commercio appariva a loro stesse il delitto più obbrobrioso che una donna potesse commettere in quegli anni.
Ed ecco che, per effetto di quella schifosa peste, che per prima cosa corrompeva il senso dell'onore e della dignità femminile, la più spaventosa prostituzione aveva portato la vergogna in ogni tugurio e in ogni palazzo. Ma perché dir vergogna? Tanta era l'iniqua forza del contagio, che prostituirsi era divenuto un atto degno di lode, quasi una prova di amor di patria, e tutti, uomini e donne, lungi dall'arrossirne, parevano gloriarsi della propria e della universale abbiezione. Molti, è vero, che la disperazione faceva ingiusti, quasi scusavano la peste: insinuando che le donne prendevano pretesto dal morbo per prostituirsi, che cercavano nella peste la giustificazione della loro vergogna.
Ma una più profonda conoscenza del morbo rivelò in seguito che un tale sospetto era maligno. Poiché le prime a disperarsi della loro sorte eran le donne: e molte ne ho udite io stesso piangere, e maledire quella crudelissima peste che le spingeva con invincibile violenza, contro la quale nulla poteva la loro debole virtù, a prostituirsi come cagne. Così son fatte, ahimè, le donne. Le quali spesso cercano di comprare con le lacrime la giustificazione delle loro vergogne, e la pietà. Ma questa volta è forza giustificarle, e averne pietà.
Se tale era la sorte delle donne, non meno pietosa e orribile era la sorte degli uomini. Non appena contagiati, essi perdevano ogni rispetto di se medesimi: si davano ai più ignobili commerci, commettevano le più sudice viltà, si trascinavano carponi nel fango baciando le scarpe dei loro 'liberatori' (disgustati di tanta, e non richiesta abbiezione), non solo per essere perdonati delle sofferenze e delle umiliazioni sofferte negli anni della schiavitù e della guerra, ma per aver l'onore d'essere calpestati dai nuovi padroni; sputavano sulle bandiere della propria patria, vendevano pubblicamente la propria moglie, le proprie figlie, la propria madre. Tutto ciò, dicevano, per salvare la patria. E pur quelli che, all'aspetto, sembravano immuni dal morbo, si ammalavano di una nauseante malattia, che li spingeva ad arrossire di essere italiani, e perfino di appartenere al genere umano. Bisogna riconoscere che facevan di tutto per essere indegni del nome di uomini. Pochissimi erano coloro che si serbavano intatti, come se il morbo nulla potesse contro la loro coscienza: e si aggiravano timidi, spauriti, disprezzati da tutti, quali importuni testimoni dell'universale vergogna.
...
Forse era scritto che la libertà dell'Europa dovesse nascere non dalla liberazione, ma dalla peste. Forse era scritto che, come la liberazione era nata dalle sofferenze della schiavitù e della guerra, la libertà dovesse nascere dalle sofferenze, nuove e terribili, della peste portata dalla liberazione. La libertà costa cara. Molto più cara della schiavitù. E non si paga né con l'oro, né col sangue, né con i più nobili sacrifici: ma con la vigliaccheria, la prostituzione, il tradimento, con tutto il marciume dell'animo umano.
La notizia che lui mi recò un bel mattino sconvolse tutto di colpo. In città, si diceva, era scoppiata la peste. Sul momento non volevo crederci: l'aveva detto come se parlasse non di Istanbul, ma di un altro luogo, di una città straniera; gli domandai come fosse venuto a saperlo, e che particolari conoscesse. Dato che cresceva il numero di chi moriva improvvisamente, se ne ricavò che doveva trattarsi di un contagio! Pensai che forse non era peste, e ne domandai i sintomi. Il Maestro mi rise in faccia: non dovevo agitarmi; se venivo colpito, senza dubbio me ne sarei accorto; per rendersene conto, c'erano tre giorni, in cui si ardeva dalla febbre. Si formavano gonfiori sotto le orecchie o le ascelle, sul ventre spuntavano bubboni, e poi la febbre divampava; talvolta si aprivano lacerazioni, talaltra si sputava sangue dai polmoni; c'era anche chi tossiva come un tisico. Aggiunse che in ogni quartiere quattro o cinque se n'erano già andati. …Vedendo nel quartiere un capannello di gente con una bara sulle spalle, mi inquietai ancor più. Mi accorsi che il Maestro, tornato da scuola, notando il mio stato, se ne compiaceva: trovandomi vigliacco, rinvigoriva la sua fiducia in sé, e io m'innervosivo. Desiderai che si liberasse dal fatuo orgoglio della baldanza: tentando di valutare la mia inquietudine, tirai fuori tutte le mie conoscenze mediche e letterarie; descrissi le scene di peste rimaste impresse nella mia memoria dalle opere di Ippocrate, Tucidide, Boccaccio; dissi che il morbo era ritenuto infettivo, ma le mie parole non servirono ad altro che ad aumentare il suo disprezzo per me. Lui non la temeva, la peste, che la malattia era da Dio predestinata; se all'uomo era prescritto di morire, moriva; era dunque vano, quel mio arrabattarmi, tappandomi in casa e troncando le relazioni con l'esterno, o cercando di scappare da Istanbul: se così stava scritto, la morte sarebbe venuta a coglierci fin laggiù. A che tanta paura? Per quelle colpe che da giorni stendevo sulla carta? Sorrise, pronunciando queste frasi; i suoi occhi luccicavano di speranza. Fino a quando non ci perdemmo di vista, non fui capace di risolvere se credesse davvero in quello che predicava. Per un attimo, la sua audacia mi aveva intimidito, ma poi, conversando come facevamo ai due capi del tavolo, mi ero insospettito, al ricordo di quei giochi crudeli. Gira e rigira, riportava il discorso sulle cattiverie che avevamo scritto l'uno di fronte all'altro, e, con una presunzione che mi rendeva furibondo, calcava la mano sullo stesso argomento: se io temevo così tanto la morte, allora non ero riuscito a superare quelle nefandezze che sembravo registrare con coraggio. L'ardire che avevo dimostrato nel dichiarare i miei peccati era dovuto a una semplice impudenza! Invece, l'incertezza provata in quei giorni dal Maestro derivava dall'attenzione meticolosa con la quale egli si soffermava sulla più piccola manchevolezza. Adesso si era ormai tranquillizzato, e la sicurezza che lo confortava di fronte alla peste lo aveva convinto, con buona pace in cuore, della propria innocenza. Rigettando tale motivazione, prima scioccamente accolta, decisi di oppormi a lui. Dichiarai schietto che quell'assenza di paura dipendeva non dalla tranquillità di coscienza, semmai dall'ignorare l'incombenza della morte. Spiegai che avremmo potuto guardarci dalla rovina, e aggiunsi che non bisognava toccare gli appestati, i quali andavano sepolti in fosse di calce; affermai la necessità di ridurre al minimo i rapporti tra le persone; e il Maestro non doveva frequentare una scuola così affollata. Questi ultimi consigli gli fecero venire in mente cose ancor più terrificanti della peste! Il mezzogiorno seguente protese le mani verso di me, dicendo che aveva palpato a uno a uno i bambini; constatando che rifiutavo, agghiacciato, di toccarlo, si avvicinò e si avvinghiò a me con voluttà; mi veniva da urlare, ma non ci riuscivo, come in un brutto sogno. Quanto al Maestro, sentenziava, con una cert'aria di scherno che avrei notato solo assai più tardi, che mi avrebbe insegnato lui a essere impavido.
Nessuno potrà spiegare perché la peste colpisca il vigliacco che fugge e risparmi il gaudente che si soddisfa sui cadaveri. Perché la fuga, la castità, la solitudine siano impotenti contro gli assalti del flagello; e perché un gruppo di libertini rifugiatosi in campagna - come Boccaccio con i suoi due robusti compagni e le sette lussuriose donzelle - possa attendere con tranquillità i giorni caldi in cui la peste si allontana; e perché in un castello delle vicinanze, trasformato in cittadella fortificata, con un cordone di armati che impediscono l’ingresso, la peste trasformi guarnigione e rifugiati in cadaveri e risparmi i soldati, i soli direttamente esposti al contagio. Chi saprà inoltre spiegare il motivo per cui i cordoni sanitari installati con gran dispiego di truppe da Mehmet Alì verso la fine del secolo scorso, durante una recrudescenza della peste egiziana, siano risultati efficaci nel proteggere conventi e scuole, prigioni e palazzi; e come invece numerosi focolai di una peste che aveva tutte le caratteristiche della peste orientale, si siano improvvisamente manifestati nell’Europa medievale, in località senza il minimo contatto con l’Oriente?
Partendo da queste stranezze, da questi misteri, da queste contraddizioni e da questi dati, si potrà comporre il ritratto spirituale di una malattia che scava l’organismo e la vita sino allo schianto e sino allo spasimo, come un dolore che, man mano che si intensifica e si approfondisce, moltiplica le sue risorse, e le sue vie d’accesso a tutti i livelli della sensibilità. ….
Quando in una città prende dimora la peste, le forme di vita normale crollano; non esistono più né servizi pubblici, né esercito, né polizia, né amministrazione municipale; si accendono roghi per ardervi i morti, a seconda delle disponibilità di mano d’opera. Ogni famiglia vuole avere il suo. Poi, man mano che il legno, lo spazio e la fiamma diventano più rari, esplodono le contese tra famiglie intorno ai roghi, cui segue ben presto una fuga generale perché i cadaveri sono troppo numerosi. Già i morti ingombrano le strade in barcollanti piramidi, addentate tutt’intorno dagli animali. Il fetore s’innalza verso il cielo come una fiamma. Intere strade sono bloccate dalle cataste di morti. A questo punto si aprono le case e appestati in delirio, con la mente ingombra di orribili fantasie, si riversano urlando nelle strade. Il male che tormenta loro le viscere, che circola in tutto il loro organismo, si scarica attraverso lo spirito in una serie di esplosioni. Altri appestati che, senza bubboni, senza dolore, senza delirio e senza pustole, si contemplano allo specchio con orgoglio, sentendosi crepare di salute, stramazzano a terra morti con il bacile della barba in mano, carichi di disprezzo per tutti gli altri appestati.
Sui rivoli sanguinolenti, densi, velenosi, del colore dell’angoscia e dell’oppio, che zampillano dai cadaveri, strani personaggi vestiti di cera - con nasi lunghi un metro, occhi vitrei, e ai piedi specie di sandali giapponesi fatti di un doppio strato di tavolette di legno, alcune orizzontali a forma di suole, altre verticali, che li isolano dagli umori contaminanti - passano salmodiando assurde litanie, le cui virtù non bastano ad evitare che a loro volta anch’essi cadano nella fornace. Questi medici ignoranti mostrano soltanto paura e puerilità.
Nelle case spalancate, entra la feccia della popolazione - immunizzata a quanto pare dalla sua frenetica cupidigia - e fa man bassa di ricchezze di cui sa perfettamente che è inutile approfittare. Ed è a questo punto che nasce il teatro. Il teatro, vale a dire una gratuità immediata che induce ad atti inutili e privi di benefici nel presente.
Gli ultimi superstiti perdono la testa: il figlio, sinora virtuoso e sottomesso, uccide il padre; il casto sodomizza i vicini. Il lussurioso diviene puro. L’avaro getta l’oro a manciate dalla finestra. L’Eroe guerriero incendia la città per salvar la quale ha un tempo rischiato la vita. L’elegante s’agghinda e va a passeggiare sui carnai. Né l’idea dell’assenza di sanzioni né quella della morte imminente, bastano a giustificare azioni così gratuitamente assurde, compiute da persone che negavano alla morte la facoltà di por termine ad ogni cosa. E come spiegare quell’esplosione di febbre erotica fra gli appestati guariti che, anziché fuggire, restano dove sono, cercando di strappare una malsana voluttà a donne moribonde o addirittura morte, semischiacciate sotto il cumulo di cadaveri dove il caso le ha poste.
Ma se è necessario un grave flagello per rivelare questa frenetica gratuità, e se questo flagello si chiama peste, si potrebbe forse cercar di scoprire cosa valga tale gratuità in rapporto alla nostra personalità totale. La situazione dell’appestato che muore senza distruzione materiale, con tutte le stimmate di un male assoluto e quasi astratto, è identica a quella dell’attore, che dai propri sentimenti viene interamente penetrato e sconvolto senza alcun beneficio per la realtà. Nell’aspetto fisico dell’attore, come in quello dell’appestato, tutto testimonia che la vita ha reagito sino al parossismo, e che pure non è avvenuto nulla…. Si può dunque dire che ogni vera libertà è nera e si identifica immancabilmente con la libertà sessuale, anch’essa nera senza che se ne sappia bene il perché. Da un pezzo infatti l’Eros platonico, il senso genetico, la libertà di vita, sono scomparsi sotto il cupo rivestimento della Libido, nella quale si identifica tutto ciò che di sporco, di infamante e di abietto è nel fatto di vivere, di precipitarsi con naturale e impuro vigore, con una forza continuamente rinnovata, verso la vita.
Ed è per questo che tutti i grandi Miti sono neri, e che fuori da una atmosfera di strage, di torture e di sangue versato, non si possono immaginare le splendide Favole che raccontano alle folle la prima divisione sessuale e il primo massacro di essenze che appaiono nella creazione.
Il teatro, come la peste, è modellato su questo massacro, su questa separazione essenziale. Scioglie conflitti, sprigiona forze, libera possibilità, e se queste possibilità e queste forze sono nere, la colpa non è della peste o del teatro, ma della vita.
Non ci pare che la vita quale è e quale ci è stata preparata offra molti motivi di esaltazione. Si direbbe che attraverso la peste scoppi un gigantesco ascesso collettivo, morale quanto sociale; non diversamente dalla peste, il teatro esiste per far scoppiare gli ascessi collettivi.
Può darsi che il veleno del teatro, iniettato nel corpo sociale, lo disintegri, come dice sant’Agostino, ma lo fa come una peste, come un flagello vendicatore, come un’epidemia salvatrice nella quale le epoche credule hanno voluto riconoscere il dito di Dio, e che altro non è se non l’applicazione della legge di natura per cui ogni gesto è compensato da un gesto, e ogni azione dalla sua reazione.
Il teatro, come la peste, è una crisi che si risolve con la morte o con la guarigione. E se la peste è una malattia superiore perché è crisi totale dopo la quale non rimane altro che la morte o una purificazione assoluta, anche il teatro è una malattia, perché è l’equilibrio supremo, non raggiungibile senza distruzione. Invita lo spirito a un delirio che esalta le sue energie; e, per concludere, si può notare che dal punto di vista umano l’azione del teatro, come quella della peste, è benefica, perché, spingendo gli uomini a vedersi quali sono, fa cadere la maschera, mette a nudo la menzogna, la rilassatezza, la bassezza e l’ipocrisia; scuote l’asfissiante inerzia della materia che deforma persino i dati più chiari dei sensi; e rivelando alle collettività la loro oscura potenza, la loro forza nascosta, le invita ad assumere di fronte al destino un atteggiamento eroico e superiore che altrimenti non avrebbero mai assunto.
Il problema che ora si pone è di sapere se nel nostro mondo che decade, che si avvia senza accorgersene al suicidio, sarà possibile trovare un gruppo di uomini capaci di imporre questo concetto superiore del teatro, che restituirà a tutti noi l’equivalente magico e naturale dei dogmi in cui abbiamo cessato di credere.
Sinceramente posso affermare che medici assai rinomati diagnosticarono a molti che sarebbero ben presto defunti, ed essi viceversa poco dopo si sentirono inaspettatamente liberi da ogni male; a molti altri assicurarono che si sarebbero salvati, e invece erano già quasi sul punto di morte.
Cosi, di questa malattia non c'era nessuna spiegazione possibile per la scienza umana, perché in tutti i casi essa aveva un decorso imprevedibile. Ad alcuni era di giovamento lavarsi, altri anche cosi erano ugualmente stroncati dalla morte; molti morivano per mancanza di cure, altri invece si salvavano, contrariamente a quanto c'era da aspettarsi; inoltre i metodi curativi avevano per ogni singolo paziente effetti differenti. Si può dire, insomma, che nessuno sapeva come fare per salvarsi, sia che prendesse precauzioni onde evitare il contagio, sia che cercasse di superare la malattia una volta che ne era colto. Si cadeva ammalati senza motivo e si guariva per puro caso. ….In quei giorni tutte le norme relative ai riti funebri erano trascurate: i morti non venivano scortati da processioni, com'è consuetudine, né accompagnati con i soliti canti, ma era già abbastanza se si trovava qualcuno che portasse a spalle uno dei morti fino alla spiaggia della città e qui giunto lo gettasse a terra, di dove i cadaveri sarebbero poi stati caricati su di una nave, tutti in mucchio, e trasportati dovunque fosse capitato. In quei momenti, però, i cittadini che prima erano stati divisi in fazioni, deposto l'odio reciproco, attendevano in comune agli uffici funebri, portando via personalmente e seppellendo anche i cadaveri di gente a cui non erano uniti da nessun legame. Coloro che prima si erano compiaciuti di condurre una vita dissipata e piena di vizi, anch'essi, abbandonate le loro riprovevoli abitudini, seguivano con scrupolo le norme della religione: non perché avessero imparato ad essere saggi e fossero diventati improvvisamente amanti della virtù (dato che le tendenze radicate negli uomini per natura o per lunga consuetudine di vita non si possono facilmente mutare, salvo che scenda su di loro una divina ispirazione); ma perché allora erano tutti quanti, si può dire, terrificati da ciò che succedeva, e, temendo di dover anch'essi prima o poi morire, erano logicamente costretti dalla necessità delle cose a imparare momentaneamente la morigeratezza. Tanto è vero che, appena guarivano dalla peste, di cui si fossero contagiati, e supponevano di essere ormai al sicuro, perché l'epidemia era passata ad altre persone, cambiavano di nuovo idea e tornavano ai loro vizi, dando più ancora di prima dimostrazione della loro sconveniente condotta e anzi superando se stessi in dissolutezza e in ogni altro genere di malefatte. Si potrebbe addirittura sostenere paradossalmente, ma senza dire una bugia, che quella pestilenza, o per caso o per un disegno divino, fece una scelta diligentissima, lasciando indenni proprio gli uomini peggiori. Ma questo si poté constatare solo qualche tempo più tardi.
Fra tutte le sciagure subite fino ad oggi dall'umanità le grandi epidemie hanno lasciato di sé un ricordo singolarmente vivo.
Esse agiscono con la fulmineità delle catastrofi naturali; ma mentre un terremoto si compie in poche e brevi scosse, l'epidemia ha una durata che può estendersi per mesi e perfino per un anno intero. Il terremoto suscita d'un colpo il culmine dell'orrore: le sue vittime muoiono tutte insieme nello stesso momento. Un'epidemia di peste ha invece effetto "cumulativo": dapprima solo pochi ne sono colpiti, poi i casi si moltiplicano; dappertutto si vedono dei morti, ed ecco che i morti sono più numerosi dei vivi. Alla fine, il risultato di un'epidemia può essere pari a quello di un terremoto; ma, nell'epidemia, gli uomini sono "testimoni" del massiccio progresso della morte che ha luogo sotto i loro occhi. Essi si trovano nella condizione di partecipanti a una battaglia che dura più a lungo di tutte le battaglie conosciute. Il nemico però è nascosto, sempre invisibile; non lo si può colpire. Ci si può aspettare soltanto di esserne colpiti. La battaglia è diretta unicamente dalla schiera avversaria, la quale colpisce chi vuole e colpisce con tale frequenza che si deve ben presto temere d'essere tutti sopraffatti.
Nell'istante in cui è stata riconosciuta, l'epidemia non può sfociare altro che nella morte collettiva, di tutti. Coloro che ne vengono aggrediti attendono - poiché non vi sono mezzi di difesa - l'esecuzione della sentenza pendente su di essi. Solo gli aggrediti dall'epidemia sono "massa": essi sono "uguali" in rapporto al destino che li attende. Il loro numero cresce con celerità sempre maggiore. La meta verso cui procedono è raggiunta in pochi giorni. Essi finiscono nella maggiore densità possibile a corpi umani, tutti insieme in un mucchio di cadaveri. Secondo le concezioni religiose, tale massa stagnante di morti costituisce qualcosa di solo provvisoriamente morto. In un unico istante essi risorgeranno tutti, e schierati fittamente l'uno a fianco all'altro dinanzi a Dio assumeranno il loro aspetto finale. Ma anche se si considera nella prospettiva più lunga il destino dei morti - e a questo proposito non tutte le fedi religiose propongono le medesime immagini -, una cosa resta indubbia: l'epidemia sfocia nella massa degli agonizzanti e dei morti. «Strade e templi» ne sono pieni. Spesso non si riesce più a seppellire le singole vittime come loro spetta; vengono gettate l'una sull'altra in enormi fosse comuni, mille in una stessa tomba. Tre fenomeni importanti e ben noti all'umanità hanno come conclusione dei mucchi di cadaveri. Assai affini tra loro, devono essere accuratamente distinti l'uno dall'altro. Sono la battaglia, il suicidio di massa, e l'epidemia.
Nella "battaglia" l'obiettivo è costituito dal mucchio di cadaveri dei nemici. Si vuole ridurre il numero dei nemici vivi, affinché il numero dei propri compagni sia al confronto più grande. Il fatto che anche i propri compagni muoiano è inevitabile, ma non è ciò che ci si augura. L'obiettivo è il mucchio di nemici morti. Lo si provoca attivamente, mediante la propria iniziativa, la forza del proprio braccio.
Nel "suicidio di massa" tale attività si svolge contro la stessa propria gente. Uomini, donne, bambini, tutti reciprocamente si uccidono finché non rimane più altro che il mucchio dei propri morti. Affinché nessuno cada nelle mani del nemico, affinché la distruzione sia completa, si ricorre al fuoco.
Nell""epidemia" si ha il medesimo risultato, il quale però non è deliberato (come nel suicidio di massa) e pare imposto dall'esterno da un potere sconosciuto Passa molto tempo prima che l'esito ultimo sia raggiunto, e quindi si vive tutti in un'eguale, terribile attesa, durante la quale si sciolgono i consueti vincoli degli uomini.
Il contagio, che nell'epidemia ha tanta importanza, fa sì che gli uomini si isolino gli uni dagli altri. Il miglior modo di difendersi consiste nel non avvicinare alcuno: chiunque potrebbe già portare in sé il contagio. Alcuni fuggono dalla città e si disperdono nei loro possedimenti. Altri si chiudono in casa e non lasciano entrare nessuno. Ciascuno schiva gli altri. Tenere gli altri a distanza è l'ultima speranza. La prospettiva di vivere, la vita stessa, si esprimono per così dire nella distanza dagli ammalati. Gli appestati formano gradualmente una massa di morti sani si tengono lontani da chiunque, spesso anche dai loro più stretti congiunti, dai genitori, dagli sposi, dai figli. E" degno di nota come la speranza di sopravvivere isoli ciascun uomo: dinanzi a lui sta la massa di tutte le vittime.
Ma nell'ambito di tale condanna generale, in cui chi viene colpito dalla malattia è perduto, accade il massimo dei prodigi: ci sono poche, contate persone che guariscono dalla peste. Si può immaginare come
esse si sentano in mezzo agli altri. Esse sono sopravvissute e si sentono "invulnerabili". Possono dunque anche provare compassione per i malati e i moribondi che le circondano. «Tali persone» scrive Tucidide «si sentivano così privilegiate dalla loro guarigione da credere che anche in futuro non sarebbero più potute morire di malattia».
Giacomo Leopardi
Lettere A Monaldo, Carissimo Signor Padre

Mio caro Papà. Non replicai alla carissima sua di Marzo, perché vergognandomi io stesso delle mie lunghe tardanze (benché Dio sappia quanto innocente) era risoluto di non iscriverle se non già partito o sul punto di partire per Recanati. Ma triste necessità, delle quali non potrò mai informarla senza scrivere un volume intero, mi hanno trattenuto di giorno in giorno fino alla più trista di tutte, ch’è il cholèra, scoppiato prima, com’Ella saprà, nelle provincie del Regno, e poi nella capitale. Non leggendo io i giornali, i miei amici mi avevano tenuto diligentemenente celato il cholèra di Ancona. Se lo avessi saputo, credo che nessuna forza avrebbe potuto impedirmi di non venire, anche a piedi, a dividere il loro pericolo. Ora per le notizie che ho potuto raccogliere, mi pare che coteste parti sieno libere, sebbene io non sono tranquillo né anche sopra di ciò; ma qui nessuno pensa più all’estero, stante la confusione che produce il cholèra in una città così immensa e popolosa come Napoli.
Io fortunatamente aveva potuto prima dello scoppio ritirarmi in campagna, dove vivo in un’aria eccellente, e in buona
Mi è stato di gran consolazione vedere che la peste, chiamata per la gentilezza del secolo cholèra, ha fatto poca impressione costì. Qui, lasciando il rimanente della triste storia, che gli occhi non mi consentono di narrare, dopo più di 50 giorni (dico a Napoli) la malattia pareva quasi cessata; ma in questi ultimi giorni la mortalità è rialzata di nuovo. Io ho notabilmente sofferto nella salute dall’umidità di questo casino nella cattiva stagione; né posso tornare a Napoli, perché chiunque v’arriva dopo una lunga assenza, è immancabilmente vittima della peste; la quale del rimanente ha guadagnato anche la campagna, e nelle mie vicinanze ne sono morte più persone.
…
Intanto le comunicazioni col nostro Stato non sono riaperte; e fino a questi ultimi giorni ho saputo dalla Nunziatura che nessuna probabilità v’era che si riaprissero per ora. Ed è cosa naturale; perché il cholèra oltre che è attualmente in vigore in più altre parti del regno, non è mai cessato neppure a Napoli, essendovi ogni giorno, o quasi ogni giorno, de’ casi, che il governo cerca di nascondere. Anzi in questi ultimi giorni tali casi paiono moltiplicati, e più e più medici predicono il ritorno del contagio in primavera o in estate, ritorno che anche a me pare assai naturale, perché la malattia non ha avuto lo sfogo ordinario, forse a causa della stagione fredda.
Questo incomodissimo impedimento paralizza qualunque mia risoluzione, e di più mi mette nella dura ma necessarissima necessità di fermar la casa qui per un anno:
….
Ma la difficoltà principale è quella del cholèra, ricominciato qui, come si era previsto, ai 13 di aprile, e d’allora in qua cresciuto sempre, benché il governo si sforzi di tenerlo celato. Si teme qui che all’esempio di Marsiglia il secondo cholèra sia superiore al primo, il quale anche in Marsiglia cominciò in ottobre, e fatta piccola strage ritornò in aprile. Qui il secondo cholèra dovrebb’essere doppio del primo, perché la malattia avesse da Napoli il contingente proporzionato alla popolazione. Le comunicazioni furono aperte per due o tre giorni verso il 20 di aprile; ma risaputosi il ritorno del contagio, i rigori sono raddoppiati.
…. Finalmente il partire a cholèra avanzato si disapprova da tutti i periti, essendosi conosciuto per esperienza di tutti i paesi che il cambiamento dell’aria sviluppa la malattia negli individui, e non essendo pochi gli esempi di quelli che partiti sani da un luogo infetto sono morti di cholèra arrivando tra le braccia dei loro parenti in un luogo sano.
Se scamperò dal cholèra e subito che la mia salute lo permetterà, io farò ogni possibile per rivederla in qualunque stagione, perché ancor io mi do fretta, persuaso oramai dai fatti di quello che sempre ho preveduto che il termine prescritto da Dio alla mia vita non sia molto lontano. I miei patimenti fisici giornalieri e incurabili sono arrivati con l’età ad un grado tale che non possono più crescere: spero che superata finalmente la piccola resistenza che oppone loro il moribondo mio corpo, mi condurranno all’eterno riposo che invoco caldamente ogni giorno non per eroismo, ma per il rigore delle pene che provo.
Jack London
La peste Scarlatta

«Sembrava una cosa grave, ma noi in California, come in ogni altro posto, non ci allarmammo. Eravamo convinti che i batteriologi avrebbero trovato il modo di sconfiggere questo nuovo germe, come avevano già fatto in passato con altri germi. Destava invece qualche timore la stupefacente rapidità del germe nel distruggere gli esseri umani e il fatto che una volta penetrato in un corpo umano lo uccidesse senza scampo. Nessuno era mai guarito. Con la vecchia epidemia di colera asiatico poteva capitarti di cenare con una persona in buona salute e il mattino dopo, se ti alzavi presto, di vederla sfilare sotto la finestra a bordo di un carro funebre. Ma questa nuova peste era ancora più rapida... molto più rapida. La morte sopraggiungeva entro un’ora dai primi sintomi. C’era chi resisteva alcune ore. Molti morivano nel giro di dieci o quindici minuti dalla comparsa dei primi sintomi. «Il cuore accelerava i battiti e la temperatura corporea saliva. Poi l’eruzione cutanea scarlatta si diffondeva in un baleno sul viso e sul corpo. I più non si accorgevano nemmeno dell’aumento di temperatura e dei battiti cardiaci e la prima cosa che notavano era l’eruzione scarlatta. Di solito, al momento della comparsa dell’eruzione avevano le convulsioni. Ma queste non duravano a lungo e non erano molto violente. In chi superava quella fase, subentrava una grande calma e solo allora la persona avvertiva un torpore che dai piedi risaliva velocemente il corpo. Il torpore attaccava prima i calcagni, poi le gambe e i fianchi, e quando arrivava all’altezza del cuore la persona moriva. Non piombava nel sonno o nel delirio. La mente conservava la calma e la lucidità fino al momento in cui il cuore intorpidito si arrestava. E un’altra stranezza era la rapidità della decomposizione. Non facevano in tempo a morire che subito il corpo sembrava andare in pezzi, sbriciolarsi, dissolversi sotto i tuoi occhi. Questa fu una delle ragioni della rapidità con cui il contagio si diffuse. Tutti i miliardi di germi di un cadavere venivano così liberati all’istante.
«E questo rendeva quasi impossibile combattere i germi ai batteriologi, che perivano nei laboratori mentre studiavano il germe della Morte Scarlatta. Erano degli eroi. Come ne moriva uno, un altro si faceva avanti per sostituirlo. Isolarono per primi il germe a Londra. La notizia fu telegrafata ovunque. L’uomo che aveva portato a termine l’impresa si chiamava Trask, ma nel giro di trenta ore era morto. Poi tutti i laboratori si impegnarono nella ricerca di qualcosa che uccidesse i germi della peste. Non si trovava un farmaco adatto. Il problema, vedete, era trovare un farmaco, o siero, che uccidesse i germi presenti nel corpo senza uccidere il corpo. Cercarono di combatterlo con altri germi, di iniettare nel corpo di un malato germi nemici dei germi della peste...». …
….
«New York e Chicago erano in preda al caos. E quanto era successo lì succedeva in tutte le grandi città. Un terzo dei poliziotti newyorkesi erano morti. Morto il capo della polizia, come pure il sindaco. Scomparsi l’ordine e la legalità. I cadaveri restavano senza sepoltura, abbandonati per la strada. I rifornimenti ferroviari e marittimi di viveri e degli altri generi di prima necessità non raggiungevano più i grandi centri urbani e bande di poveri affamati si erano messe a saccheggiare magazzini e depositi. Imperavano l’assassinio, la rapina e l’ubriachezza. La popolazione era già fuggita in fretta e furia dalla città... per primi i ricchi, a bordo delle loro automobili e dei loro dirigibili, seguiti dalle masse appiedate e affamate, portandosi dietro la peste, saccheggiando lungo il tragitto le fattorie e i villaggi, ogni centro abitato.
…. «Quelle aeromobili erano fuggite a centinaia alla volta delle Hawaii e non solo si erano portate dietro la peste, ma avevano trovato la peste già insediata sul posto. Questo lo venimmo a sapere dai dispacci finché, con la scomparsa di ogni traccia d’ordine a San Francisco, non rimasero più centralinisti per ricevere e inviare messaggi. La mancanza di comunicazione con il resto del mondo destava stupore, sgomento. Sembrava proprio che il mondo fosse finito, cancellato. Da sessant’anni il mondo ha cessato di esistere per me. So che devono esserci posti come New York, l’Europa, l’Asia e l’Africa; ma non se ne hanno più notizie... da sessant’anni. Con l’arrivo della Morte Scarlatta il mondo è andato in pezzi, nel modo più assoluto e irrimediabile. Diecimila anni di cultura e civiltà svaniti in un batter d’occhio, “fugaci come schiuma”.

Tutto andò bene, o quasi, fino a quel giorno in cui accadde l’inverosimile. Fu come se l’inverno avesse cessato all’improvviso di essere inverno. Aveva semplicemente deciso di non esserlo più. Con terrore gli abitanti del distretto, una settimana appena passato il Natale, udirono il ghiaccio schiantarsi sulla Struminka. Secondo un’antica leggenda, che circolava da quelle parti, quegli schianti significavano che una grande sciagura sarebbe avvenuta nella prossima estate. Tutti erano molto spaventati e andavano in giro con la faccia buia.
Ma avevano ragione. La vecchia leggenda aveva ragione. Infatti, alcuni giorni dopo quegli schianti, una terribile malattia cominciò a infierire nella città, una malattia che di solito fa la sua comparsa soltanto nelle estati calde: il colera.
Il disgelo era dappertutto, si sarebbe detto che la primavera fosse già arrivata. Di notte pioveva. Una pioggia dolce, regolare, che pareva una consolazione del cielo. Ma era una falsa consolazione. In gran fretta, dopo appena tre giorni di malattia, la gente se ne andava all’altro mondo. I medici dicevano che era colera, ma gli abitanti della zona sostenevano che era la peste. Ma non importa quale fosse la malattia, la gente comunque moriva.
Poiché quella morìa non sembrava arrestarsi, il Governatorato cominciò a mandare medici e medicamenti nel distretto di Zlotogrod.
Tuttavia, furono in molti a dire che medici e medicamenti avrebbero fatto solo del male e che le disposizioni del Governatorato erano ancora peggio della peste. Il mezzo migliore – dicevano – per salvarsi la vita era l’alcol. Così la gente si buttò a bere. Molte persone venivano a Szvaby, all’Osteria della Frontiera, gente che prima non si era mai vista.
Anche il verificatore Eibenschütz prese a bere smodatamente, e non tanto perché temesse la malattia e la morte, ma perché quella smania di bere così diffusa arrivava quanto mai opportuna per lui. Non gli importava nulla di sfuggire all’epidemia, bensì al proprio dolore. L’epidemia, si sarebbe potuto dire, era addirittura la benvenuta. Gli offriva la possibilità di mitigare la propria pena, che gli sembrava enorme, più di qualsiasi contagio. In fondo, sospirava la morte. L’idea di poter essere una delle numerose vittime del colera gli sorrideva, gli era persino cara. Ma come si può aspettare la morte senza stordirsi, quando non si sa se verrà veramente?
Così il verificatore Eibenschütz beveva.
Tutti quelli che restavano in vita si davano all’alcol, senza parlare poi dei disertori. Il colera aveva già portato via tre dei creditori di Jadlovker e soltanto il piccolo Kapturak, l’indistruttibile Kapturak, era rimasto. Anche lui beveva, ma il suo viso giallo e sgualcito non diventava rosso per questo, niente gli poteva nuocere, né i bacilli né l’alcol.
Non tutti morivano, si capisce, ma molti erano a letto malati.
All’Osteria della Frontiera, ormai giocavano a carte soltanto il verificatore, il brigadiere Slama, il furfante Kapturak e il caldarrostaio Sameškin. Quest’ultimo, poi, non lo si poteva più chiamare così perché ormai, di castagne, quasi non ne vendeva. Era forse possibile vendere castagne in una zona in cui regnava il colera? E quale colera!
La gente moriva come mosche. Si dice così ma, in realtà, le mosche muoiono spesso più lentamente degli uomini. In un periodo compreso fra tre e otto giorni, secondo i casi, le persone prendevano un colorito bluastro. La lingua penzolava dalle loro bocche aperte. Tiravano ancora un paio di volte il fiato, ed erano già bell’e andate. A che cosa servivano i dottori e le medicine mandati dal Governatorato? Un giorno venne l’ordine dall’autorità militare che il 35° reggimento lasciasse immediatamente il distretto di Zlotogrod, e questo causò uno spavento ancora più grande. Fino a quel momento, infatti, quella povera gente aveva creduto che la morte passasse quasi incidentalmente dalle loro case e dalle loro capanne. Ma, ora, il trasferimento della guarnigione significava che lo Stato stesso sanzionava il fatto che la «peste», come loro la chiamavano, fosse cosa di lunga durata. L’inverno, poi, non voleva proprio ricominciare. Si sospirava il gelo, altrimenti così temuto. Ma il gelo non veniva, la neve nemmeno, tutt’al più grandinava e soprattutto pioveva. E la morte si aggirava, falciando e strangolando.
Un giorno accadde qualcosa di molto strano. Per un paio d’ore venne giù una pioggia di colore rosso, una pioggia di sangue, diceva la gente. Era una specie di finissima sabbia rossastra che si depositò sulle strade, alta qualche centimetro, e cadde giù dai tetti. Era come se i tetti sanguinassero.
La gente si spaventò ancora di più che per il trasferimento della guarnigione. E sebbene il Governatorato mandasse a Zlotogrod anche una commissione, e questi dotti signori spiegassero nella sala del comune come, per un particolare fenomeno ben noto alla scienza, la pioggia di sangue non era che una sabbia rossa venuta dal lontano deserto, ciò nonostante il cuore della gente rimase terrorizzato. E si moriva ancora più in fretta e repentinamente di prima. Tutti pensavano che fosse venuta la fine del mondo; e chi poteva avere ancora voglia di vivere?
Il colera si propagò con la rapidità di un incendio, da una capanna all’altra, da un paese al villaggio vicino, da questo a un altro paese. Immuni rimasero soltanto i casolari isolati e il castello del conte Chojnicki.
Immune rimase anche l’Osteria della Frontiera, nonostante tutta la gente che andava e veniva. Pareva che i bacilli morissero subito nei vapori dell’alcol che avvolgevano la sala
…Fu sempre peggio. Ormai si era già al principio di febbraio e l’epidemia non cessava. Tre necrofori morirono. Gli inservienti del comune si rifiutavano di andare nelle case dove c’era un morto. Arrivarono istruzioni dal Governatorato affinché s’impiegassero i detenuti come necrofori.
Dal grosso carcere di Zloczov i detenuti furono portati nel distretto di Zlotogrod. Vennero legati insieme a gruppi di sei, con lunghe catene, e, tintinnando e sferragliando, salirono sul treno accompagnati da gendarmi con la baionetta inastata.
Furono distribuiti nell’intero distretto, sei in ciascun paese e dodici nella cittadina di Zlotogrod. Li vestirono con mantelli speciali forniti di cappuccio, il tutto trattato con il cloroformio. In quelle palandrane giallognole, che facevano molta paura, e con l’accompagnamento delle catene sferraglianti, essi entravano, sorvegliati dai gendarmi, nelle case e nelle capanne, trasportavano fuori, sempre sferragliando, le bare e le caricavano sui grossi carri a rastrelliera del comune. Dormivano per terra nello stanzone del corpo di guardia della gendarmeria.
Ad alcuni di loro riuscì di ammalarsi di colera. Finirono all’ospedale, quasi che fossero davvero malati, il che in realtà non era. Ad alcuni riuscì persino, apparentemente, di morire. Succedeva infatti che Kapturak inducesse gli scrivani comunali a registrare come morti alcuni che erano vivissimi. Fra tutti i detenuti uno soltanto morì veramente, un vecchio che era già sempre malato. I più furbi scapparono, tutti gli altri sopravvissero, come se le catene e l’ansia di libertà li mettessero più al sicuro dal contagio di tutte le misure precauzionali del medico distrettuale dottor Kiniover. Anche i disertori provenienti dalla Russia non s’infettarono. Che cosa potevano mai, bacilli così minuscoli, contro quella loro ansia tanto grande di libertà?
….
Il ventuno febbraio, esattamente, venne all’improvviso un gran freddo e tutti lo salutarono con gioia.
Il nostro amato e crudele Signore manda colera e freddo a suo piacimento. Dopo il colera, tutti salutarono contenti il freddo.
Nello spazio di una notte la Struminka gelò. La pioggia smise di colpo. Il fango in mezzo alla strada si fece duro e secco come vetro, un torbido vetro grigio, e in un cielo di puro cristallo il sole brillò luminoso, anche se molto distante. Sui marciapiedi di legno ghiacciarono gli stillicidi, ultimi resti della pioggia, e la gente, per non scivolare, vi camminava sopra con i bastoni dal puntale di ferro. Soffiava un vento gelato, non da nord o da sud, non da est o da ovest, ma da una direzione che nessuno conosceva. Veniva piuttosto dal cielo. Soffiava dall’alto, come dall’alto cade la pioggia o la neve.
Nello spazio di una notte anche il colera scomparve. I malati risanarono e nessun sano si ammalò più. Si dimenticarono i morti – come sempre si dimenticano. Si seppellirono. Si piansero. Alla fine si dimenticarono.
Alexandr Puskin
Festino in tempo di peste
C'era un tempo in cui il paese, nella pace prosperava:
le domeniche la chiesa,
di fedeli si riempiva;
voci allegre di bambini
risuonavan nelle scuole
e nei campi sotto il sole
balenavano le falci.
Ora la chiesa è vuota;
la scuola muta, è chiusa;
fermo è il raccolto;
deserto è il fitto bosco;
ed il villaggio sembra
un luogo dall'incendio visitato.
Silenzio ovunque - solo il cimitero si riempie e non tace.
Portano altri morti
e i vivi con timidi
lamenti, a Dio chiedono
per loro, pace eterna.
Serve altro spazio,
e le bare, pressate l'una
accanto all'altra,
come un gregge spaventato,
restano in attesa.
Se una morte prematura
mi tocca in sorte, io,
che ti ho tanto amato
e il cui amore, felice
m'ha reso, io ti prego:
non avvicinarti al corpo
della tua Jenny, non sfiorare le sue labbra spente,
seguila da lontano.
Lascia il villaggio!
e vai là dove tu possa
lenire il tuo tormento
e riposare.

Ciò che più sgomentava in un tale flagello
era il fatto che ognuno, scopertosi il male,
e convinto di essere condannato a morire
cadeva in stato di inerzia, col cuore dolente
ed il pensiero rivolto alla fine vicina,
e solo per questo giaceva in preda alia morte.
Molti così perivano nel contagio continuo
come branchi di pecore o mandrie di bovini
e ogni giorno cresceva l’elenco dei morti.
Chi non si era prestato a curare i malati
era presto punito dal suo stesso egoismo
ritrovandosi solo, ammalato e morente
nell’altrui indifferenza, abbandonato da tutti:
ma anche chi si curava dei propri parenti
soccombeva alla fine al contagio e allo sforzo
di alleviare il dolore a coloro che amava.
Anche loro morivano, questi uomini migliori.
che s’erano sforzati di onorare i parenti
e poi, stanchi di piangere, ritornavano a casa
dove ben presto il male li avrebbe colpiti.
Non c’era più nessuno che non fosse coinvolto
per qualche lutto in famiglia o per esser malato.
Contadini robusti o guardiani di armenti,
guidatori di aratri dal vomere bene incurvato
si ammalavano anch’essi, nelle loro campagne
e restavano immoti ad aspettare la morte.
Spesso apparivano stesi sui corpi dei bambini
quelli dei genitori, e talvolta accadeva
che un bambino morisse sotto il padre e la madre.
Questo morbo letale era giunto ad Atene
dalle campagne d’intorno e i contadini correvano
volgendosi alla città, come per occuparla:
si affollavano tutti e più facilmente il male,
trovandoli così indifesi, arrivava a colpirli:
Alcuni per la gran sete stavano in mezzo alla strada
stesi sui fontanili o riversi nell’acqua
soffocati da quanto avevano bevuto:
li si vedeva dovunque, nelle vie e sulle piazze,
quasi sempre morenti, con i corpi imbrattati
muti, coperti di stracci in mezzo alle loro lordure:
avevano solo ossa e pelle, e questa era sempre coperta
da bubboni nerastri sbucanti dalla sporcizia.
Molti edifici sacri consacrati agli dèi
ospitavano i morti: sotto quei colonnati
una volta affollati di tanti ospiti illustri
s’ammassavano i corpi che i parenti portavano:
ma nessuno pensava di implorare gli dèi
o potenze divine: c’era soltanto il dolore.
Nessuno più si occupava di svolgere i riti
che si compiono sempre per i propri defunti
ma ciascuno, impaurito, pur con grande dolore
seppelliva i suoi morti come meglio poteva:
per questo accadevano spesso violenze sgradevoli
e si vide la gente che sulle pire degli altri,
cercava di andare a deporre il corpo di un proprio caro:
per riuscirci lottavano agitando le torce
come a voler difendere ciascuno qualche cosa di proprio.
VII. Havvi, cosa strana a dirsi, un disprezzo della morte e un coraggio più abbietto e più disprezzabile che la paura: ed è quello de’ negozianti ed altri uomini dediti a far danari, che spessissime volte, per guadagni anche minimi, e per sordidi risparmi, ostinatamente ricusano cautele e provvidenze necessarie alla loro conservazione, e si mettono a pericoli estremi, dove non di rado, eroi vili, periscono con morte vituperata. Di quest’obbrobrioso coraggio si sono veduti esempi insigni, non senza seguirne danni e stragi de’ popoli innocenti, nell’occasione della peste, chiamata più volentieri cholera morbus, che ha flagellata la specie umana in questi ultimi anni.

Una peste tremenda, inflitta dall'ira di Giunone per l'astio
che un luogo portasse il nome della rivale, si abbatté sul popolo.
Finché parve un male naturale e oscura ci fu la causa
che provocava quell'immane strage, si lottò con l'arte medica;
ma il flagello prevalse su ogni cura, svilita dall'impotenza.
All'inizio una caligine densa calò sulla terra
dal cielo, che in quella cappa di nubi concentrò un'afa spossante,
e per tutto il tempo che la luna impiegò a colmare quattro volte
il suo disco congiungendo le corna, e decrescendo ad intaccarlo,
con le sue folate mortali soffiò un Austro soffocante.
Sappiamo che il contagio si propagò anche a fonti e laghi,
e che migliaia di serpenti, errando per i campi desolati,
contaminarono l'acqua dei fiumi coi loro veleni.
Fu con una strage di cani, uccelli, pecore, buoi e animali
selvatici che all'improvviso il morbo mostrò la propria violenza.
Con sgomento, durante l'aratura, il contadino per disgrazia
vede stramazzare e accasciarsi tra i solchi i tori più forti.
Alle greggi di pecore, che emettono lamentosi belati,
la lana cade da sola e i corpi si riempiono di piaghe.
Il cavallo, un tempo famoso per il suo ardore nell'arena,
si fa indegno di vittoria e, dimentico degli onori trascorsi,
geme nella sua stalla in attesa di una morte ingloriosa.Il cinghiale non pensa più ad infuriarsi, la cerva a cercare scampo nella fuga, gli orsi ad aggredire lo stuolo degli armenti.
Tutto languisce: nei boschi, sui campi, per le strade
giacciono corpi in sfacelo; da miasmi fetidi è appestata l'aria.
Ed è incredibile, neppure i cani, neppure gli uccelli ingordi
o i lupi grigi toccano quei corpi in decomposizione,
che con le loro esalazioni infette estendono l'epidemia.
Poi, con effetti ancor più gravi e infami, la peste giunge a colpire
i contadini e a imperversare fin tra le mura della città.
Prima s'infiammano i visceri, e sintomo della fiamma che cova
è un rossore della pelle e l'affanno febbrile dell'alito;
la lingua si fa gonfia e rugosa, la bocca inaridita
si spalanca all'afa del vento e in gola entra quell'aria malsana.
Non si tollera giaciglio, né veste quale sia;
ci si stende col ventre indolenzito sulla terra, e non è il suolo
a rinfrescare il corpo, ma il corpo ad arroventare quello.
Non c'è chi possa mitigare il male: il flagello scoppia spietato
anche fra i medici, che rimangono vittime dell'arte loro.
Chi è più a contatto col malato e con più tenacia l'assiste,
più in fretta cade in braccio alla morte. Svanita ogni speranza
di guarire, accertato che l'esito del morbo sarà la morte,
la gente si abbandona ai propri istinti, trascurando ciò che giova:
tanto, nulla può giovare. Lasciato ogni ritegno, gli uni e gli altri
si attaccano alle fonti, ai fiumi, ai pozzi più capaci, e a furia di bere, la sete non si estingue che con la loro vita.
Così molti, non riuscendo ad alzarsi per il peso,
muoiono annegati: eppure c'è chi continua a bere!
Tanto insopportabile, fastidioso è il letto per quegli infelici,
che ne balzano fuori o, se non hanno la forza d'alzarsi,
si rotolano giù per terra, e tutti fuggono, fuggono via
di casa. A ognuno la propria dimora sembra foriera di lutti,
ed essendo ignota la causa, s'incrimina l'angustia del luogo.
Avresti potuto vedere delle larve errare per le strade,
finché si reggevano in piedi, ed altri piangere distesi a terra
e stralunare gli occhi stanchi, con un estremo sussulto:
tendevano le braccia verso gli astri del cielo opprimente,
esalando l'anima là dov'erano sorpresi dalla morte.
Quale emozione provai allora? E quale avrebbe dovuta essere,
se non l'odio per la vita e l'ansia di spartire la sorte loro?
Ovunque si volgessero gli occhi, c'erano a terra
corpi inanimati, come mele marce cadute
quando si agitano i rami, o ghiande quando si scuote il leccio.
Vedi, là di fronte, in cima a quella lunga scalinata, quel tempio?
È dedicato a Giove. Chi, senza averne riscontro, non ha offerto
incenso a quegli altari? Quante volte avvenne
che raccolto in preghiera, un uomo per la moglie, un padre
per il figlio, spirasse davanti a quegli altari impassibili
e gli si trovasse in mano un po' d'incenso ancora da ardere! Quante volte avvenne che, mentre il sacerdote pronunciava
la formula di rito, spruzzando vino in mezzo alle corna, i tori
condotti al tempio stramazzassero senza attendere il colpo!
Io stesso stavo sacrificando a Giove per me, per la mia patria
e i miei tre figli, quando la vittima emise un tremendo muggito
e si accasciò all'improvviso senza essere colpita, macchiando
appena il coltello alla gola con qualche goccia di sangue.
Anche i tessuti infetti avevano perso le tracce che rivelano
la volontà degli dei: nelle viscere s'era infiltrato il morbo.
Ho visto cadaveri abbandonati davanti alle porte sacre;
proprio davanti agli altari, a rendere più odiosa ancora la morte,
v'è chi con un cappio tronca la sua vita e, scacciando con la morte
il terrore di morire, affretta una fine che incombe spietata.
I corpi dei defunti non sono inumati con le esequie
di rito: troppo anguste sono le porte di città per quel numero; o insepolti giacciono al suolo o senza onori vengono gettati
in cima ai roghi. Ormai non c'è rispetto che valga: la gente
si azzuffa per un rogo e brucia i propri morti tra le fiamme altrui.
Non c'è chi pianga; senza un conforto vagano le ombre
di padri e figli, di giovani e vecchi: non c'è spazio
per i sepolcri e sufficiente non è la legna per fare fuoco.
Sconvolto da un cumulo così immenso di calamità:
"O Giove," gridai, "se non si tramanda il falso
quando si dice che a Egina, la figlia di Asopo, ti sei unito,
se tu, padre degli dei, non ti vergogni d'essermi genitore,
restituiscimi i miei o spedisci anche me nella tomba!".
E lui con un lampo ed un tuono mi diede un segno di assenso.
"Ti sono debitore," dissi allora, "e m'auguro che ciò significhi
la tua benevolenza. Questi presagi li considero un pegno".
Per caso lì vicino, rarissima per la vastità dei rami,
c'era una quercia della specie di Dodona, consacrata a Giove.Qui noi scorgemmo una fila di formiche in cerca di semi,
che portavano grandi fardelli con la bocca minuta
e seguivano un loro sentiero fra le rughe della corteccia.
Sbalordito dal loro numero: "Tu che sei il migliore dei padri,"
dissi, "colma il vuoto delle mura e dammi altrettanti cittadini".
L'alta quercia fremette e i suoi rami stormirono senza che un alito
di vento li muovesse. Un brivido di spavento percorse
le mie membra e mi si rizzarono i capelli; baciai tuttavia
la terra e la pianta, senza confessare la mia speranza,
ma speravo, accarezzando in cuore i miei voti.
Scende la notte e il sonno invade il corpo sfinito da tanti assilli.
Davanti agli occhi mi appare la stessa quercia,
con altrettanti rami e altrettanti insetti sui rami,
che sembra fremere e agitarsi come prima, facendo cadere
sul campo ai suoi piedi uno stuolo di formiche, e che d'un tratto
queste crescano, diventando man mano sempre più grandi,
e si alzino da terra, rizzandosi in piedi a busto eretto,
e che perdano l'esilità, gran parte delle zampe e il colore
che hanno nero, per assumere nelle membra aspetto umano.Svanisce il sonno: desto, faccio un fascio delle mie visioni,
lamentando che gli dei non m'aiutino. Ma nella reggia
c'era un grande brusio e mi sembra d'udire voci umane
ormai a me desuete. Mentre mi chiedo se anche queste
non siano un sogno, ecco che Telamone in corsa spalanca le porte
e grida: "Padre, vedrai cose che superano speranza e fede!
Vieni fuori!". Esco, e come mi è parso di vederli in sogno,
tali e quali ora vedo esseri umani in fila, e li riconosco
mentre si fanno avanti a salutare il loro re.
Sciolgo i miei voti a Giove, divido la città e i campi,
lasciati dai contadini scomparsi, fra questi uomini nuovi,
e li chiamo Mirmìdoni, perché il nome ne ricordi l'origine.
L'aspetto fisico l'hai visto; il carattere è sempre quello
che avevano prima: una stirpe parca, resistente alle fatiche,
che con tenacia accumula e mette da parte ciò che accumula.
Saranno questi, tutti uguali per età e per coraggio a seguirti
in guerra, quando l'Euro, che senza affanni qui t'ha condotto,»
(con l'Euro era infatti arrivato) «si sarà mutato in Austro».
Gabriel Garcia Marquez
Cent’anni di solitudine

Una notte, verso l’epoca in cui Rebeca guarì dal vizio di mangiare terra e fu portata a dormire nella stanza degli altri bambini, l’india che dormiva con loro si svegliò per caso e sentì uno strano rumore intermittente in un angolo. Si alzò a sedere spaventata, credendo che fosse entrato un animale nella stanza, e allora vide Rebeca nella poltroncina a dondolo, col dito in bocca e con gli occhi illuminati come quelli di un gatto nel buio. Paralizzata dal terrore, afflitta dalla fatalità de suo destino, Visitación riconobbe in quegli occhi i sintomi della malattia la cui minaccia li aveva costretti, lei e suo fratello, esuli per sempre da un regno millenario del quale essi erano i principi. Era la peste dell’insonnia.
Cataure, l’indio, non attese l’alba per andarsene. Suo sorella rimase, perché il suo cuore fatalista le suggeriva che la malattia letale l’avrebbe inseguita in ogni modo fin nell’ultimo angolo della terra. Nessuno capì la trepidazione di Visitación. “Se non dormiremo, tanto meglio,” diceva José Arcadio Buendìa, di buon umore. “Così, la vita ci renderà di più.” Ma l’india spiegò loro che la cosa più temibile della malattia dell’insonnia non era l’impossibilità di dormire, dato che il corpo non provava alcuna fatica, bensì la sua inesorabile evoluzione verso una manifestazione più critica: la perdita della memoria. Significava che quando il malato si abituava al suo stato di veglia, cominciavano a cancellarsi dalla sua memoria i ricordi dell’infanzia, poi il nome e la nozione delle cose, e infine l’identità delle persone e perfino la coscienza del proprio essere, fino a sommergersi in una specie di idiozia senza passato. José Arcadio Buendìa, sbellicandosi dalle risa, ritenne che doveva trattarsi di una delle tante malattie inventate dalla superstizione degli indigeni. Ma Ursula, in ogni modo, prese la precauzione di separare Rebeca dagli altri bambini.
Dopo parecchie settimane, quando il terrore di Visitación sembrava acquietato, José Arcadio Buendìa si sorprese una notte a rivoltarsi nel letto senza poter dormire. Ursula, che era anche lei sveglia, gli chiese che cosa avesse, e lui le rispose: “Sto ripensando a Prudencio Aguilar.” Non dormirono n minuto, ma il giorno dopo si sentivano così riposati che si dimenticarono della nottataccia. Aureliano commentò stupito all’ora di colazione che si sentiva benissimo nonostante avesse trascorso tutta la notte nel laboratorio a dorare un fermaglio che aveva intenzione di regalare a Ursula il giorno del suo compleanno. Non cominciarono ad allarmarsi se non il terzo giorno, quando all’ora di coricarsi si sentirono senza sonno e si resero conto che ormai non dormivano da oltre cinquanta ore.
“Anche i bambini sono svegli,” disse l’india con la sua convinzione fatalista. “Una volta che entra in casa, nessuno sfugge alla peste.”
Avevano contratto, in effetti, la malattia dell’insonnia. Ursula, che aveva imparato da sua madre il valore medicinale delle piante, preparò e fece bere a tutti un beverone di aconito, ma non riuscirono a dormire, e invece rimasero a sognare svegli per tutto il giorno. In quello stato di allucinata lucidità non soltanto vedevano le immagini dei loro stessi sogni, ma vedevano perfino gli uni le immagini sognate dagli altri. Era come se la casa si fosse riempita di visitatori. Seduta nella sua poltroncina a dondolo in un angolo della cucina, Rebeca sognò che un uomo molto simile a lei, vestito di lino bianco e col collo della camicia chiuso da un bottone d’oro, le portava un mazzo di rose. Lo accompagnava una donna dalle mani delicate che staccò una rosa e la infilò nei capelli della bambina. Ursula capi che l’uomo e la donna erano i genitori di Rebeca, ma per quanto si sforzasse di riconoscerli, si confermò nella certezza di non averli mai visti. Nel frattempo, per una negligenza che José Arcadio Buendìa non si perdonò mai, si continuavano a vendere nel villaggio gli animaletti di caramello fabbricati in casa. Bambini e adulti succhiavano beatamente i deliziosi galletti verdi dell’insonnia, gli squisiti pesci rosa dell’insonnia e i teneri cavallini gialli dell’insonnia, di modo che l’alba del lunedì sorprese sveglio tutto il villaggio. Sulle prime nessuno si mise in apprensione. Al contrario, erano contenti di non dormire, perché allora c’era tanto da fare a Macondo che il tempo bastava appena. Lavorarono tanto, che ben presto non ebbero più nulla da fare, e si trovarono alle tre del mattino con le braccia incrociate, a contare il numero delle note del valzer degli orologi. Quelli che volevano dormire, non per stanchezza bensì per nostalgia dei sogni, ricorsero a ogni tipo di metodi spossanti. Si riunivano a chiacchierare senza tregua, a ripetersi per ore e ore le stesse storielle, complicando fino ai limiti della esasperazione la storia del gallo cappone, che era un gioco infinito nel quale il narratore chiedeva se volevano sentire la storia del gallo cappone, e se gli rispondevano di si, il narratore diceva che non aveva chiesto che gli dicessero di si, ma se volevano sentire la storia del gallo cappone, e se gli rispondevano di no, il narratore diceva che non aveva chiesto che gli dicessero di no, ma se volevano sentire la storia del gallo cappone, e quando non gli rispondevano nulla il narratore diceva che non aveva chiesto che non gli rispondessero nulla, ma se volevano sentire la storia del gallo cappone, e nessuno poteva andarsene, perché il narratore diceva che non aveva chiesto che se ne andassero, ma se volevano sentire la storia del gallo cappone, e così via, in un cerchio vizioso che si prolungava per notti intere.
Quando José Arcadio Buendìa si accorse che la peste aveva invaso il villaggio, riunì i capi famiglia per spiegar loro quello che sapeva sulla malattia dell’insonnia, e fu deciso di adottare delle misure per impedire che il flagello si propagasse ad altre popolazioni della palude. Fu così che si tolsero ai capri le campanelle che gli arabi barattavano coi pappagalli, e furono messe all’entrata del villaggio a disposizione di coloro che trascuravano i consigli e le suppliche delle sentinelle e insistevano nel voler visitare il villaggio. Ogni forestiero che in quell’epoca percorreva le strade di Macondo doveva far suonare la sua campa nella perché i malati sapessero che era sano. Non gli si permetteva né di mangiare né di bere nulla durante il soggiorno, perché non c’era dubbio che la malattia si trasmetteva soltanto per bocca, e tutte le cose da bere e da mangiare erano contaminate di insonnia. In quel modo si mantenne la peste circoscritta al perimetro dell’abitato. La quarantena fu così efficace, che giunse il giorno in cui lo stato di emergenza venne considerato come cosa naturale, e si organizzò la vita in modo tale che il lavoro riacquistò il suo ritmo e nessuno si preoccupò più dell’inutile abitudine di dormire.
Emile Zola
I misteri di Marsiglia

Passò sopra Marsiglia un nuovo soffio di morte. L’intiera città ne fu colpita. Non erano più poche centinaia di feriti; i morti cadevano a centinaia. Il colera era venuto dopo la guerra civile.
Sarebbe una dolorosa storia quella delle numerose e terribili epidemie che hanno desolato Marsiglia. La posizione di questa città, il suo clima caldo, i suoi continui rapporti con l’Asia, la sporcizia delle vecchie strade, sembrano averla destinata fatalmente ad essere un focolaio d’infezione dove le malattie contagiose si propagano con rapidità. Quando giunge l’estate la città è minacciata dal morbo. Se per disgrazia vi penetra per la minima negligenza il flagello, invade il litorale e si propaga in tutta la Francia.
L’epidemia del 1849 fu piuttosto benigna. Si manifestò verso la metà d’agosto. Vogliono che non fosse grave se non dopo lo sbarco di un drappello di soldati ammalati, provenienti da Roma e da Algeri. Dicono che cinquanta di quei soldati morirono la notte dopo il loro arrivo. Da quel momento il morbo imperversò su Marsiglia.
Le fazioni politiche di quel tempo rimproverarono acerbamente al governo della repubblica un decreto in data del 18 agosto, che dava il permesso alle navi provenienti dal Levante d’entrare subito in porto, purché i medici di bordo dichiarassero di non aver malati sospetti. Quel decreto sopprimeva le quarantene e apriva la città ai germi della malattia.
L’incubazione fu molto lenta. Alla fine d’agosto le vittime del morbo erano state solo centonovantasei. Ma il mese di settembre fu terribile: morirono milleduecento persone. L’epidemia cessò nell’ottobre dopo avere ucciso altre cinquecento persone.
Un folle timor panico invase gli abitanti nei primi giorni del flagello. Fuggivano tutti. La notizia del diffondersi del colera passò di quartiere in quartiere come il fuoco sopra una traccia di polvere. Un uomo era morto dopo un’atroce agonia e subito dopo le donnicciole dicevano di aver visto passare cinquanta morti. Il popolo parlava a voce bassa di veleno, accusando i ricchi di avere avvelenate tutte le fontane. Tali sospetti aumentavano il timor panico. Un povero diavolo, che beveva alla fontana del Corso, rischiò di farsi accoppare perché un operaio pretendeva di averlo veduto buttare qualche cosa nell’acqua.
La paura faceva danni incredibili in quelle ardenti immaginazioni. Pareva agli abitanti che un vento impestato soffiasse sulla città. Le donne camminavano per le strade tenendosi un fazzoletto sulla bocca. Non osando più né bere né respirare, i Marsigliesi non potevano più vivere.
La città fu abbandonata. Quanti poterono fuggire, fuggirono. Le campagne vicine erano piene di rifugiati. Alcuni andarono ad accamparsi fino sulle colline della Nerthe: preferivano il vivere all’aria aperta, il dormire sotto una tenda, al restare in una città dove s’incontrava un morto ad ogni passo. I ricchi, quelli che avevano una casa in campagna o potevano prenderla a fitto, furono i primi ad allontanarsi: poi gli impiegati, gli operai, i lavoratori, che mettevano a rischio la loro esistenza giornaliera lasciando il loro lavoro, si sentirono vili, ed un gran numero di essi preferirono fuggire ed esporsi al pericolo della fame. A poco a poco Marsiglia diventò vuota e triste.
Vi rimasero soltanto i coraggiosi che combattevano o sdegnavano l’epidemia, ed i poveri diavoli obbligati a rimanere ad onta dei brividi della paura. Se vi furono atti di viltà, e improvvise fughe di medici e di impiegati, vi furono pure atti di energia e di abnegazione. Sin da principio si aprirono posti di soccorso nei quartieri più danneggiati; e giorno e notte molti generosi si consacravano al sollievo della popolazione impaurita.
Petrarca
Epistole
All’arcivescovo di Genova Guido Sette. Come il mondo volge in peggio.
Che dire degli altri mali? Il nome di peste noi l’avevamo udito e letto sui libri; ma una peste universale venuta per render vuoto il mondo non si era né veduta né letta; ed è una peste che da vent’anni ha ormai invaso ogni paese al punto che, diminuita forse e come sospesa in qualche località, nessuno certo può dire che sia sino ad oggi cessata; tanto che ogni giorno la vediamo tornare mentre già si pensava che se ne fosse andata, assalendoci di nuovo dopo averci ingannati con una breve gioia. Documento, se non sbaglio, proprio della collera divina e dei delitti degli uomini; se mai avessero termine o ne diminuisse almeno il numero, tu vedresti mitigarsi anche i castighi del cielo.
Daniel Defoe
Diario dell'anno della peste

All’inizio dell’epidemia, quando non c’era più speranza che la City intera non venisse colpita, quando – come ho detto – tutti quelli che avevano amici o terre in campagna fuggivano con le proprie famiglie, e quando effettivamente si sarebbe potuto ritenere che l’intera City stesse uscendo di corsa dalle porte di Londra, e che non vi sarebbe rimasto nessuno, potete star certi che da quel momento ogni commercio, eccetto quello riguardante i mezzi di sussistenza, subì un arresto per così dire totale.
La circostanza è di tale interesse, e rivela in modo così preciso quali fossero le vere condizioni del popolo, che penso non si possa essere accusati di pedanteria nell’illustrarla. Passo quindi a esporre le diverse categorie della popolazione che in questa circostanza piombarono immediatamente nella miseria, come ad esempio:
Gli operai manifatturieri, soprattutto delle fabbriche di guarnizioni e di altri accessori dell’abbigliamento, di stoffe e mobilio; tessitori di nastri e altri tessitori, lavoratori di filigrane d’oro e d’argento, tessitori di fili d’oro e d’argento, sarte, modiste, calzolai, cappellai e guantai, e anche tappezzieri, falegnami, mobilieri; piombatori, e le infinite attività commerciali che si fondano su questi mestieri interruppero il lavoro, e tutti i giornalieri, tutti i lavoranti e tutti i dipendenti vennero licenziati.
Poiché il commercio era a un punto morto (ben poche navi si arrischiavano a risalire il Tamigi, e nessuna ne usciva) tutti i funzionari straordinari delle dogane, e analogamente i barcaioli, i carrettieri, i facchini, e tutta la povera gente il cui lavoro dipendeva dai mercanti, vennero licenziati in tronco e si trovarono disoccupati.
Tutti gli imprenditori a cui di solito si affidava la costruzione o la riparazione di case, erano inattivi, giacché la gente era ben lungi dal richiedere lavori di questo tipo, quando tante migliaia di case erano state abbandonate improvvisamente dagli abitanti; e così vennero licenziati tutti i consueti lavoratori di questo settore, come muratori, carpentieri, falegnami, stuccatori, pittori, vetrai, fabbri, piombatori, e tutti gli operai che vivevano di tale attività.
Poiché la navigazione era ferma, le nostre navi non entravano e uscivano dai porti come in passato; così i marinai erano tutti senza lavoro e molti di essi erano finiti in miseria; e insieme a loro erano ridotti all’inattività commercianti e operai che lavoravano alle costruzioni e attrezzature navali, e che campavano di questo lavoro, come calafati, carpentieri navali, bottai, fabbricanti di corde e di vele, fabbri d’ancora e d’altro, fabbricanti di pulegge, scalpellini, fonditori di cannoni, fornitori navali, scalpellini navali e simili. I proprietari forse potevano vivere grazie alle proprie sostanze, ma gli imprenditori erano completamente senza attività, e di conseguenza tutti i loro dipendenti erano disoccupati. Si aggiunga a questo che il Tamigi era privo di barche, e tutti o la maggior parte dei lavoratori del fiume, guardiani di fari, costruttori di barche e di fanali, erano senza lavoro e abbandonati a se stessi.
Tutte le famiglie, sia quelle che erano fuggite, sia quelle che erano rimaste, riducevano al massimo le spese per vivere; e così un’innumerevole schiera di staffieri, servitori, bottegai, cottimisti, contabili e figure del genere perse completamente il lavoro; e una delle categorie più sfortunate era quella delle povere domestiche, che venivano licenziate e lasciate prive di amici e di appoggio, senza un impiego e senza un tetto.
Potrei essere più preciso a proposito di questo argomento, ma può essere sufficiente ricordare che, essendo fermi tutti i commerci, ogni prestazione cessò; il lavoro, e con esso il pane della povera gente, venne a mancare; e all’inizio i lamenti dei poveri erano la cosa più terribile, sebbene, con la distribuzione dei sussidi, la loro miseria fosse grandemente alleviata. In effetti, molti fuggirono in campagna, ma a Londra ne rimasero migliaia, fin quando vennero messi in fuga dalla disperazione, vennero sorpresi dalla morte per strada e non servirono ad altro se non come messaggeri di morte. Altri, in realtà, recando con sé l’infezione lungo la strada, la diffusero nelle zone più lontane del regno. Molti di costoro presentavano i pietosi spettacoli di disperazione che ho ricordato e furono eliminati dalla morte che sopraggiunse in seguito. Si può dire che essi perirono non per l’infezione in sé, ma per le conseguenze di essa, cioè per la fame e la miseria e la mancanza di tutto, essendo senza tetto, senza denaro, senza amici, senza mezzi per guadagnarsi il pane e senza nessuno che gliene desse, dato che molti erano privi di quella che viene definita residenza legale e perciò non potevano rivolgersi alle parrocchie, e tutti i mezzi di sussistenza che ricevevano erano dovuti alla sollecitudine delle autorità nell’opera di soccorso. Tale soccorso (per riconoscere alle autorità i loro meriti) fu elargito con grande solerzia, secondo quanto giudicarono necessario: e quelli che rimasero in città non patirono mai una miseria simile a quella che soffrirono coloro che se n’erano andati.
Ciascuno consideri quanta gente si guadagna il pane quotidiano in questa città mediante il proprio lavoro, sia artigiani che semplici operai; consideri quindi quale sarebbe la pietosa situazione di tale città, se all’improvviso essi fossero licenziati, se il lavoro cessasse, se per il lavoro non ci fosse più salario.
Questo fu quello che accadde allora; e se le somme di denaro fornite a titolo di carità da persone ben fornite di ogni ceto sociale, sia all’estero che in patria, non fossero state straordinariamente grandi, il sindaco e gli sceriffi non avrebbero potuto mantenere l’ordine pubblico, e anzi avrebbero potuto temere che la disperazione inducesse il popolo a sollevarsi, e lo spingesse a prendere a fucilate le case dei ricchi, e a depredare i mercati delle loro merci.
Plutarco
Vite parallele
Pericle e Fabio Massimo

Ed ecco capitò in primo luogo il flagello della peste che distrusse il fiore dei giovani; fiaccati nell’anima e nel corpo da questa sciagura, gli Ateniesi si inasprirono contro Pericle, e come quelli che usciti di senno per la malattia danno addosso al padre o al medico, cominciarono a tramare contro di lui: essi erano stati indotti dai nemici a credere che la peste traeva origine dal confluire in città della gente di campagna, per cui nella stagione estiva erano costretti a vivere in molti alla rinfusa, in piccole casette o in tende soffocanti, una vita inattiva e sedentaria, in contrasto con la precedente, salubre, all’aria aperta. Di tutto ciò, dicevano, era responsabile colui che per la guerra aveva raccolto entro le mura la massa allontanata dai campi e a nulla utilizzava tanti uomini, ma lasciava che, rinchiusi come bestie, si infettassero tra loro, e non introduceva alcun mutamento, né dava modo di respirare. consumando lentamente il corpo e fiaccando la vivacità dello spirito. [2] Teofrasto, nella sua «Etica», chiedendosi se il carattere si modifica secondo le circostanze e conformandosi alle afflizioni fisiche perde le sue virtù, racconta che Pericle, colto dalla malattia, mostrò ad un amico che gli faceva visita, un amuleto che gli era stato posto attorno al collo dalle donne, per significare che doveva stare davvero male se sopportava anche questa sciocchezza.Quando già era prossimo a morire, gli stavano attorno i maggiorenti, e gli amici che erano in città, e parlavano della sua virtù e del suo potere, quanto grande esso era stato, ed elencavano i suoi successi, e il numero dei suoi trofei (nove erano quelli che da stratego vittorioso aveva riportato). Essi parlavano tra loro convinti che egli non più sentisse; ma Pericle stava attento a tutto, e interrompendoli disse che si stupiva del fatto che di lui ricordavano e lodavano ciò cui aveva messo mano il caso, e che già era capitato ad altri strateghi, mentre non ricordavano il suo merito più grande e più bello; e aggiunse: «Nessuno degli Ateniesi d’oggi ha indossato per causa mia una veste di lutto.
Eduardo Galeano
Le vene aperte dell’America Latina

I batteri e i virus furono gli alleati migliori. Gli europei portavano con sé, come bibliche piaghe, il vaiolo e il tetano, malattie polmonari di vario tipo, malattie intestinali e veneree, il tracoma, il tifo, la lebbra, la febbre gialla e la carie che imputridiva la bocca. Il vaiolo fu il primo a manifestarsi. E che non fosse un castigo divino quella epidemia sconosciuta e ripugnante che accendeva la febbre e corrompeva le carni? «Andarono a insediarsi a Tlaxcala. Allora si diffuse l'epidemia: tosse, pustole ardenti che bruciano», racconta un testimone indigeno. E un altro: «A molti diede la morte la contagiosa, incontenibile, dura malattia delle pustole». Gli indios morivano come mosche. I loro organismi non opponevano difesa alcuna alle nuove malattie. E quelli che sopravvivevano erano infiacchiti, indeboliti, inutili. Secondo l'antropologo brasiliano Darcy Ribeiro, oltre la metà della popolazione indigena d'America, d'Australia e delle isole oceaniche morì per contagio al primo contatto con gli uomini bianchi.
Eugène Ionesco
Il gioco dell’epidemia

Cari concittadini, vi ho convocati per parlarvi delle sorti della nostra città. Ho violato le disposizioni che si oppongono ad una simile riunione e voi, in barba e a scorno degli attuali dirigenti, siete accorsi numerosi. Si tenta di imprigionarci dentro le nostre case e dentro la nostra angoscia. Col pretesto di una malattia che infuria tra di noi - tutti i pretesti sono buoni per i nostri capi - con la scusa di proteggerci dal male, si cerca d’impedirci di agire, di paralizzarci , di intrappolarci e annientarci. La malattia miete le sue vittime nelle case dove l’aria è stagnante e nell’aria stagnante il male si sviluppa molto meglio. All’aria aperta il male ha una presa minore. Comunque non certo maggiore. E’ cattiva politica restare rintanati; cattiva per noi: ma tattica diabolica per i nostri capi. Essi vogliono impedirci di insorgere apertamente, vogliono impedirci di insorgere apertamente, vogliono impedirci di formulare le nostre legittime rivendicazioni, vogliono impedirci di raggrupparci, ci isolano per renderci impotenti e perché il male possa colpirci più facilmente. Mi domando se questa malattia, che si suol definire misteriosa, non sia per caso una loro invenzione. E perché la si definisce misteriosa? Per nasconderne le cause, le ragioni profonde. Ebbene noi siamo qui proprio per demistificare questo mistero. Chi ha interesse che la malattia continui? Noi? E’ poco probabile dal momento che moriamo. Morte senza dubbio politica. Facciamo il gioco dei nostri oppressori, comportandoci come burattini nelle loro mani. Conoscete le statistiche? Centoventimila cittadini sono morti senza ragioni apparenti, negli ultimi tempi, cioè da quanto dura questa faccenda, centoventimila, se non duecentomila dato che le nostre statistiche risalgono a due giorni fa, praticamente quindi circa un quarto della popolazione. Inoltre da quaranta sessantamila persone giacciono in questo momento, secondo i nostri calcoli, negli ospedali dove agonizzano, giacchè le si aiuta più a morire che non a sopravvivere; altre sessantamila giacciono nelle loro abitazioni, con le pompe funebri in attesa davanti alla porta. Se le pompe funebri sono lì in agguato, chi le ha mandate? I nostri capi. Ciò significa che essi sanno, che essi prevedono, che essi forse preparano. Duecentomila morti, centomila malati e moribondi significano che quasi un terzo della popolazione è ormai spacciato. Quanti sono i nostri consiglieri municipali? Ventuno. Di questi ventuno, quattro non sono in città: erano in vacanza al momento della comparsa del male e della chiusura delle porte e, ci dicono, non sono potuti rientrare. Non siamo nati ieri. In previsione di quel che accadeva si sono messi al sicuro; dunque sapevano ciò che stava accadere. Quattro consiglieri su ventuno equivale ad un quinto del totale. Mi direte che anche dei cittadini comuni erano fuori città, in vacanza. Verissimo, ce n’erano, però soltanto un ventesimo della popolazione totale. Non era possibile impedire a tutti di allontanarsi. Sarebbe stata un’ imprudenza: Tuttavia il fatto che un quinto dei consiglieri, contro appena un ventesimo dei loro amministrati, fosse fuori città prova in modo inconfutabile sino a che punto tutta la faccenda sia stata manipolata machiavellicamente. Dei diciassette consiglieri in attività di servizio soltanto tre sono morti. In proporzione un numero infimo in rapporto alla percentuale dei morti in città. E di questi tre consiglieri morti uno era favorevole alle nostre legittime rivendicazioni, nemico del presidente del consiglio municipale e amico del popolo; gli altri due erano personaggi indecisi, seguaci del presidente del consiglio, tuttavia seguaci non troppo convinti e non troppo sicuri. Mi direte che questi tre consiglieri non sono stati palesemente assassinati su ordine degli altri consiglieri. E’ evidente. Però, anche accettando questa obiezione, richiamo la vostra attenzione sul fatto che il problema non consiste tanto nella morte di questi tre consiglieri, cause razionali, quanto piuttosto sul fatto che questi tre morti erano avversari in atto o potenziali del regime. Se è un caso che quattro consiglieri fossero in vacanza (e non è affatto sicuro, come vi dicevo poco fa, che fossero in vacanza per caso) quest’altro fatto non è meno significativo, diciamo che è dovuto al caso obiettivo. Ad ogni modo ci restano quattordici consiglieri in perfetta salute ed in piena attività. Se andiamo avanti di questo ritmo, essi rappresenteranno presto un decimo della popolazione totale della città: facile governare una simile città con le forze ridotte. Chi non morirà finirà tra le loro grinfie mani e piedi legati.
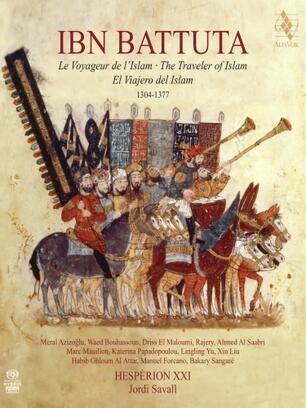
Nei giorni della grande peste che sconvolse Damasco, alla fine del mese di rabī‘ II del 749 [1348], sono stato testimone della mirabile venerazione degli abitanti di Damasco per questa moschea133. Arghūn Shāh, malik degli emiri e luogotenente del sultano, ordinò a un banditore di proclamare per tutta Damasco l’ordine di digiunare per tre giorni, durante i quali era vietato cuocere alcunché di commestibile al mercato – perché lí gran parte della gente mangia cibo cotto, appunto, [che compera] al mercato. I damasceni digiunarono quindi per tre giorni consecutivi, fino a un giovedí. Poi gli emiri, gli sharīf, i qāḍī, i giuristi e gente di svariate altri classi si riunirono nella moschea: erano cosí tanti che la riempirono completamente! Trascorsero la notte di vigilia del venerdí in preghiere, invocazioni e suppliche e quindi, compiuta la preghiera dell’alba, uscirono fuori a piedi – gli emiri addirittura scalzi – con in mano il Corano. Tutti gli abitanti della città, uomini e donne, piccoli e grandi, si unirono a loro: parteciparono anche gli ebrei con la loro Torah e i cristiani con il loro Vangelo, accompagnati da donne e bambini, e ognuno piangeva, implorava e supplicava Dio in nome dei propri libri e dei propri profeti. Andarono alla moschea al-Aqdām e tra suppliche e invocazioni rimasero lí fin verso mezzogiorno, poi tornarono in città e compirono la preghiera del venerdí. Allora l’Altissimo alleviò la loro sofferenza: a Damasco, il numero dei morti si fermò a duemila al giorno, mentre al Cairo – e in Egitto in genere – arrivò a ventiquattromila.
Vicino alla porta est di Damasco si staglia un minareto bianco sul quale, secondo il Ṣaḥīḥ di Muslim, scenderà Gesú
MARY SHELLEY
L’ultimo uomo

Questa è dunque la sensazione che cominciammo a provare nei confronti della morte dai mille volti che si aggirava libera nei distretti più scelti della nostra bella dimora e, soprattutto, nei confronti della peste. Avevamo paura dell’estate che stava per arrivare. Le nazioni confinanti con i paesi già infetti, cominciarono a studiare seri progetti per allontanare meglio il nemico. Noi, un popolo di commercianti, fummo obbligati a prendere in considerazione tali piani; e il problema del contagio divenne argomento di urgente discussione. Che la peste non fosse quella che comunemente viene definita una malattia infettiva, come la scarlattina o l’ormai estinto vaiolo era accertato. Si diceva che fosse un’epidemia. Ma la questione principale, di come questa epidemia si fosse prodotta e sviluppata, era ancora aperta. Se l’infezione dipendeva dall’aria, l’aria era soggetta all’infezione. Prendiamo il caso, per esempio, della febbre tifoide portata da alcune navi in una città portuale: ebbene, le stesse persone non potevano trasmetterla a una città situata in una posizione più fortunata. Ma come facciamo a giudicare le diverse atmosfere, e affermare che in una data città la peste morrà senza rigenerarsi, mentre in un’altra la natura le ha preparato un raccolto abbondante? Allo stesso modo, gli individui potrebbero sfuggire novantanove volte, e ricevere il colpo mortale alla centesima; perché i corpi talvolta sono in condizione di respingere il contagio della malattia, e talaltra bramosi di assorbirlo. Queste considerazioni spinsero i nostri legislatori a fare una pausa prima di decidere quali leggi dovessero far entrare in vigore. Il male stava diventando così diffuso, ed era così violento e incurabile, che nessuna cura, nessuna prevenzione che aggiungesse anche soltanto una possibilità di salvezza poteva essere ritenuta superflua.
Si trattava di questioni di prudenza; non c’era la necessità immediata di prendere serie misure di cautela. L’Inghilterra era ancora sicura. Tra noi e la peste si frapponevano, mura senza breccia, la Francia, la Germania, l’Italia e la Spagna. I nostri vascelli, in verità, erano il trastullo dei venti e delle onde, proprio come Gulliver era il giocattolo degli abitanti di Brobdignac; tuttavia, al riparo delle nostre difese, queste eruzioni della natura non potevano ferirci nel corpo o nell’anima. Non potevamo aver paura e non ne avevamo. Nondimeno, un sentimento di soggezione, un senso di stupore che toglieva il fiato, una dolorosa sensazione della degradazione dell’umanità penetrò in ogni cuore. La natura, nostra madre e nostra amica, ci guardava con aspetto minaccioso. Ci dimostrava chiaramente che, per quanto ci permettesse di assegnarle delle leggi e di sottomettere i suoi poteri visibili, tuttavia, bastava che alzasse anche soltanto un dito e dovevamo tremare. Poteva prendere il nostro globo orlato di montagne, cinto dall’atmosfera, contenente le condizioni del nostro esistere insieme a tutto quello che la mente dell’uomo poteva inventare o conquistare con la sua forza; poteva prendere la palla in mano e scagliarla nello spazio, dove in un attimo la vita sarebbe stata risucchiata, l’uomo e tutti i suoi sforzi annientati per sempre.
Queste meditazioni erano comuni tra di noi; ma, cionondimeno, continuavamo a occuparci delle nostre faccende quotidiane e di quei progetti la cui realizzazione avrebbe richiesto molti anni. Non si udì una sola voce che ci dicesse di fermarci! Quando, attraverso i canali di commercio giunsero a farsi avvertire anche tra di noi le sofferenze che affliggevano i popoli stranieri, ci apprestammo a porvi rimedio. Vennero fatte sottoscrizioni per gli emigranti e per i mercanti che avevano dichiarato bancarotta in seguito al fallimento dell’attività commerciale. Lo spirito inglese si risvegliò fino a mettersi in piena attività e, come aveva sempre fatto, si preparò a resistere al male, e ad arginare la breccia che la natura malata aveva permesso al caos e alla morte di aprire entro i confini e le sponde che fino ad allora li avevano tenuti lontano.
All’inizio dell’estate cominciammo a renderci conto che i danni che avevano colpito quei paesi lontani erano più gravi di quanto avessimo sospettato in un primo momento. Quito fu distrutta da un terremoto. Il Messico fu devastato dagli effetti congiunti di tempeste, peste e carestia. Folle di emigranti inondarono l’Europa occidentale, e la nostra isola era diventata il rifugio di migliaia di persone…Molti degli stranieri erano privi di tutto; e il loro numero sempre crescente impedì alla lunga di far ricorso ai normali mezzi di soccorso. Il commercio fu bloccato dal fallimento dei consueti scambi di carichi tra noi e l’America, l’india, l’Egitto e la Grecia. Il normale ritmo di vita subì un’interruzione improvvisa. … Questi disastri colpirono nel vivo così tanti cuori e, attraverso i vari canali di commercio, si diffusero in maniera così completa in ogni classe e in ogni strato della società che divennero, per forza di cose, il problema primario del paese, l’argomento principale cui tutti dovevamo rivolgere l’attenzione. Possibile, ognuno chiedeva all’altro con stupore e sgomento, che a causa di questi disordini della natura interi paesi vengano devastati, intere nazioni annientate? Le immense città dell’America, le fertili pianure dell’Indostan, le popolate dimore dei cinesi, sono minacciate dalla distruzione totale. Dove, fino a poco fa, moltitudini industriose si riunivano alla ricerca del piacere o del profitto, ora si ode solo il suono del gemito e della sofferenza. L’aria è avvelenata, ogni essere umano inala morte, persino se è giovane e sano e le speranze sono nel pieno del loro rigoglio. Ci tornò alla mente la peste del 1348, quando si calcolò che un terzo dell’umanità fosse stato annientato. Fino a ora l’Europa occidentale non era stata contagiata: sarebbe stato sempre così? …I nostri tormenti, sebbene fossero provocati dalla fittizia reciprocità del commercio, aumentarono in debita proporzione. Banchieri, mercanti e manifatturieri, il cui mestiere dipendeva dalle esportazioni e dallo scambio di beni, fecero bancarotta. Simili eventi, quando capitano in maniera isolata, colpiscono solo le parti immediatamente coinvolte; ma ormai la prosperità dell’intera nazione era scossa da perdite frequenti ed estese. Famiglie cresciute nell’opulenza e nel lusso erano ridotte alla miseria. La stessa condizione di pace di cui ci gloriavamo era nociva; non c’erano mezzi per impiegare i disoccupati o far espatriare la popolazione in eccesso. Persino la risorsa delle colonie si era prosciugata, perché la peste infuriava nei territori della Nuova Olanda, della Terra di Van Diemen e del Capo di Buona Speranza. Oh, se solo fosse esistita qualche fiala medicinale per purificare la natura infetta e riportare la terra alla sua abituale salute! ….. Ogni giorno aggiungeva nuove difficoltà; l’arrivo recente di navi cariche di emigranti, la cessazione totale dei commerci, la moltitudine affamata che si affollava intorno al palazzo del Protettorato erano circostanze che non potevano essere camuffate. Il colpo fu sferrato: l’aristocrazia ottenne tutto quello che desiderava e aderì a un disegno di legge, della durata di dodici mesi, che tassava del venti per cento tutte le rendite terriere del paese.
Nella metropoli e nelle popolose città, prima indotte alla disperazione, fu riportata la calma; tornammo a riflettere sulle calamità lontane, chiedendoci se il futuro avrebbe portato qualche sollievo ai loro eccessi. Era agosto, e dunque ci poteva essere ben poca speranza di ristoro durante il caldo. Al contrario, la malattia guadagnò virulenza, mentre l’inedia compiva il suo lavoro consueto. A migliaia morirono senza essere compianti, perché accanto al cadavere ancora caldo giaceva disteso, reso muto dalla morte, chi quel morto piangeva.
Il diciotto di questo mese giunse a Londra la voce che la peste era arrivata in Francia e in Italia. In un primo momento, in città, queste informazioni vennero soltanto sussurrate, ma nessuno osava ripetere a voce alta la notizia che sgomentava l’animo. Quando qualcuno incontrava un amico per strada, diceva semplicemente, allontanandosi in fretta: «Lo sai, vero!»; mentre l’altro, con grido improvviso di paura e di orrore, rispondeva: «Che ne sarà di noi?». Alla lunga la notizia apparve sui giornali. Il paragrafo fu inserito in una parte poco visibile: «Siamo dolenti di comunicare che non ci possono più essere dubbi sul fatto che la peste sia penetrata a Livorno, Genova e Marsiglia». Non seguiva alcuna parola di commento; ogni lettore, spaventato, faceva il proprio. Eravamo come un uomo che senta dire che la sua casa sta bruciando, e tuttavia corre per le strade spinto dalla latente speranza che si tratti di un errore, finché volta l’angolo e vede il tetto che lo proteggeva avvolto dalle fiamme. Prima era solo una voce; ma ora la notizia era stata pubblicata con parole che non potevano essere più cancellate, stampata con caratteri netti e innegabili. L’angolo nascosto in cui era stata relegata, la rendeva ancor più vistosa: all’occhio sconcertato dalla paura i caratteri minuscoli diventavano giganteschi, sembravano incisi da una penna di ferro, suggellati dal fuoco, intessuti nelle nuvole, impressi sulla faccia stessa dell’universo.

Noi, d’invitta stirpe rampolli, a morte
siamo tratti, in preda a un fato atroce;
sempre processioni in onore suo:
lunghe file affrettansi verso il rogo,
triste folla; ingorgasi il mesto stuolo,
e alle turbe, volte al sepolcro, è poco
spazio quello ch’apron le sette porte.
Restano i cadaveri in mucchio, e i morti
premono i morti.
Da principio il male infettò gli agnelli:
l’erba folta spiacque al lanoso gregge;
si fermò, sul punto di dare il colpo,
con la mano in aria, il sacrificante,
perché il toro, a cui risplendeva il corno,
cadde senza forza; s’aperse al colpo
la cervice, infranta dal ferro immane:
niente sangue; l’ascia si macchia solo
di schifosa marcia che fuori fiotta.
Mentre corre, languido a mezzo il giro
il destriero cade e travolge a terra
seco il padrone.
Giaccion sopra i campi le bestie sole;
langue il toro in mezzo al morente armento:
fra i giovenchi fradici, accanto al gregge
decimato, crolla il pastore estinto.
Non han più paura dei lupi i cervi,
tace del leone il ruggito iroso,
la ferocia cessa negli orsi irsuti;
perde il suo veleno il serpente dentro
la sua tana e, secca la gola, muore.
La selva ricca di fronde, non più
proietta l’ombra dai culmini,
non verdeggiano i campi di frutti, né più
la vite al peso dei grappoli
s’incurva: ogni cosa ora abbrivida
al contagio pestifero.
Hanno infranto le porte dell’Erebo
le Furie, agitando le fiaccole,
e mutò il Flegetonte il suo letto; quassù
lo Stige all’Ismeno si mescola.
La morte spalanca l’avida
mascella e a volo disfrenasi;
e il nocchiero crudele per vegeta
vecchiezza, che in riva alla torbida
fiumana sul legno capace si sta,
sfibrato, a fatica può muovere
i remi, ché i morti s’affollano.
Si dice che, rotte del Ténaro
le catene, s’aggiri ora Cerbero
tra noi, e dal suolo un ululo
sia sorto e nei boschi balenino
sovrumani fantasmi; due volte tremò,
scuotendo la neve, la selva cadmea,
e di sangue la fonte di Dirce spumò;
nella notte silente
i cani d’Anfione ulularono.
O segni di morte orribile,
della morte stessa più orribili!
Un torpore incatena le membra, un rossor
s’effonde sul volto, si spargono
sul capo macchie leggere, un ardor
infiamma il cervello, e le palpebre
s’iniettan di sangue; rigido
diventa lo sguardo; in putredine
si disfanno le membra, tintinnano
gli orecchi, e il sangue gocciola
nerastro dal naso che incurvasi:
senza tregua sommuove le viscere
un anelito stridulo. Abbracciano
le fredde pietre a sollievo; se poi
la casa si vuota, corrono
alle fonti, ma tanto più accrescono
la sete, quanto più bevono.
Una folla agli altari prosternasi,
chiedendo la morte, l’unico
favore ch’è facile aver dagli dèi;
non si bada a placarli, ma a pascerli
d’un così funereo spettacolo.

Già erano gli anni della fruttifera incarnazione del Figliuolo di Dio al numero pervenuti di milletrecentoquarantotto, quando nella egregia città di Fiorenza, oltre a ogn'altra italica bellissima, pervenne la mortifera pestilenza: la quale, per operazion de' corpi superiori o per le nostre inique opere da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali, alquanti anni davanti nelle parti orientali incominciata, quelle d'inumerabile quantità de' viventi avendo private, senza ristare d'un luogo in uno altro continuandosi, verso l'Occidente miserabilmente s'era ampliata. E in quella non valendo alcuno senno né umano provedimento, per lo quale fu da molte immondizie purgata la città da officiali sopra ciò ordinati e vietato l'entrarvi dentro a ciascuno infermo e molti consigli dati a conservazion della sanità, né ancora umili supplicazioni non una volta ma molte e in processioni ordinate, in altre guise a Dio fatte dalle divote persone, quasi nel principio della primavera dell'anno predetto orribilmente cominciò i suoi dolorosi effetti, e in miracolosa maniera, a dimostrare. E non come in Oriente aveva fatto, dove a chiunque usciva il sangue del naso era manifesto segno di inevitabile morte: ma nascevano nel cominciamento d'essa a' maschi e alle femine parimente o nella anguinaia o sotto le ditella certe enfiature, delle quali alcune crescevano come una comunal mela, altre come uno uovo, e alcune più e alcun'altre meno, le quali i volgari nominavan gavoccioli. E dalle due parti del corpo predette infra brieve spazio cominciò il già detto gavocciolo mortifero indifferentemente in ogni parte di quello a nascere e a venire: e da questo appresso s'incominciò la qualità della predetta infermità a permutare in macchie nere o livide, le quali nelle braccia e per le cosce e in ciascuna altra parte del corpo apparivano a molti, a cui grandi e rade e a cui minute e spesse. E come il gavocciolo primieramente era stato e ancora era certissimo indizio di futura morte, così erano queste a ciascuno a cui venieno. A cura delle quali infermità né consiglio di medico né virtù di medicina alcuna pareva che valesse o facesse profitto: anzi, o che natura del malore nol patisse o che la ignoranza de' medicanti (de' quali, oltre al numero degli scienziati, così di femine come d'uomini senza avere alcuna dottrina di medicina avuta giammai, era il numero divenuto grandissimo) non conoscesse da che si movesse e per consequente debito argomento non vi prendesse, non solamente pochi ne guarivano, anzi quasi tutti infra 'l terzo giorno dalla apparizione de' sopra detti segni, chi più tosto e chi meno e i più senza alcuna febbre o altro accidente morivano. E fu questa pestilenza di maggior forza per ciò che essa dagli infermi di quella per lo comunicare insieme s'avventava a' sani, non altramenti che faccia il fuoco alle cose secche o unte quando molto gli sono avvicinate. E più avanti ancora ebbe di male: ché non solamente il parlare e l'usare cogli infermi dava a' sani infermità o cagione di comune morte, ma ancora il toccare i panni o qualunque altra cosa da quegli infermi stata tocca o adoperata pareva seco quella cotale infermità nel toccator transportare. Maravigliosa cosa è a udire quello che io debbo dire: il che, se dagli occhi di molti e da' miei non fosse stato veduto, appena che io ardissi di crederlo, non che di scriverlo, quantunque da fededegna udito l'avessi. Dico che di tanta efficacia fu la qualità della pestilenzia narrata nello appiccarsi da uno a altro, che non solamente l'uomo all'uomo, ma questo, che è molto più, assai volte visibilmente fece, cioè che la cosa dell'uomo infermo stato, o morto di tale infermità, tocca da un altro animale fuori della spezie dell'uomo, non solamente della infermità il contaminasse ma quello infra brevissimo spazio uccidesse. Di che gli occhi miei, sì come poco davanti è detto, presero tra l'altre volte un dì così fatta esperienza: che, essendo gli stracci d'un povero uomo da tale infermità morto gittati nella via publica e avvenendosi a essi due porci, e quegli secondo il lor costume prima molto col grifo e poi co' denti presigli e scossiglisi alle guance, in piccola ora appresso, dopo alcuno avvolgimento, come se veleno avesser preso, amenduni sopra li mal tirati stracci morti caddero in terra. Dalle quali cose e da assai altre a queste simiglianti o maggiori nacquero diverse paure e imaginazioni in quegli che rimanevano vivi, e tutti quasi a un fine tiravano assai crudele, ciò era di schifare e di fuggire gl'infermi e le lor cose; e così faccendo, si credeva ciascuno a se medesimo salute acquistare. E erano alcuni, li quali avvisavano che il viver moderatamente e il guardarsi da ogni superfluità avesse molto a così fatto accidente resistere: e fatta lor brigata, da ogni altro separati viveano, e in quelle case ricogliendosi e racchiudendosi, dove niuno infermo fosse e da viver meglio, dilicatissimi cibi e ottimi vini temperatissimamente usando e ogni lussuria fuggendo, senza lasciarsi parlare a alcuno o volere di fuori, di morte o d'infermi, alcuna novella sentire, con suoni e con quegli piaceri che aver poteano si dimoravano. Altri, in contraria opinion tratti, affermavano il bere assai e il godere e l'andar cantando a torno e sollazzando e il sodisfare d'ogni cosa all'appetito che si potesse e di ciò che avveniva ridersi e beffarsi esser medicina certissima a tanto male: e così come il dicevano il mettevano in opera a lor potere, il giorno e la notte ora a quella taverna ora a quella altra andando, bevendo senza modo e senza misura, e molto più ciò per l'altrui case faccendo, solamente che cose vi sentissero che lor venissero a grado o in piacere. E ciò potevan far di leggiere, per ciò che ciascun, quasi non più viver dovesse, aveva, sì come sé, le sue cose messe in abandono: di che le più delle case erano divenute comuni, e così l'usava lo straniere, pure che a esse s'avvenisse, come l'avrebbe il propio signore usate; e con tutto questo proponimento bestiale sempre gl'infermi fuggivano a lor potere. E in tanta afflizione e miseria della nostra città era la reverenda auttorità delle leggi, così divine come umane, quasi caduta e dissoluta tutta per li ministri e essecutori di quelle, li quali, sì come gli altri uomini, erano tutti o morti o infermi o sì di famiglie rimasi stremi, che uficio alcuno non potean fare; per la qual cosa era a ciascun licito quanto a grado gli era d'adoperare. Molti altri servavano, tra questi due di sopra detti, una mezzana via, non strignendosi nelle vivande quanto i primi né nel bere e nell'altre dissoluzioni allargandosi quanto i secondi, ma a sofficienza secondo gli appetiti le cose usavano e senza rinchiudersi andavano a torno, portando nelle mani chi fiori, chi erbe odorifere e chi diverse maniere di spezierie, quelle al naso ponendosi spesso, estimando essere ottima cosa il cerebro con cotali odori confortare, con ciò fosse cosa che l'aere tutto paresse dal puzzo de' morti corpi e delle infermità e delle medicine compreso e puzzolente. Alcuni erano di più crudel sentimento, come che per avventura più fosse sicuro, dicendo niuna altra medicina essere contro alle pistilenze migliore né così buona come il fuggir loro davanti: e da questo argomento mossi, non curando d'alcuna cosa se non di sé, assai e uomini e donne abbandonarono la propia città, le proprie case, i lor luoghi e i lor parenti e le lor cose, e cercarono l'altrui o almeno il lor contado, quasi l'ira di Dio a punire le iniquità degli uomini con quella pistolenza non dove fossero procedesse, ma solamente a coloro opprimere li quali dentro alle mura della lor città si trovassero, commossa intendesse, o quasi avvisando niuna persona in quella dover rimanere e la sua ultima ora esser venuta. E come che questi così variamente oppinanti non morissero tutti, non per ciò tutti campavano: anzi, infermandone di ciascuna molti e in ogni luogo, avendo essi stessi, quando sani erano, essemplo dato a coloro che sani rimanevano, quasi abbandonati per tutto languieno. E lasciamo stare che l'uno cittadino l'altro schifasse e quasi niuno vicino avesse dell'altro cura e i parenti insieme rade volte o non mai si visitassero e di lontano: era con sì fatto spavento questa tribulazione entrata ne' petti degli uomini e delle donne, che l'un fratello l'altro abbandonava e il zio il nepote e la sorella il fratello e spesse volte la donna il suo marito; e, che maggior cosa è e quasi non credibile, li padri e le madri i figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e di servire schifavano. Per la qual cosa a coloro, de' quali era la moltitudine inestimabile, e maschi e femine, che infermavano, niuno altro subsidio rimase che o la carità degli amici (e di questi fur pochi) o l'avarizia de' serventi, li quali da grossi salari e sconvenevoli tratti servieno, quantunque per tutto ciò molti non fossero divenuti: e quegli cotanti erano uomini o femine di grosso ingegno, e i più di tali servigi non usati, li quali quasi di niuna altra cosa servieno che di porgere alcune cose dagl'infermi adomandate o di riguardare quando morieno; e servendo in tal servigio sé molte volte col guadagno perdeano. E da questo essere abbandonati gl'infermi da' vicini, da' parenti e dagli amici e avere scarsità di serventi, discorse uno uso quasi davanti mai non udito: che niuna, quantunque leggiadra o bella o gentil donna fosse, infermando non curava d'avere a' suoi servigi uomo, qual che egli si fosse o giovane o altro, e a lui senza alcuna vergogna ogni parte del corpo aprire non altramenti che a una femina avrebbe fatto, solo che la necessità della sua infermità il richiedesse; il che in quelle che ne guerirono fu forse di minore onestà, nel tempo che succedette, cagione. E oltre a questo ne seguio la morte di molti che per avventura, se stati fossero atati, campati sarieno; di che, tra per lo difetto degli oportuni servigi, li quali gl'infermi aver non poteano, e per la forza della pistolenza, era tanta nella città la moltitudine di quegli che di dì e di notte morieno, che uno stupore era a udir dire, non che a riguardarlo. Per che, quasi di necessità, cose contrarie a' primi costumi de' cittadini nacquero tra coloro li quali rimanean vivi.Era usanza, sì come anco Era usanza, sì come ancora oggi veggiamo usare, che le donne parenti e vicine nella casa del morto si ragunavano e quivi con quelle che più gli appartenevano piagnevano; e d'altra parte dinanzi la casa del morto co' suoi prossimi si ragunavano i suoi vicini e altri cittadini assai, e secondo la qualità del morto vi veniva il chericato; e egli sopra gli omeri de' suoi pari, con funeral pompa di cera e di canti, alla chiesa da lui prima eletta anzi la morte n'era portato. Le quali cose, poi che a montar cominciò la ferocità della pistolenza, o in tutto o in maggior parte quasi cessarono e altre nuove in lor luogo ne sopravennero. Per ciò che, non solamente senza aver molte donne da torno morivan le genti, ma assai n'eran di quegli che di questa vita senza testimonio trapassavano: e pochissimi erano coloro a' quali i pietosi pianti e l'amare lagrime de' suoi congiunti fossero concedute, anzi in luogo di quelle s'usavano per li più risa e motti e festeggiar compagnevole; la quale usanza le donne, in gran parte postposta la donnesca pietà, per salute di loro avevano ottimamente appresa. E erano radi coloro i corpi de' quali fosser più che da un diece o dodici de' suoi vicini alla chiesa acompagnato; de' quali non gli orrevoli e cari cittadini ma una maniera di beccamorti sopravenuti di minuta gente (che chiamar si facevan becchini, la quale questi servigi prezzolata faceva) sotto entravano alla bara; e quella con frettolosi passi, non a quella chiesa che esso aveva anzi la morte disposto ma alla più vicina le più volte il portavano, dietro a quatro o a sei cherici con poco lume e tal fiata senza alcuno; li quali con l'aiuto de' detti becchini, senza faticarsi in troppo lungo oficio o solenne, in qualunque sepoltura disoccupata trovavano più tosto il mettevano. Della minuta gente, e forse in gran parte della mezzana, era il raguardamento di molto maggior miseria pieno: per ciò che essi, il più o da speranza o da povertà ritenuti nelle lor case, nelle lor vicinanze standosi a migliaia per giorno infermavano, e non essendo né serviti né atati d'alcuna cosa, quasi senza alcuna redenzione, tutti morivano. E assai n'erano che nella strada publica o di dì o di notte finivano, e molti, ancora che nelle case finissero, prima col puzzo de' lor corpi corrotti che altramenti facevano a' vicini sentire sé esser morti: e di questi e degli altri che per tutto morivano, tutto pieno. Era il più da' vicini una medesima maniera servata, mossi non meno da tema che la corruzione de' morti non gli offendesse, che da carità la quale avessero a' trapassati. Essi, e per se medesimi e con l'aiuto d'alcuni portatori, quando aver ne potevano, traevano delle lor case li corpi de' già passati, e quegli davanti alli loro usci ponevano, dove, la mattina spezialmente, n'avrebbe potuti veder senza numero chi fosse attorno andato: e quindi fatte venir bare, e tali furono che per difetto di quelle sopra alcuna tavola, ne ponieno. Né fu una bara sola quella che due o tre ne portò insiememente, né avvenne pure una volta, ma se ne sarieno assai potute annoverare di quelle che la moglie e 'l marito, di due o tre fratelli, o il padre e il figliuolo, o così fattamente ne contenieno. E infinite volte avvenne che, andando due preti con una croce per alcuno, si misero tre o quatro bare, da' portatori portate, di dietro a quella: e, dove un morto credevano avere i preti a sepellire, n'avevano sei o otto e tal fiata più. Né erano per ciò questi da alcuna lagrima o lume o compagnia onorati, anzi era la cosa pervenuta a tanto, che non altramenti si curava degli uomini che morivano, che ora si curerebbe di capre: per che assai manifestamente apparve che quello che il naturale corso delle cose non avea potuto con piccoli e radi danni a' savi mostrare doversi con pazienza passare, la grandezza de' mali eziandio i semplici far di ciò scorti e non curanti. Alla gran moltitudine de' corpi mostrata, che a ogni chiesa ogni dì e quasi ogn'ora concorreva portata, non bastando la terra sacra alle sepolture, e massimamente volendo dare a ciascun luogo proprio secondo l'antico costume, si facevano per gli cimiterii delle chiese, poi che ogni parte era piena, fosse grandissime nelle quali a centinaia si mettevano i sopravegnenti: e in quelle stivati, come si mettono le mercatantie nelle navi a suolo a suolo, con poca terra si ricoprieno infino a tanto che della fossa al sommo si pervenia. E acciò che dietro a ogni particularità le nostre passate miserie per la città avvenute più ricercando non vada, dico che così inimico tempo correndo per quella, non per ciò meno d'alcuna cosa risparmiò il circustante contado. Nel quale, lasciando star le castella, che simili erano nella loro piccolezza alla città, per le sparte ville e per li campi i lavoratori miseri e poveri e le loro famiglie, senza alcuna fatica di medico o aiuto di servidore, per le vie e per li loro colti e per le case, di dì e di notte indifferentemente, non come uomini ma quasi come bestie morieno; per la qual cosa essi, così nelli loro costumi come i cittadini divenuti lascivi, di niuna lor cosa o faccenda curavano: anzi tutti, quasi quel giorno nel quale si vedevano esser venuti la morte aspettassero, non d'aiutare i futuri frutti delle bestie e delle terre e delle loro passate fatiche ma di consumare quegli che si trovavano presenti si sforzavano con ogni ingegno. Per che adivenne i buoi, gli asini, le pecore, le capre, i porci, i polli e i cani medesimi fedelissimi agli uomini, fuori delle proprie case cacciati, per li campi, dove ancora le biade abbandonate erano, senza essere non che raccolte ma pur segate, come meglio piaceva loro se n'andavano; e molti, quasi come razionali, poi che pasciuti erano bene il giorno, la notte alle lor case senza alcuno correggimento di pastore si tornavano satolli. Che più si può dire, lasciando stare il contado e alla città ritornando, se non che tanta e tal fu la crudeltà del cielo, e forse in parte quella degli uomini, che infra 'l marzo e il prossimo luglio vegnente, tra per la forza della pestifera infermità e per l'esser molti infermi mal serviti o abbandonati ne' lor bisogni per la paura ch'aveono i sani, oltre a centomilia creature umane si crede per certo dentro alle mura della città di Firenze essere stati di vita tolti, che forse, anzi l'accidente mortifero, non si saria estimato tanti avervene dentro avuti? O quanti gran palagi, quante belle case, quanti nobili abituri per adietro di famiglie pieni, di signori e di donne, infino al menomo fante rimaser voti! O quante memorabili schiatte, quante ampissime eredità, quante famose ricchezze si videro senza successor debito rimanere! Quanti valorosi uomini, quante belle donne, quanti leggiadri giovani, li quali non che altri, ma Galieno, Ipocrate o Esculapio avrieno giudicati sanissimi, la mattina desinarono co' lor parenti, compagni e amici, che poi la sera vegnente appresso nell'altro mondo cenaron con li lor passati!
San Cipriano di Cartagine
La Pestilenza

Molti dei nostri muoiono durante questa epidemia e questo vuol dire che molti dei nostri fratelli sono liberati dal mondo. Questa mortalità diventa una peste per i giudei, per i gentili e per i nemici di Cristo; per i servi di Dio diventa invece una morte salutare. Il fatto che senza alcuna distinzione tra gli uomini muoiono giusti ed ingiusti non vi deve far credere che la morte destini ad un’eguale sorte i cattivi e i buoni. I giusti vengono chiamati alla pace, gli ingiusti sono portati via per il supplizio. A quelli che hanno fede viene anticipata la protezione, ai cattivi la pena. Fratelli carissimi, non sappiamo comprendere e apprezzare i benefici divini, né riconosciamo cosa ci è concesso. Ecco che le vergini muoiono nella pace, sicure della propria salvezza: esse avanzano gloriose senza temere le minacce, le seduzioni e i lupanari dell’anticristo. I giovani sfuggono i pericoli dell’età difficile e raggiungono felicemente il premio della continenza e dell’innocenza. La matrona, mollemente educata, non teme più i tormenti, perché avendo ottenuto di affrettare la morte, sfugge alla paura della persecuzione, alle battiture e alla tortura del carnefice. I tiepidi sono stimolati dallo spavento della pestilenza e della sventura, i negligenti sono spronati, i pigri destati, i disertori della fede sono costretti a ritornare, i pagani sono obbligati a credere, i fedeli più anziani sono chiamati al riposo, un nuovo e numeroso esercito si raccoglie a battaglia con maggiore forza, pronto a combattere senza paura di morire quando verrà il momento della lotta, perché viene allenato al combattimento attraverso il flagello della peste. Carissimi fratelli, quanto è prezioso, utile e necessario che questa peste e questa epidemia, all’apparenza orribili e funeste, accertino la giustizia dei singoli ed esaminino i sentimenti umani Tale peste mostra se i sani assistano i malati, se i parenti amino i loro consanguinei come devono, se i padroni abbiano compassione dei loro schiavi colpiti dal male, se i medici non trascurino i malati che hanno bisogno di aiuto. Questa peste prova se gli animi violenti sappiano tenere a freno la loro prepotenza, se poi gli avidi, almeno per paura della morte, eliminino i loro desideri insaziabili e la loro pazza avarizia, se i superbi si sottomettano, se i cattivi calmino la loro audacia, se i ricchi, vedendo i loro cari venir meno distribuiscano almeno qualche cosa e regalino un poco di roba, dato che moriranno senza eredi . Anche se questa epidemia non avesse portato altro beneficio, è servita moltissimo a noi cristiani e servi di Dio, perché incominciamo a desiderare volentieri il martirio imparando a non temere la morte. La peste è per noi una prova, non uno sterminio, perché offre al nostro animo la possibilità di acquistare la gloria con prove di coraggio preparandolo alla corona con il disprezzo della morte.
Kurt Vonnegut
Ghiaccio Nove

“Una volta,” disse Castle “quando io avevo circa quindici anni, ci fu un ammutinamento qui vicino, su una nave greca diretta da Hong Kong all’Avana con un carico di mobili di vimini. Gli ammutinati si impadronirono della nave, ma non sapevano come manovrarla, e la mandarono a fracassarsi sulle rocce vicino al castello di ‘Papà’ Monzano. Annegarono tutti, tranne i topi. I topi e i mobili di vimini arrivarono a riva.”
La storia sembrava finita lì, ma non potevo esserne certo. “E così?”
“E così qualcuno si prese i mobili gratis e qualcuno si prese la peste bubbonica. Nell’ospedale di mio padre vi furono millequattrocento morti in dieci giorni. Ha mai visto qualcuno morire di peste bubbonica?”
“Non ho avuto questa infe“Non ho avuto questa infelicità.”
“Le ghiandole linfatiche dell’inguine e delle ascelle si gonfiano e diventano grosse come aranci.”
“Posso crederlo.”
“Dopo la morte, il corpo diventa nero... come il carbone di Newcastle, nel caso di San Lorenzo. Quando la peste spadroneggiava, la Casa della Speranza e Misericordia nella Giungla sembrava Auschwitz o Buchenwald. Avevamo certi mucchi di cadaveri così alti e larghi che il bulldozer che cercava di spingerli verso una fossa comune si incagliò. Mio padre lavorò senza dormire per giorni interi, lavorò senza dormire ma anche senza salvare molte vite.”
L’orribile racconto di Castle fu interrotto dallo squillo di un telefono.
“Mio Dio,” disse Castle “non sapevo neppure che avessero già allacciato i telefoni.”
Alzai il ricevitore. “Pronto?”
Era il maggior generale Franklin Hoenniker che mi cercava. Era ansimante e spaventato a morte.
“Mi ascolti! Lei deve venire immediatamente da me. Dobbiamo parlare! Potrebbe essere molto importante per lei!”
“Può darmene un’idea?”
“Non per telefono, non per telefono. Venga a casa mia. Venga subito! La prego!”
“Va bene.”
“Non sto scherzando. E una cosa veramente importante per lei. Questa è la cosa più importante di tutte.” Riattaccò.
“Di cosa si tratta?” chiese Castle.
“Non ne ho la minima idea. Frank Hoenniker mi vuole immediatamente.”
“Faccia con calma. È un imbecille.”
“Ha detto che era importante.”
“E come può sapere, quello, se è importante? Io ricaverei un uomo migliore di lui se lo scolpissi in una banana.”
“Be’, comunque finisca il suo racconto.”
“Dove ero arrivato?”
“La peste bubbonica. Il bulldozer che si era incagliato nei cadaveri.”
“Ah, sì. Ad ogni modo, una notte rimasi con mio padre, mentre lavorava. Era tutto quello che potevamo fare per trovare un paziente vivo da curare. In un letto dopo l’altro e dopo l’altro, trovavamo solo morti.
“E mio padre cominciò a ridacchiare” continuò Castle. “Non riusciva a smettere. Uscì nella notte, con la sua lampada tascabile. Continuava a ridacchiare. Faceva danzare il raggio della lampada su tutta quella gente morta ammonticchiata là fuori. Mi mise una mano sulla testa, e sa cosa mi disse quell’uomo meraviglioso?” chiese Castle.
“No.”
“‘Figlio,’ mi disse mio padre ‘un giorno tutto questo sarà tuo.’“‘
Mark Twain
Seguendo l’Equatore
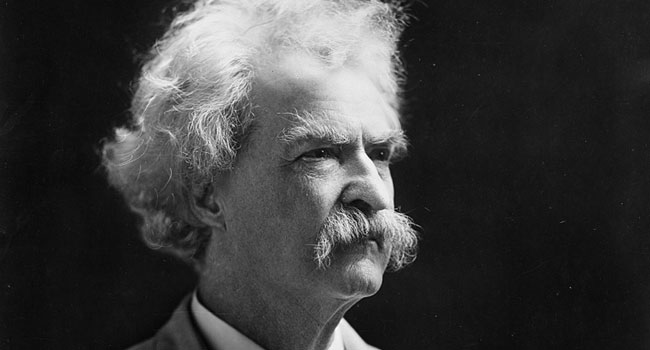
La peste porta con sé un terrore che nessun altro morbo può provocare; giacché di tutte le malattie note all’uomo, essa è la più letale – di gran lunga la più letale. «Cinquantadue nuovi casi – tutti fatali.» La Morte Nera è l’unica in grado di sterminare a questo modo. Tutti possiamo immaginare, in qualche maniera, la desolazione di una città colpita dalla peste, e lo stordimento della calma rotta a intervalli regolari da lontani scoppi di lamenti che indicano il passaggio di cortei funebri qua e là, ma credo sia impossibile per noi renderci conto dell’incubo di paura e terrore che s’impadronisce dei vivi, che si trovano in un simile luogo e non possono andarsene. Quemezzo milione di persone fuggito da Bombay in preda al panico incontrollabile può darci una lontana idea di ciò che provavano, ma forse neppure loro erano in grado di realizzare che cosa stesse provando il mezzo milione di persone che si erano lasciati alle spalle, prigionieri, a fronteggiare quell’orrore strisciante senza possibilità di fuga. Molti anni fa, Kinglake si trovò al Cairo durante un’epidemia di Morte Nera, e aveva provato a immaginare le paure che s’insinuano nel cuore di un uomo in un simile momento, e a seguirlo finché esse stesse generano il fatale segno nel cavo dell’ascella, quindi il delirio che rimescolava le immagini, e i sogni di casa, e turbinosi tavoli da biliardo, e infine l’improvviso vuoto della morte:
«Per il contagista, pieno com’è di terrore delle cause finali, non avendo alcuna fede nel destino, né nella volontà stabilita di Dio, e privo della strafottente indifferenza che potrebbe sostenerlo contro le credenze – per un simile soggetto, ogni cencio che si agita alla brezza di una città colpita dalla peste possiede questo tipo di sublimità. Se, per una qualche terribile ordinanza, egli è costretto ad avventurarsi oltre, vede la morte pendere da qualunque manica; e, mentre avanza lentamente, egli soppesa i suoi tremanti arti inferiori tra la minacciosa giacca che lo pugnala a destra e il mantello di pelliccia che minaccia di farlo secco non appena striscia sulla propria sinistra. Ma più di tutto egli teme ciò che dovrebbe più di tutto amare – il tocco di un vestito femminile; giacché madri e mogli, che si affrettano in benevole commissioni dopo essere state al capezzale dei moribondi, si aggirano per le strade più ostinatamente e con meno cortesia degli uomini. Per un attimo, può essere che la circospezione del povero levantino lo ponga in grado di evitare il contatto, ma presto o tardi la temuta eventualità si verifica; quel lembo di stoffa, con in cima quegli occhi scuri pieni di lacrime, che si affanna in giro con la voluttuosa goffaggine di una Grisi – ha toccato il povero levantino con un angolo della manica! Da quel temuto momento, la sua pace è svanita; la sua mente, costantemente appesa al tocco fatale, attira il soffio che teme; egli vigila sui sintomi della peste con tanta attenzione, che presto o tardi ci casca davvero. La secchezza delle fauci è un segno – le sue fauci sono secche; il cervello pulsante – e il suo pulsa; il battito accelerato – si tasta il polso (giacché non osa chiedere il consiglio di alcun uomo, per paura di essere abbandonato), si tasta il polso, e sente quanto il suo sangue pieno di paura fuoriesca al galoppo dal suo cuore. Manca solo la tumefazione fatale a che la sua triste convinzione sia completa; d’un tratto, egli avverte una strana sensazione sotto il braccio – nessun dolore, soltanto una lieve tensione della pelle; prega Dio che sia la sua immaginazione, tanto forte da dargli quella sensazione; e questo è il peggio. Ora gli sembra che potrebbe essere felice e contento con le sue fauci secche, e il suo cervello pulsante, e il suo battito accelerato, se solo sapesse che non v’è nessuna tumefazione sotto il suo braccio sinistro; ma osa provare? – in un momento di calma e ponderatezza, non osa; ma quando, per un istante, egli si contorce nella tortura dell’incertezza, un’improvvisa forza di volontà lo spinge a cercare e conoscere il proprio destino; si tocca la ghiandola e trova la pelle sana e integra, ma sotto la cute giace un piccolo grumo, simile a una pallottola, mobile al tocco. Oh! Ma è questa, al di là di ogni dubbio, è questa la sentenza di morte? Tasta la ghiandola sotto l’altro braccio. Non c’è esattamente lo stesso grumo, ma uno simile. Non accade forse che le persone abbiano ghiandole naturalmente ingrossate? – volesse il cielo che egli ne facesse parte! Sicché egli compie da sé il lavoro della peste, e quando l’Angelo della Morte, così corteggiato, arriva davvero, deve solo completare ciò che è stato così bene iniziato; egli passa la sua mano di fuoco sul cervello della vittima, e lascia che quest’ultima vaneggi per un po’, in modo del tutto casuale, di persone e cose un tempo care, oppure di persone e cose indifferenti. Il pover’uomo si ritrova a casa nella bella Provenza, e scorge la meridiana del giardino in cui giocava da piccolo – scorge sua madre, e il viso da tempo dimenticato della sua amata sorellina – (la vede, dice, di domenica mattina, perché le campane stanno suonando); scruta in lungo e in largo l’universo, e lo possiede ben accatastato in balle e balle di cotone, cotone eterno – al punto che – sente – sa – giura che potrebbe mandare la palla in buca, se solo il tavolo da biliardo non fosse in pendenza, e se la stecca fosse una stecca con cui vale la pena giocare; ma non lo è – è una stecca destinata a rimanere immobile – anche il suo braccio resterà immobile – insomma, è burrasca nella testa del povero levantino; e forse nel giro di una notte egli diventerà l’“anima” di un’urlante famiglia di sciacalli che lo tirerà fuori per i piedi dal suo sepolcro basso e sabbioso».
MARGUERITE YOURCENAR
L'OPERA AL NERO

Il 1549 esordì con piogge che spazzarono le semine degli ortolani; una piena del
Reno inondò le cantine dove mele e barili mezzo pieni galleggiavano sull'acqua
grigiastra. A maggio, le fragole ancora verdi marcirono nei boschi, le ciliege nei
frutteti. Martin fece distribuire minestre ai poveri sotto il portico di San Gereone; la
carità cristiana e la paura delle sommosse ispiravano ai borghesi elemosine di tal
fatta. Ma quei mali non erano che araldi di una calamità più terribile. La peste,
venuta da Oriente, penetrò in Germania per la Boemia. Viaggiava senza fretta, al
suono delle campane, come un'imperatrice. China sul bicchiere del bevitore,
spegnendo la candela del dotto seduto tra i suoi libri, servendo messa al prete,
nascosta come una pulce nella camicia delle donne di malaffare, la peste inseriva
nell'esistenza di tutti un elemento di insolente uguaglianza, un acre e pericoloso
fermento d'avventura. Il rintocco funebre spandeva nell'aria un insistente rumore di
negra festa: i babbei, raccolti ai piedi dei campanili, non si stancavano di
contemplare, lassù in alto, la sagoma del campanaro, ora accovacciato ora sospeso,
gravante con tutto il proprio peso sul campanone. Le chiese non scioperavano, le
taverne neppure.
Martin si barricò nello studiolo come avrebbe fatto per difendersi da un ladro. A
dargli retta, il miglior profilattico consisteva nel bere moderatamente Johannisberg
di buon'annata, nell'evitare donnacce e compagni di bisboccia, non respirare l'odore
delle strade, e soprattutto non informarsi del numero dei morti. Johanna continuava
ad andare al mercato o a scendere per vuotare le immondizie, il suo volto cucito di
cicatrici, la parlata straniera avevano da sempre irritato i vicini; in quei giorni nefasti,
la diffidenza si mutava in odio, e al suo passaggio si parlava di seminatrici di peste e
di streghe. Lo confessasse o meno, la vecchia fantesca in segreto si rallegrava
dell'avvento del flagello di Dio: terribile gaudio che le si leggeva in faccia; ebbe un
bell'addossarsi, al letto di Salomé gravemente ammorbata, rischiose incombenze che
le altre domestiche rifiutavano: la padrona la respingeva gemendo come se la
domestica invece di una brocca portasse una falce e una clessidra. … La notte successiva alla morte di Salomé, Benedicte distesa accanto alla cugina
avvertì a sua volta i primi sintomi del male. Era divorata da una sete ardente, che seppe attenuare immaginando il cervo biblico intento a bere alla fonte d'acqua viva.
Una tossetta stizzosa le raschiava la gola; la trattenne il più a lungo possibile per non
svegliare Martha. già fluttuava, a mani giunte, pronta a sfuggire dal letto a
colonnine, per ascendere a un grande paradiso luminoso, ov'era Dio. Dimenticati i
cantici evangelici; il volto amico delle sante riappariva tra le cortine; Maria, dal
sommo dei cieli, tendeva le braccia dall'azzurro manto, imitata nel suo gesto dal bel
Bambino paffuto dalle piccole dita rosate. In silenzio, Benedicte si rammaricava delle
proprie colpe: un litigio con Johanna per via di una cuffietta strappata, sorrisi in
risposta alle occhiate di ragazzi che le passavano sotto la finestra, una voglia di
morire non immune da pigrizia, da impazienza di salire in cielo, dal desiderio di non
dover più scegliere tra Martha e i suoi, tra due maniere di parlare a Dio. Martha
cacciò un grido scorgendo il volto devastato della cugina ai primi lucori del mattino…. Nel frattempo, la fanciulla peggiorava. Appoggiata
allo stipite, Martha la vegliava a distanza. Tuttavia, più volte le si accostò per farla
bere con mano tremante. Ormai la malata deglutiva con fatica, il contenuto del
bicchiere colava sul letto. Di tanto in tanto, faceva udire la sua tosse secca e breve,
simile al latrato di un cucciolo; e ogni volta Martha senza volerlo abbassava lo
sguardo per cercarsi attorno alla gonna il cagnolo di casa, rifiutandosi di credere che
quel rantolo animalesco potesse sortire da una così dolce bocca. Finì col mettersi a
sedere sul pianerottolo per non udirlo. Per qualche ora, lottò contro il terrore di
quella morte i cui preparativi avvenivano sotto i suoi occhi, e più ancora contro lo
spavento di essere a sua volta contagiata dalla peste come lo si è dal peccato.
Benedicte non era più Benedicte, bensì una nemlca, una bestia, un oggetto
pericoloso che bisognava guardarsi dal toccare….Martha la vide seppellire il giorno stesso con Salomé nel chiostro delle Orsoline,
anzi come sigillare sotto una menzogna. Nessuno avrebbe saputo mai che Benedicte
era stata lì lì per imboccare la stretta via verso cui la spingeva sua cugina, incedendo
con lei verso la Città di Dio. Martha si sentiva spogliata, tradita. I casi di peste si
facevano rari ma, andando per strade semideserte, continuava a stringersi addosso
con precauzione le falde del mantello. La morte della cuginetta non aveva fatto che
accrescere in lei l'ardente desiderio di continuare a vivere, di non rinunciare a ciò che
era e a ciò che aveva per divenire uno di quei gelidi involti che si depongono sotto la
lastra di una chiesa. Benedicte era morta certa della propria salvezza grazie a
paternostri e avemarie; Martha non poteva nutrire identica fiducia per se stessa;
talvolta le sembrava di essere di quelli che il decreto divino condanna prima della
nascita, e la cui stessa virtù è una forma di caparbietà che dispiace a Dio. Del resto, di
che virtù si trattava? Al cospetto del flagello, era stata pusillanime; non era detto che
di fronte al boia si sarebbe mostrata più fedele all'Eterno che, in tempo di peste, a
quell'innocente che aveva creduto di amare tanto. Ragion di più per ritardare al
massimo il verdetto che non ammette appello.
Italo Calvino
Il Castello dei destini incrociati

Ma la profezia si compie: la peste infesta Tebe, una nuvola di bacilli cala sulla città, inonda di miasmi le vie e le case, i corpi dànno fuori bubboni rossi e blu e cascano stecchiti per le strade, lambendo l'acqua delle pozzanghere fangose con le labbra secche. In questi casi non c'è che ricorrere alla Sibilla Delfica, che spieghi quali leggi o tabù sono stati violati: la vecchia con la tiara e il libro aperto, etichettata con lo strano epiteto di Papessa, è lei. Se si vuole, nell'arcano detto del Giudizio o dell'Angelo si può riconoscere la scena primaria a cui rimanda la dottrina sigismondiana dei sogni: il tenero angioletto che si sveglia nottetempo e tra le nuvole del sonno vede i grandi che non si sa cosa stanno facendo, tutti nudi e in posizioni incomprensibili, mamma e papà e altri invitati. Nel sogno parla il fato. Non ci resta che prenderne atto. Edipo, che non ne sapeva niente, si strappa il lume degli occhi: letteralmente il tarocco dell'Eremita lo presenta mentre si toglie dagli occhi un lume, e prende la via di Colono col mantello e il bastone del pellegrino
Sant'Agostino
Città di Dio

Quell'inverno fu memorabile perché incredibilmente rigido al punto che a causa delle nevi, le quali rimasero a una preoccupante altezza per quaranta giorni anche nel foro, perfino il Tevere gelò. Se si fosse avuto ai nostri tempi, costoro ne avrebbero dette tante e tanto grosse. Allo stesso modo una straordinaria epidemia, finché infierì, ne fece morire molti. Ed essendosi prolungata con maggiore virulenza nell'anno successivo malgrado la presenza di Esculapio, si consultarono i libri sibillini. In questo tipo di oracoli, come ricorda Cicerone nel libro Sulla divinazione, abitualmente si crede di più agli interpreti che spiegano le cose dubbie come possono o come vogliono. Il responso fu che causa dell'epidemia era il fatto che molti occupavano abusivamente parecchi edifici sacri. Così per il momento Esculapio fu scolpato dall'accusa d'incapacità o di trascuratezza. Gli edifici erano stati occupati senza che alcuno lo impedisse perché erano state inutilmente a lungo rivolte suppliche a una così folta moltitudine di divinità. Così un po' alla volta i locali venivano disertati dai devoti in modo che essendo vuoti si potevano senza offesa di alcuno adibire agli usi umani. Per far cessare la pestilenza furono fatti restituire e restaurare. E se in seguito non fossero rimasti sconosciuti perché di nuovo abbandonati e occupati, non si darebbe certamente merito alla grande erudizione di Varrone che scrivendo sugli edifici sacri ne ricorda molti ignorati. In quel caso non si ottenne la fine della epidemia ma per un po' di tempo una diplomatica scusa per gli dèi.
Giovanni Verga
I Malavoglia

A Catania c’era il colèra, sicché ognuno che potesse scappava di qua e di là, pei villaggi e le campagne vicine. Allora a Trezza e ad Ognina, era venuta la provvidenza, con tutti quei forestieri che spendevano. Ma i rigattieri torcevano il muso, se si parlava di vendere una dozzina di barilotti d’acciughe, e dicevano che i denari erano scomparsi, per la paura del colèra. – Che non ne mangia più acciughe la gente? – diceva loro Piedipapera. Ma a padron ’Ntoni, e a chi ne aveva da vendere, per conchiudere il negozio, diceva invece che col colèra la gente non voleva guastarsi lo stomaco con le acciughe, e simili porcherie; piuttosto mangiava pasta e carne; perciò bisognava chiudere gli occhi, ed essere correnti pel prezzo. …Andando per la strada bisognava camminare nel bel mezzo, e lontano dai muri, dove si correva rischio di acchiapparsi mille porcherie; e badare di non mettersi a sedere sui sassi, o lungo i muricciuoli. La Longa una volta, mentre tornava da Aci Castello, col paniere al braccio, si sentì così stanca che le gambe le tremavano, e sembrava fossero di piombo. Allora si lasciò vincere dalla tentazione di riposare due minuti su quelle quattro pietre liscie messe in fila all’ombra del caprifico che c’è accanto alla cappelletta, prima d’entrare nel paese; e non si accorse, ma ci pensò dopo, che uno sconosciuto, il quale pareva stanco anche lui, poveraccio, c’era stato seduto pochi momenti prima, e aveva lasciato sui sassi delle gocce di certa sudiceria che sembrava olio. Insomma ci cascò anche lei; prese il colera e tornò a casa che non ne poteva più, gialla come un voto della Madonna, e colle occhiaie nere; talché la Mena che era sola in casa, si mise a piangere al solo vederla, e la Lia corse a cogliere dell’erba santa, e delle foglie di malva. Mena tremava come una fronda, mentre faceva il letto; eppure l’ammalata, seduta sulla scranna, stanca morta, col viso giallo e le occhiaie nere, badava a dirle: – Non è nulla, non vi spaventate: quando mi sarò messa in letto ogni cosa passerà, – e cercava di aiutare anche lei, ma ad ogni momento le mancavano le forze, e tornava a sedersi. ….In quel tempo non andavano intorno né medico né speziale dopo il tramonto; e le vicine stesse si sprangavano gli usci, per la paura del colèra, e ci incollavano delle immagini di santi a tutte le fessure. Perciò comare Maruzza non poté avere altro aiuto che dei suoi, poveracci, i quali correvano per la casa come pazzi, al vederla andarsene in tal modo, in quel lettuccio, e non sapevano che fare, e davano della testa nelle pareti. Allora la Longa vedendo che non c’era più speranza, volle che le mettessero sul petto quel soldo di cotone coll’olio santo che aveva comperato a Pasqua, e disse pure che lasciassero la candela accesa, come quando stava per morire padron ’Ntoni, ché voleva vederseli tutti davanti al letto, e saziarsi di guardarli ad uno ad uno con quegli occhi sbarrati che non ci vedevano più. La Lia piangeva in modo da spezzare il cuore; e tutti gli altri, bianchi come un cencio, si guardavano in faccia quasi chiedendosi aiuto l’un l’altro; e si stringevano il petto per non scoppiare a piangere davanti alla moribonda, la quale nondimeno se ne accorgeva bene, sebbene non ci vedesse più, e nell’andarsene le rincresceva di lasciare così desolati quei poveretti. Li andava chiamando per nome ad uno ad uno, colla voce rauca; e voleva alzare la mano, che non la poteva più muovere, per benedirli, come se sapesse di lasciare loro un tesoro. – ’Ntoni! ripeteva, colla voce che già non si sentiva più, ’Ntoni! A te che sei il maggiore raccomando questi orfanelli! – E sentendola parlar così, mentre era ancor viva, tutti gli altri non poterono trattenersi di scoppiare a piangere e singhiozzare.
Così passarono tutta la notte davanti al lettuccio, dove Maruzza non si muoveva più, sin quando la candela cominciò a mancare e si spense anch’essa, e l’alba entrava dalla finestra, pallida come la morta, la quale aveva il viso disfatto e affilato al pari di un coltello, e le labbra nere. Sul tardi vennero a pigliarsi la Longa in fretta e in furia, e nessuno pensò a fare la visita del morto; che ciascuno pensava alla pelle, e lo stesso don Giammaria rimase sulla soglia, quando spruzzò l’acqua santa coll’aspersorio, tenendo raccolta e sollevata la tonaca di san Francesco, – da vero frate egoista che era! – predicava lo speziale. Lui invece, se gli avessero portato la ricetta del medico per qualche medicina, avrebbe aperto la spezieria anche di notte, che non aveva paura del colèra; e diceva pure che era una minchioneria di credere che il colera lo buttassero per le strade e dietro gli usci. – Segno che è lui che sparge il colèra! – andava soffiando don Giammaria. Per questo nel paese volevano fargli la festa allo speziale; ma lui si metteva a ridere come una gallina, preciso come faceva don Silvestro, e diceva: – Io che sono repubblicano! Se fossi un impiegato, o qualcuno di quelli che fanno i tirapiedi al governo, non direi!... – Ma i Malavoglia rimasero soli, davanti a quel lettuccio vuoto.

Ecco un altro accrescimento di male che mi colse in seguito al resto. Tanto fuori che dentro la mia casa fui assalito da una peste violenta quant’altre mai. Di fatto, come i corpi sani sono soggetti a più gravi malattie, poiché non possono esser vinti che da quelle, così la mia aria oltremodo salubre, dove a memoria d’uomo il contagio, benché vicino, non aveva mai potuto prender piede, venendo a infettarsi, produsse effetti straordinari: Mista senum et iuvenum densantur funera, nullum Sæva caput Proserpina fugit. Dovetti sopportare questa piacevole situazione: che la vista della mia casa mi riempiva di terrore. Tutto quello che vi si trovava era senza custodia e abbandonato a chiunque ne avesse voglia. Io che sono tanto ospitale fui in estrema difficoltà per trovare un asilo per la mia famiglia. Una famiglia sbandata, che faceva paura ai suoi amici e a se stessa, e orrore dovunque cercasse di fermarsi, costretta a cambiar dimora appena uno della compagnia cominciava a sentir male alla punta d’un dito. Tutte le malattie sono prese per peste: non ci si dà il tempo di riconoscerle. E il bello è che, secondo le regole dell’arte, a qualsiasi sintomo che si manifesti bisogna star quaranta giorni con la paura di quel male, mentre intanto l’immaginazione vi tormenta a suo piacere e fa ammalare la vostra stessa salute. Tutto questo mi avrebbe toccato molto meno se non avessi dovuto preoccuparmi per la pena altrui, e per sei mesi servir miserabilmente di guida a questa carovana. Poiché io porto in me le mie difese, che sono fermezza e sopportazione. La paura, che si teme particolarmente in questo male, non mi tormenta affatto. E se, essendo solo, avessi voluto prenderlo, sarebbe stata una fuga ben più risolutiva e lontana. È una morte che non mi sembra delle peggiori: è di solito breve, con stordimento, senza dolore, consolata dalla condizione comune, senza cerimonia, senza lutto, senza folla.
Diogene Laerzio
Vite dei Filosofi

Del modo in cui salvò gli Ateniesi dalla peste
In quel tempo, agli Ateniesi tormentati dalla peste la
Pizia ingiunse con un oracolo di purificare la città. Essi allora
mandarono ,una nave e anche Nicia, figlio di Nicerato, a
Creta, per fare appello a Epimenide. Ed egli, giunto nella
quarantaseiesima Olimpiade, purificò la loro città e fece
cessare la pestilenza in questo modo. Prese delle pecore sia
nere sia bianche e le condusse sulla collina di Ares; e, da là, le lasciò andare dove volessero, dopo avere comandato a coloro che le conducevano che là dove ciascuna di esse si
coricasse, venisse offerta in sacrificio al dio del luogo. E in
tal modo fece cessare il male. Perciò, ancora oggi, è possibile
trovare, disseminati per i demi degli Ateniesi, altari anonimi,
a ricordo della propiziazione che avvenne allora. Altri invece
dicono che la Pizia avrebbe dichiarato che causa della
peste era il sacrilegio di Cilone e avrebbe indicato il mezzo
per liberarsi da essa. E per. questo, sarebbero stati messi a
morte due giovani, Cratino e Ctesibio, e il caso sarebbe stato
risolto. Gli Ateniesi decretarono quindi di dargli up
talento, e unii nave che la riconducesse a Creta. Epimendine, però, non accettò il denaro, ma fece concludere un'amicizia e un'alleanza tra gli abitanti di Cnosso e quelli di Atene.

Qui un tempo per infezione del cielo sorse una miseranda stagione, e arse per tutto il calore dell’autunno, e diede a morte ogni specie di animali e di fiere, inquinò i laghi, fece imputridire i pascoli. Non era semplice la via della morte; ma quasi un’ardente sete penetrata in tutte le vene aveva contratto i miseri arti, di contro abbondava a fiotti un sudore e a gradi assorbiva in sé le membra disfatte dal morbo. Spesso in un rito per gli dèi, stando nel mezzo la vittima presso l’ara, mentre la benda di lana viene cinta al niveo nastro, cadde morente fra l’esitare dei celebranti, o se altra ne aveva abbattuta prima il sacerdote, non ne ardevano le fibre poste sui sacri altari, né l’indovino consultato poteva rendere responsi, i coltelli conficcati nella gola si tingevano appena di sangue e la superficie della terra si macchiava di uno scarso putridume. Così i vitelli muoiono fra le erbe rigorose ed esaltano le dolci anime presso le greppie ricolme; così la rabbia coglie i festoni cani, e un’ansante tosse scuote i maiali infermi e li strozza con il gonfiore delle fauci. Scivola sventurato, immemore di bravure e di erba, il cavallo vittorioso, rifugge dalle fonti, e batte spesso il terreno con lo zoccolo, le orecchie abbassate; ivi intorno uno strano sudore, che poi fa freddo in punto di morte; arida la pelle, dura, e resistente al tatto. Mostrano questi segni nei primi giorni avanti la morte. Se invece il morbo incrudelisce in un luogo decorso, allora gli occhiali divampano, il respiro è tratto dal profondo, talvolta incupito da un lamento, e il basso ventre si tende in un singulto; esce dalle narici un tetro sangue, e la ruvida lingua preme ostruendo le fauci. Giovò versare da un corno inserito in bocca liquore leneo; questa si credette l’unica salvezza ai cavalli morenti. Ma ciò stesso risultava subito esiziale: rianimati ardevano in furia, e da soli sulla soglia d’una misera morte (o dèi, date sorte migliore ai buoni, una tale follia ai nemici!) laceravano con i denti nudi le proprie membra, squarciandole. Ed ecco fumante sotto il duro aratro abbattersi il toro e vomitare sangue misto a schiuma e levare gli estremi lamenti. Va l’aratore sgomento, distaccando il giovenco mesto per la morte del fratello, e lascia l’aratro conficcato in terra e l’opera sospesa. Non riescono a sollevare l’animo le ombre degli alti boschi, i molli prati o un torrente che scende tra le rocce in pianura, più puro dell’ambra; ma i fianchi si allentano e cadono, uno stupore preme gli occhi immobili, la testa si piega al suolo inclinata dal proprio peso. A che giovano il lavoro e i meriti? e aver rivoltato In tempo non diverso, dicono, furono cercate invano in quelle contrade giovenche per un rito a Giunone, e con bufali ineguali condotti carri agli alti santuari. Dunque graffiano penosamente la terra con rastrelli, e con le stesse unghie v’infossano il seme della mèsse, e per erti monti traggono cigolanti carri con strappi del collo. Non tenta agguati il lupo intorno agli ovili, non erra di notte intorno ai greggi: un affanno più aspro lo doma; i timidi daini e i cervi fugaci vagano ora tra i cani e attorno alle case. Ormai le parole dell’immenso mare e tutta la stirpe dei natanti è bagnata dalle onde sull’orlo della riva al pari di naufraghi corpi; fuggono insolite verso i fiumi le foche. Muore anche protetta invano dai tortuosi nascondigli la vipera, e gli storditi serpenti dalle irte squame. Non è buona l’aria per gli stessi uccelli, ed essi lasciano cadendo a precipizio la vita sotto un’alta nube. Inoltre ormai non serve mutare pascoli, i ricercati rimedi nuocciono; i maestri rinunziarono: il filliride Chirone, l’amitaonio Melampo. Incrudelisce, e suscita dalle tenebre della Stige alla luce, la pallida Tisifone spinge innanzi i Morbi e la Paura, e di giorno in giorno sorgendo innalza l’avida testa. Risuonano del belato delle pecore e di frequenti muggiti i fiumi, e le rive inardite, e i colli distesi. Ormai il morbo mena strage a mucchi, e anche nelle stalle accumula cadaveri sfatti da orrenda putredine, finché si apprende a coprirli di terra e a nasconderli nelle fosse. Non era più usabile il cuoio, nessuno poteva detergere con acqua le carni o purgarle alla fiamma; e nemmeno tosare le lane corrose dal male e dal sudiciume, e, ove tessute, toccare quelle putride tele; ma se anche qualcuno provava quei panni nocivi, brucianti pustole e un sudore immondo coprivano le sue fetide membra, e poi senza lungo indugio di tempo il fuoco sacro divorava le membra contagiate.

E ora un altro posto, gente che indossava maschere protettive, centinaia di persone che si muovevano all’altezza dell’obiettivo, chi camminava, chi veniva trasportato da altri. Di cosa si trattava? Di una malattia? Un virus? Vaste schiere di uomini e donne che si muovevano lentamente. Ma cos’è? Un’epidemia diffusa da insetti o parassiti, che viaggia con la polvere? Individui con lo sguardo spento, migliaia ormai, che avanzavano provati, in un tempo che sembrava eterno.
Poi una donna seduta sul tetto della sua macchina, con la testa fra le mani, mentre un incendio – di nuovo le fiamme – scendeva lungo colline pedemontane poco distanti.
Poi incendi che si propagavano per le pianure e una mandria di bisonti, che si stagliavano in controluce sullo sfondo delle fiamme e procedevano al galoppo parallelamente a una recinzione di filo spinato uscendo dall’inquadratura.
Poi improvvisamente gigantesche onde oceaniche che si avvicinavano, acqua che s’infrangeva impetuosa contro gli argini e una serie di immagini che si fondevano le une con le altre, abilmente montate, ma difficili da assimilare, torri che remavano, un ponte che crollava, un primo piano spaventoso sulla cenere e la lava che eruttavano da un’apertura della crosta terrestre e io avrei voluto che durasse piú a lungo, era proprio lí, un po’ piú in alto rispetto a me, lava, magma, roccia fusa, ma dopo pochi secondi è comparso il bacino asciutto di un lago da cui spuntava un tronco d’albero ritorto e poi di nuovo incendi indomabili nei boschi e in aperta campagna che si allargavano verso la città e sulle autostrade.
Poi lunghe riprese di colline boscose che venivano inghiottite da ondate di fumo e dei pompieri, casco in testa e zaino in spalla, che scomparivano su per un sentiero di montagna e ricomparivano in un bosco di pini dalla corteccia spaccata e tutto attorno terra nuda del colore del bronzo.
Poi, in primo piano, lo schermo quasi sul punto di scoppiare per le fiamme che saltano sopra un torrente e compaiono di nuovo balzando verso la telecamera e poi fuori, nel corridoio dove sono io fermo a guardare.
Federico De Roberto
I vicerè

«Il castigo di Dio!… Tutta colpa dei nostri peccati!… Eran più di anni che vivevamo tranquilli! Assassini del governo!… » La povera gente seguiva a piedi i carrettelli carichi di due magri sacconi e di quattro seggiole sciancate; e nelle brevi soste fatte per riprender fiato, per asciugar il sudore grondante dalle fronti terrose, scambiava commenti sulle notizie del colera, sull'origine della pestilenza, sulla fuga universale che spopolava la città. I più credevano al malefizio, al veleno sparso per ordine delle autorità; e si scagliavano contro gl'«italiani», untori quanto i borboni. Al Sessanta, i patriotti avevano dato a intendere che non ci sarebbe stato più colera, perché Vittorio non era nemico dei popoli come Ferdinando; e adesso, invece, si tornava da capo! Allora, perché s'era fatta la rivoluzione? Per veder circolare pezzi di carta sporca, invece delle belle monete d'oro e d'argento che almeno ricreavano la vista e l'udito, sotto l'altro governo? O per pagar la ricchezza mobile e la tassa di successione, inaudite invenzioni diaboliche dei nuovi ladri del Parlamento? Senza contare la leva, la più bella gioventù strappata alle famiglie, perita nella guerra, quando la Sicilia era stata sempre esente, per antico privilegio, dal tributo militare? Eran questi tutti i vantaggi dell'Italia una?… E i più scontenti, i più furiosi, esclamavano: «Bene han fatto i palermitani, a prendere i fucili!… » Ma la rivolta di Palermo era stata vinta, anzi la pestilenza, secondo i pochi che non credevano al veleno, veniva di lì, importata dai soldati accorsi a sedare l'insorta città… E sui monticelli di breccia disposti lungo la via, al filo d'ombra proiettata dai muri, dalla cui cresta sporgevano le pale spinose dei fichi d'India, i fuggenti sedevano un poco, discutendo di queste cose, mentre continuava la sfilata delle carrozze, dei carri e dei pedoni non ancora stanchi. Alcuni tra questi, i più poveri, avevano caricato tutta la loro roba sopra un asinello, e uomini, donne e bambini seguivano a piedi, con fagotti di cenci in capo, o sotto il braccio, o infilati ad un bastone, la bestia lenta e paziente. I conoscenti si fermavano, notizie e commenti erano scambiati anche tra sconosciuti, con la solidarietà del pericolo nella comune miseria. Le donne ripetevano ciò che avevano udito dire dai preti: il colera era la pena dei tempi peccaminosi: gli scomunicati non avevano fatto la guerra al Papa? La Chiesa non era perseguitata? E adesso, per colmar lo staio, c'era la legge che spogliava i conventi! La fine del mondo! L'anno calamitoso! Chi avrebbe creduto una cosa simile! Tanti poveri monaci buttati in mezzo a una via? I luoghi santi sconsacrati? Non c'è più dove arrivare!… Queste erano sciocchezze, giudicavano invece gli uomini. I monaci avevano assai scialato senza far nulla! Mangiavano a ufo! E i muri dei conventi, se avessero potuto parlare, ne avrebbero dette di belle. Era tempo che finisse la cuccagna! L'unica cosa fatta bene dal governo!… Però, tanti santi Padri, che ce n'erano, costretti a vivere con una lira al giorno!
Amitav Ghosh
L’isola dei Fucili

«Nel 1629 i soldati tedeschi portarono la pestilenza a Milano, e nel giro di poche settimane morirono diecimila persone. Poi il morbo passò di città in città: da Mantova a Padova e poi a Venezia, dove a quanto pare fu introdotto da un diplomatico.
«Per Venezia non era la prima volta. In passato c’erano state altre epidemie, da cui i veneziani avevano tratto insegnamento: erano stati pubblicati diversi trattati su come affrontare la peste, e fin dal Quattrocento esisteva una commissione sanitaria permanente. Si potrebbe anzi dire che i protocolli moderni per evitare il diffondersi del contagio siano stati inventati a Venezia. Perciò, quando nel 1630 scoppiò la grande pestilenza, i notabili della città reagirono con prontezza».
Mi toccò un braccio, come per trattenermi dal saltare a conclusioni affrettate.
«Dino, non pensare che i consiglieri comunali fossero dei creduloni. Molti di loro avevano studiato all’Università di Padova, che era un grande centro del razionalismo – ci aveva insegnato Galileo, e la sua dottrina sull’ordine della natura per loro era vangelo. Erano simili agli odierni burocrati dell’Unione Europea: amministratori istruiti e competenti che non si abbandonavano a voli di fantasia. La loro fede nel potere della ragione umana era sconfinata.
«Si misero subito all’opera adottando una lunga serie di contromisure. Vennero imposti coprifuochi e quarantene: tutti coloro che sembravano aver contratto la malattia venivano trasferiti su una certa isola, mentre i pochi che guarivano venivano spostati su un’altra isola ancora. Tutti i luoghi pubblici furono chiusi e alla gente fu vietato uscire di casa; solo i soldati potevano muoversi liberamente. Le strade erano così deserte che fra le pietre del selciato cominciò a spuntare l’erba. Ufficiali giudiziari appositamente nominati giravano di casa in casa col volto celato da maschere a forma di becco, disinfestando con fumigazioni e cercando i segni del contagio.
«Ma la pestilenza sembrava inarrestabile. Le persone morivano a migliaia, manovali e pescivendole, preti e nobildonne, e anche i probiviri più illustri non venivano risparmiati. In pochi mesi la città perse un quarto della sua popolazione. Le chiatte che portavano via i morti non bastavano, e così i canali si riempirono di cadaveri. All’Arsenale, dove ora si tengono mostre d’arte, i corpi venivano ammucchiati uno sull’altro, e non si trovavano uomini a sufficienza per cospargerli di liscivia.
«Ma nel mezzo di quell’orrore c’era un minuscolo angolo della città, una calle chiamata Corte Nova, rimasto pressoché immune dal contagio. Una giovane che vi abitava aveva dipinto un quadro della Vergine Maria e l’aveva appeso all’ingresso della corte, dicendo che la peste non sarebbe passata oltre la Madonna, e stranamente, miracolosamente, gli abitanti di quella viuzza non si ammalavano.
«La Vergine Maria era sempre stata molto venerata dai veneziani, e a quel punto la popolazione si rivolse a lei implorando la salvezza. Anche i notabili della città, quegli uomini esperti e razionali, riconobbero la propria assoluta impotenza, e deliberarono di costruire una grande chiesa dedicata alla Madonna. E quando, subito dopo, il morbo si svigorì, tutti dissero che quel miracolo era opera di Santa Maria della Salute».
Francesco Mastriani
I misteri di Napoli – Il Colera

Il morbo terribile che si avvolgea misteriosamente nella caliginosa nebbia venuta dalle Imalaie si nomava colèra. In sullo scorcio del 1850, l'esercito russo richiamato dall'Asia
sparse e diffuse la desolazione e la morte sul vastissimo territorio della Russia e sulle belle provincie polacche, le quali, di fresco sollevatesi contro il loro despota dominatore, e soggiogate dalle falangi moscovite, attribuirono a nefanda vendetta del Russo il nuovo flagello che le colpiva.
Intanto, gli uomini della scienza già cominciavano a perdere il capo per indagare la natura dello straordinario veleno che sì prestamente mieteva tante vittime. E chi sosteneva la sua opinione che il colèra fosse epidemico dallo scorgere il cammino che questo avea percorso per giungere dalla grande Asia sino alla Europa settentrionale, ed altri invece appoggiava la sua opinione sulla natura contagiosa del male, mostrando il fatto dell'esercito russo che l'avea seco menato in Europa dall'Asia, donde era stato richiamato. E moltissimi adoprarono il loro ingegno ad indagare le ragioni endemiche
del morbo e del suo modo di diffusione e ricercavano nella scienza i mezzi di allontanarlo e di debellarlo. Si scrissero in quel tempo numerosi opuscoli, quando ancora la nebbia fatale non avea colpito che una parte di Europa, lontana ancora da' centri di popolazione e di civiltà. Quasiché il colèra seguisse i lenti passi di un uomo che percorresse a piedi l'un paese dopo l'altro, camminava progressivamente investendo villaggi e paesi l'un dopo l'altro-, in guisa che dalle Provincie polacche scese sulla limitrofa Germania e nel 1832, la capitale dell'Austria, Vienna, fu investita dal morbo, e per vari mesi non poche migliaia di vittime furono mietute dalla falce di morte.
Il terrore si spargea sempre più in Europa : l'arcana natura del male, il suo lento e misterioso cammino, cui nessun cordone sanitario arrestava, la inefficacia de' rimedi, l'impotenza della scienza, gli spaventevoli fenomeni che accompagnavano i casi di morte, tenevano tutta Europa in gran trepidanza, e le immaginazioni riscaldate dalla paura si esageravano le cose^ e già si foggiavano del colera una peste più terribile di quella che avea travagliato nel decimosettimo secolo le principali città d'Italia.
Dalla Vistola e dal Danubio , il morbo corre rapidamente sulle rive della Senna. E, nello stesso anno 1832, Parigi fu per la prima volta visitata dall'ospite terribile che camminava avvolto nella nebbia misteriosa, come il fulmine di Dio che si nasconde nella elettrica nube. Né soltanto Parigi, la città del brio , vide in quell’anno sparire dal suo suolo molte e molte migliaia di abitanti; ma eziandio Marsiglia, Tolone ed altre moltissime città della Francia pagarono il loro tributo all'inesorabile angelo dello esterminio.
La presenza così vicina dell'ignoto nemico tremar facea le cento città d'Italia. Le gazzette di Francia, pria vietate per allontanare una causa di contagio e poscia sottoposte a svariati modi di disinfezione, erano ricercate e lette con avidità. Ognuno vedea la possibilità anzi la certezza che il fiero morbo venisse a visitare la penisola italica pur non dimeno ognuno si lusingava ancora che la nebbia fatale non sarebbe discesa a coprire il bel cielo d'Italia , e che le soavi profumate ebbrezze de' mari incantati che circondano le belle spiagge esperidi e la mitezza dell'aria e il sorriso di natura che bea le belle nostre contrade avrebbero fugata la pestifera lue. Così fatte speranze caddero nel più amaro disinganno quando si seppe che il fiero nemico era comparso nella bella città di Nizza e nella provincia di Cuneo. Rapidissimo fu il suo passaggio da Cuneo a Torino, a Genova, a Livorno, a Milano, a Parma, indi il morbo risalì d'un salto a Trieste, e poi giù in Dalmazia; passò l'Adriatico, e assaltò Ancona, e poco stante si vide apparire su le Murgie e minacciare la Capitanata e il regno di Napoli…..
La scienza medica ha dichiarato la sua impotenza contro il morbo asiatico. Che cosa è questa malattia? dove risiede? quale parte dell'organismo umano investe primamente? quale causa efficiente la fa nascere e sviluppare? Tutto ciò è rimasto ignoto.
È sempre nelle pesti il fatale che sfugge agli occhi dell'umana scienza.
Due terribili flagelli mietono le generazioni, la guerra e la peste. Entrambi sono figli della umana nequizia , colla differenza che il primo è creato direttamente dall'uomo, il secondo indirettamente. La Guerra è flagello volontario ; la Peste, involontario.
Spesso la peste vien dietro alla guerra : è la gran punizione di quel gran delitto.
Né si obbietti che la guerra è opera di due o tre coronati. I popoli che si sgozzano tra loro sono solidali di questa grande scelleraggine. Nessun popolo veramente civile dovrebbe permettere la guerra. Le grandi sventure smascherano i popoli come gl'individui. Quando un pericolo sovrasta, i popoli, al pari degl'individui, non si possono contenere di mostrarsi a nudo. Il pericolo è come un lampo che disegna tutti i profili dell'anima. Gli animi grandi s'ingrandiscono maggiormente, i piccini vie più s'impiccioliscono. Mettete un uomo al cospetto della morte, ed egli vi si mostrerà tale qual'è. Quelli che dicono di non credere a Dio caggiono nelle più ridevoli superstizioni non appena sono travagliati da un mal di capo. Ne abbiamo veduti di questi spiriti forti ne' pericoli di morte terrorizzati a segno da chiedere colla più angosciosa sollecitudine un padre confessore.
Non pochi famosi tiranni, distruttori di uomini, si andavano a gittare genuflessi a' pie' delle immagini sante quando udivano per l'aere il rombo del tuono o vero quando i loro occhi erano colpiti dalla livida luce de' lampi. Non ci è che il Giusto, che guardi con serena imperturbabilità la faccia della morte. Le bassezze e le codardie del cuore umano vengono a galla, quando il fondo melmoso della vita è agitato da violenta bufera.
Allorché la morte passeggia su i campi della creazione, lo spavento invade le ossa de' viventi. Fuggono gli animali quasi impazzati e l'uomo con occhi smarriti e con viso bianco di paura sembra che schivi il contatto del suo simile.
La mente più non ragiona sotto l'incubo del terrore. I sonni sono interrotti da rimbalzi nervosi, i sogni, conturbati da sinistre fantasime.
Ogni altro pensiero è messo da banda. L' animo è tutto assorto nella perplessità e nelle paure. A guisa della farfalla che non può contenersi di battere le ali intorno alla fiammella della candela, a cui alla fine s'incende, la paura fa ricercare con avida curiosità le notizie che l'alimentano, l'accrescono e la rendono agonia.
L'avaro sospende di pensare a' suoi tesori il libidinoso, a' suoi piaceri- l'ambizioso, al suo ingrandimento — Che io mi salvi da questa minaccia di morte — dice ciascheduno di loro tra se— e poi, ritornerò a bearmi nella vista delle mie arche e poi, ritenterò l'onestà di quella tale donzella-, e poi, riprenderò le pratiche, le quali debbono spingermi in alto.
La paura piglia tanti e si diversi aspetti, fa nascere così novelle e strane trasformazioni.
Quel cuore, cui nulla era capace di riscuotere nella sua marmorea immobilita, freme, trasalisce, agghiaccia, e spande i suoi lividori in sul sembiante. E le rose, che pel consueto coloravano quelle guance per insultante salute, ora cedono il posto alla plumbea tinta dello spavento. Le chiome asperse di odori giaccion neglette e snodate in su gli omeri. I salotti pomposi di lusso sono deserti e silenziosi. La vita è sospesa in una paralisi……I padri e le madri tenerissime non sanno più schiodare gli occhi appaurati dalla carissima loro prole. Domani, stasera forse, tra un'ora, il diletto figliuolo può essere strappato da inesorabile morte ! E ogni giorno, ogni ora, ogni istante, è lo stesso pericolo, la stessa angoscia di paura. E chi potrebbe dire della straziante perplessità di quella madre, che vede per insolito languore chinar la fronte della vergine figliuola e impallidire e trambasciare e venir manco su i ginocchi ? Se si prenda in considerazione 1' agonia dolorosissima de' viventi sotto questo incubo giornaliero , crediamo che non valga infatti la vita più che la morte, e che men da compiangere sieno i trapassati che quelli che calpestano ancora la terra.
I cuori meschini tremano per sé.
I cuori sensitivi ed amanti non tremano per sé, ma pe' loro cari.
I cuori nobili e generosi sono compostamente afflitti delle lacrime altrui e della comune calamità.
II Giusto piega la fronte a' decreti di Dio, e ne aspetta rassegnato il compimento.
Elif Shafak
La città ai confini del cielo

Prima dei festeggiamenti per la circoncisione, venne la peste. All’inizio al limitare della città, nei tuguri vicino al porto di Scutari; poi si diffuse più rapida di un incendio scatenato, balzando da una casa all’altra, la maledizione sparsa nel vento. La morte si posò su Istanbul come una nebbia che non vuole alzarsi, filtrando in ogni buco, in ogni fessura. Volteggiava nella brezza marina, schiumava nel lievito del pane, sobbolliva nel denso caffè amaro. A poco a poco la gente smise di andare in giro; evitando gli assembramenti, sprofondò nella solitudine. I tonfi dei remi e i mormorii dei rematori non si sentivano nemmeno nelle sere più tranquille. Nessuno desiderava passare da una riva all’altra se proprio non doveva. Gli abitanti di Istanbul non avevano mai avuto così paura di trovarsi in mezzo alla folla. Non avevano mai avuto così paura di offendere Dio.
Perché era irritabile, il Dio dei primi giorni della peste. Erano tutti preoccupatissimi di farsi sfuggire la parola sbagliata dalle labbra, che la mano sbagliata toccasse loro la pelle, che l’odore sbagliato riempisse loro le narici. Chiusero a chiave le porte e oscurarono le finestre per evitare i raggi del sole che diffondevano la malattia. Ciascun quartiere divenne isolato, ciascuna strada una cittadella oltre la quale nessuno si avventurava. Parlavano sottovoce, curvavano le spalle e si vestivano con panni semplici, avvolti nella modestia. Il lino fine fu scambiato con tessuto ruvido; i copricapi complicati furono abbandonati. Le monete d’oro – gettate in vasi, chiuse in scrigni – vennero sepolte in buchi profondi. Le mogli dei ricchi nascosero i gioielli e scivolarono negli abiti delle domestiche nella speranza di ottenere il favore di Dio. Furono fatte promesse di andare in pellegrinaggio alla Mecca l’anno dopo e di dar da mangiare ai poveri in Arabia. Istanbul contrattava con Dio: offriva abitudini, offriva agnelli sacrificali, offriva preghiere, perdeva, perdeva.
Yumrucuk, si chiamavano: un nome troppo grazioso per i ponfi che comparivano alle ascelle, sulle cosce e sul collo delle vittime, e a guardarli da vicino c’era chi credeva che recassero impresso il volto inconfondibile di Azrael. Uno starnuto era un brutto segno: la gente trasaliva nel sentirne uno. Era così che cominciava. Sul corpo si formavano bolle che diventavano in fretta più grandi e scure. Poi veniva la febbre, il vomito.
Era nel vento, dicevano; l’aria della notte, sudicia, era infestata dal miasma. Le stanze in cui le vittime incontravano la fine venivano ripulite con aceto, imbiancate a calce, spruzzate di acqua santa della Mecca, poi abbandonate. Nessuno voleva indugiare in un luogo infestato da un fantasma risentito.
Che anche i ricchi e i potenti morissero era di consolazione per alcuni, un segnale di disperazione per altri. Quando un uomo si ammalava, le mogli cominciavano a litigare su chi dovesse curarlo. Di solito se ne occupava la moglie più vecchia, o la sterile, se ce n’era una. A volte veniva chiamata una concubina. C’erano uomini che avevano quattro mogli e una decina di concubine ma comunque esalavano l’ultimo respiro da soli.
I cadaveri venivano portati via su carri trainati da buoi, il cigolio delle ruote pulsava sull’acciottolato e un aroma acuto aleggiava ovunque. I cimiteri sui fianchi delle colline si riempirono e si gonfiarono come le pecore sgozzate, spellate e appese sugli alberi a Eid. A ogni nuova fossa i becchini scavavano più a fondo e più in largo, e seppellivano i corpi a decine. Si tenevano per sé il fatto che molti morti non erano stati lavati né avvolti nel sudario. Alcuni Alcuni venivano consegnati al riposo senza nemmeno una lapide. Il dolore era un lusso che pochi potevano concedersi. La morte doveva smettere di tormentare i vivi perché i morti venissero pianti a dovere. Quando la peste se ne fosse andata, solo allora parenti e amici si sarebbero battuti il petto e avrebbero versato lacrime come il cuore desiderava. Per il momento, il dolore era messo sotto conserva, stipato vicino alla carne salata e ai peperoni secchi nelle cantine, in modo da potervi attingere in tempi migliori.
Le navi venivano rimandate indietro senza scaricare la merce; le carovane ricevevano l’ordine di cambiare percorso. La malattia si era diffusa dall’Ovest, come tutti i mali. Da ovunque arrivassero, i viaggiatori venivano guardati con sospetto. Fuggiaschi, dervisci itineranti, nomadi, vagabondi, zingari: i senza radici erano sgraditi.
A metà estate la malattia colpì il gran visir Ayas Pasha, un uomo ritenuto potentissimo. La sua morte sconvolse il palazzo. All’improvviso le pareti della dimora reale non erano più abbastanza robuste da tenere a bada il contagio. La stessa settimana quattro concubine si ammalarono, una paura più scura del kohl vorticava nei corridoi dell’harem. Dicevano che Hurrem si era chiusa in una stanza con i suoi figli e si rifiutava di vedere altri se non il sultano. Cucinava da sé, si bolliva l’acqua, si lavava perfino i vestiti, diffidando dei servi.
Nel serraglio morirono tre stallieri, tutti nella primavera della vita. E Taras il siberiano rimase chiuso nel suo capanno per giorni, perché tutti lo odiavano, vecchio e fragile com’era, e ancora vivo. Passati erano i giorni in cui la gente non voleva essere vista per le strade, la discrezione gettata al vento. Correvano nelle moschee, nelle sinagoghe e nelle chiese per pregare e pentirsi, pentirsi e pregare. I loro peccati avevano portato la calamità, quelli che avevano commesso ed erano certi di commettere. Era l’ira di Dio. La carne era debole. Non c’era da stupirsi se fiorisse di rose nere. Jahan ascoltava quelle parole, il cuore in gola, convinto e incredulo. Dio aveva creato gli umani, con le loro debolezze, solo per punirli?
«Abbiamo passato il limite» dicevano gli imam. «Il peccato è entrato nel mondo» dicevano i sacerdoti. «Dobbiamo pentirci» dicevano i rabbini. E la gente lo faceva, a frotte di migliaia. Molti divennero bigotti: nessuno più del sultano. Il vino fu proibito, i produttori di vino puniti; gli strumenti musicali furono arsi nei falò, le taverne vennero chiuse, i bordelli sprangati, le fumerie d’oppio rimasero vuote come noci secche. I predicatori parlavano solo di pestilenza ed empietà e del fatto che erano intrecciate come i capelli di un’odalisca.
Poi, come in coro, la gente smise di accusarsi. Erano altri che avevano portato l’epidemia in città, altri con la loro empietà e corruzione. La paura si mutò in rancore; il rancore in rabbia. E la rabbia era una sfera di fiamme che non si poteva tenere in mano a lungo; doveva essere gettata addosso a qualcuno.
A fine luglio una folla inferocita entrò nel quartiere ebraico attorno alla Torre di Galata. Le porte furono segnate col catrame, uomini furono picchiati, un rabbino che oppose resistenza fu bastonato a morte. Un calzolaio ebreo fu accusato di aver avvelenato tutti i pozzi e le cisterne e i ruscelli di Istanbul, diffondendo la malattia. In decine erano stati arrestati e avevano già confessato il loro crimine. Che le confessioni fossero state ottenute sotto tortura era un dettaglio a cui nessuno badava. Gli ebrei non erano stati espulsi dalle città sassoni solo pochi anni prima, molti di loro non erano stati arsi al rogo nelle terre del Frangistan? C’era una ragione per cui portavano calamità ovunque andassero, un cattivo presagio li seguiva come un’ombra. Rapivano bambini cristiani per usare il loro sangue in oscuri rituali. Le accuse crebbero come un fiume gonfio di pioggia. Infine il sultano Suleiman emise un ferman. I kadi locali non avrebbero potuto emettere condanne a partire da questa accusa e i pochi giudici che accettavano casi simili avrebbero voluto non farlo. Le accuse svanirono.
Non erano gli ebrei. Erano i cristiani. Non andavano mai all’hamam, erano sporchi fino al midollo. Non si lavavano dopo essersi accoppiati con le mogli. Bevevano vino, e come se non fosse stato un peccato sufficiente lo chiamavano il sangue di Gesù, che osavano chiamare Dio. Peggio di tutto, mangiavano maiale; la carne di un animale che divorava carne marcia e verminosa. La peste doveva essere stata contratta dai mangiatori di maiali. La stessa gente che prima s’infiltrava nelle strade degli ebrei fu vista aggredire i quartieri cristiani.
Un sellaio di Eyup prese il comando della folla. Dichiarò che ebrei e cristiani erano Gente del Libro e anche se erranti non erano malvagi. Non erano loro i colpevoli. Erano i sufi, con le loro cantilene e il loro ruotare. Chi poteva essere più pericoloso di qualcuno che si definiva musulmano eppure non aveva nulla a che vedere con l’Islam? Non dicevano di non aver paura dell’inferno né desiderio del paradiso? Non si rivolgevano a Dio come se fosse loro pari, non dicevano perfino che c’era Dio sotto il loro manto? La blasfemia aveva attratto la condanna. Squadracce sorvegliavano le strade, agitando bastoni, a caccia di eretici. Non furono fermati dal subashi e dalle sue guardie né arrestati dopo.
Il venerdì, dopo la preghiera della sera, si scatenarono per le stradine tortuose di Pera. Uomini, ma anche bambini di sette anni, con torce in mano, una folla che s’ingrossava: frugarono le case di malaffare, trascinarono fuori puttane e magnaccia e incendiarono le dimore. Una donna così grassa che si muoveva a stento fu legata a un palo e frustata, strisce cremisi su rotoli di carne. Un hunsa fu spogliato del tutto, ricoperto di sputi, rasato da capo a piedi e immerso nella merda. Ma fu una nana, dissero, che si prese la colpa di tutto, anche se nessuno sapeva perché: si diceva che fosse vicina al Capo eunuco bianco e capace di molti artifici. La mattina dopo, appena passata l’alba, i cani randagi la trovarono incrostata di sangue e feci, il naso rotto, le costole spezzate, viva a stento.
Solo quando la folla cominciò a minacciare di marciare sul palazzo, solo allora intervenne il subashi, arrestando undici uomini. Furono impiccati il giorno stesso, e i corpi rimasero a dondolare nel vento perché tutti li vedessero.
Quando la peste se ne fu andata, Istanbul aveva cinquemilasettecentoquarantadue anime in meno e i cimiteri erano pieni da scoppiare.
Ingmar Bergman
Pittura su Legno
(base del film il Settimo sigillo)
LA RAGAZZA: Dovreste obbedire e tornare indietro, scendere giù attraverso i paesi ancora non toccati dal morbo. Voi non avete mai visto gli occhi dei contagiati, le loro mani, il sangue che schiuma intorno al naso e alla bocca. Non avete mai visto il bubbone sotto la gola del malato, che cresce dalla sera alla mattina e dalla mattina alla sera, non avete mai visto il marciume che fuoriesce dai corpi. Su alcuni la piaga diventa grande come la testa di un bambino e i corpi degli ammalati inaridiscono e si ritirano intorno al bubbone, cosicché gli arti diventano come cordami. Cercano di strappare via il bubbone, si mordono le mani, arrivano a strapparsi le vene con le unghie. Le loro urla arrivano oltre le nuvole. Traballano sul pavimento, nei letti, sopra i prati, poi cadono in un ansimo continuo e infine muoiono nei fossi, nelle stalle, sulle aie, sulla riva del fiume. La gente fugge dai villaggi infestati, ma nella loro fuga sono seguiti da un’ombra, quella di un signore severo. Ancora nuove regioni vengono colpite: è come nei giorni estremi. Sembra di poter scorgere nel tramonto l’inesorabile cavaliere dell’Apocalisse.
JONS: Il mio padrone mi fa capire che dobbiamo andare avanti, mi ordina di proseguire. Vado incontro alla morte e alla peste. Sento il richiamo dell’uccellino dell’aldilà. E così hanno fine l’aria fresca, le notti quiete, le mattinate dolci e i giorni assolati. Addio, ragazza mia! Il cavaliere ed io non abbiamo di che ricompensarti per i tuoi avvisi; mettilo in conto per quando ci rivedremo nei cieli, se mai ci verrai. (I due si inoltrano nel bosco. Viene buio). Povero piccolo Jons, come è buio il bosco, anche se il sole è appena tramontato. Sento nel mio petto come un grande granchio che mi stringe il cuore! E se provassi a cantare una canzoncina: «Nel mare vanno pesci e vascelli. Ma qui la peste falcia i fuscelli». Basta! Hai paura eh, piccolo Jons? No, invece non hai paura, mio povero, piccolo Jons? Sì! Ho così paura che mi potrebbe venire la diarrea da un momento all’altro, se le mie viscere non fossero vuote quanto l’infinito.
Alfred Kubin
L’altra parte

Un sonno morboso e irresistibile si abbatté su Perla. Scoppiò nell’Archivio e di lì si diffuse per la città e per la campagna. Nessuno riusciva a resistere all’epidemia. Chi si vantava della propria freschezza aveva già preso da qualche parte, quando meno se l’aspettava, il germe della malattia.
Venne presto riconosciuto il suo carattere contagioso, ma nessun medico trovò un rimedio. I proclami fallirono il loro scopo, perché, ancor prima di aver finito di leggerli, la gente si metteva a sbadigliare. Tutti quelli che potevano se ne restavano a casa, per non venir còlti dal morbo per la strada. Se si aveva il proprio posticino ben riparato, ci si arrendeva rassegnati al nuovo destino. Male del resto non faceva. Per lo più il primo sintomo era una forte sensazione di spossatezza, poi il contagiato era còlto da un accesso di sbadigli, gli sembrava di avere della sabbia negli occhi, le palpebre gli si appesantivano, tutti i pensieri gli si confondevano, e doveva sdraiarsi dovunque si trovasse. L’ammalato poteva sì essere strappato al sonno di tanto in tanto, per mezzo di vapori dall’odore penetrante, di ammoniaca, ecc., ma balbettava soltanto un paio di parole incomprensibili e subito dopo se ne partiva di nuovo. Nelle persone robuste si poteva rinviare di qualche ora, con dei massaggi, questo stato, ma poi era lo stesso. Molti casi avevano un inizio rapidissimo. Un oratore stava ancora parlando, tutto infervorato, degli avvenimenti politici, quando all’im- prowiso si curvava sul tavolo, lasciava cadere la testa e si metteva a russare tranquillamente.
Anton, invece, non riusciva quasi a tenere gli occhi a- perti e tuttavia continuava a servire i clienti del caffè. Ma come bisognava scrollarlo, santo Iddio! Veniva bombardato con zollette di zucchero e cucchiaini, ma era di una smemoratezza inaudita, e, quando finalmente arrivava con l’ordinazione, capitava che il cliente impaziente si fosse intanto addormentato. Bisognava stare molto attenti, e spegnere subito il sigaro acceso di chi era caduto nel sonno.
La soldatesca si esercitava con molto zelo sulla piazza d’armi, per poter essere all’altezza della situazione in caso di una rivolta. Ma i sottufficiali potevano tuonare finché volevano, gli uomini si accasciavano per terra l’uno dopo l’altro. Si verificavano degli incidenti strani e comici. I ladri si addormentavano beatamente con le mani ancora dentro la cassa altrui. Melitta dormì per quattro giorni in casa di Brendel; il suo consorte sognava chino sulla tavola, col naso dentro una maionese.
Castringius era stato colpito mentre giocava a carte. Era appoggiato comodamente alla sua sedia, in una bettola malfamata, e teneva nella sua zampa il fante di quadri. Quanto a me, fui sorpreso a casa, dove m’ero ritirato molto presto. Avevo appena finito di preparare il letto e stavo per tirare le tende. Feci ancora in tempo a vedere delle banconote che dalla finestra della Principessa, lì di fronte, svolazzavano l’una dietro l’altra giù in strada; un leggero vento autunnale le trascinava verso il fiume come foglie appassite. Poi fui costretto a mettermi a letto immediatamente.
Nei primi due giorni dopo lo scoppio dell’epidemia, i treni arrivavano con enorme ritardo perché a ogni stazione bisognava sostituire il personale. Più tardi il traffico ferroviario cessò del tutto.
L’ultimo numero della « Voce » era stampato da una parte sola, e anche in quella brulicavano frasi incomplete e miriadi di errori di stampa. L’ultima pagina, dove di solito si trovavano spigolature e barzellette, mancava del tutto. Non c’era niente da fare; Perla dormiva. Quello stato di incoscienza completa sarà durato circa sei giorni: almeno questo era il risultato dei calcoli del barbiere, fondati sulla lunghezza delle barbe dei clienti.
Pare che durante questo tempo un uomo solo in tutta la città non abbia dormito, o abbia dormito pochissimo: l’americano! Così almeno affermò lui. Un giorno, mentre camminava per la Via Lunga come un nuovo principe da Bella Addormentata, aveva visto, a quanto diceva, attraverso una finestra del caffè, uno dei due giocatori di scacchi che stava facendo una mossa. Ne dedusse che i due, come lui, erano stati risparmiati dalla malattia. Ma altrove non si faceva che inciampare in gente che dormiva. Non solo su tutte le panchine dei giardini pubblici, ma anche nelle trombe delle scale e negli androni giacevano in gran disordine signori e signore ben vestiti, e dormivano come dei vagabondi, con espressione soddisfatta nonostante la singolare situazione.
Rabelais
Gargantua e Pantagruel

Grandola chiedeva ai pellegrini di qual paese fossero, donde venivano a dove
andavano.
Lasdaller rispose per tutti:
- Signore, io sono di Saint-Genou nel Berry, questo qui è di Palluau, quest'altro di Onzay,
quest'altro di Argy e questo qui di Villebrenin. Veniamo da San Sebastiano presso Nantes, e ce ne
ritorniamo a casa a piccole giornate.
- Ma, chiese Grangola, che andaste a fare a San Sebastiano?
- Siamo andati, disse Lasdaller, a offrirgli i nostri voti contro la peste.
- Oh, povera gente, disse Grangola, credete voi che la peste venga da San Sebastiano?
- Certo, rispose Lasdaller, così affermano i nostri predicatori.
- Davvero? disse Grangola, i falsi profeti vi annunciano di tali frottole? Essi bestemmiano in
tal modo i giusti e i santi di Dio rendendoli simili ai diavoli i quali non fanno che male tra gli uomini. Così Omero scrive che la peste fu mandata tra l'esercito dei Greci da Apollo, e così i preti inventano un mucchio di Vegiovi e divinità malefiche. E così predicava a Cirais un ipocrita, che Sant'Antonio mette il fuoco alle gambe, Sant'Eutropio rende idropici, San Gildas fa impazzire, San Ginocchio dà la gotta. Ma io l'ho punito in tal modo, benché mi chiamasse eretico, che da allora mai più nessun ipocrita osò entrare nelle mie terre e mi stupisco che il vostro re lasci loro predicare nel suo reame tali scandali; poiché meritano maggior castigo di coloro che per arte magica o altri mezzi
diffondessero la peste tra la gente. La peste infatti non uccide che il corpo, quegli impostori
avvelenano le anime…. Andatevene, disse Grangola, andatevene, povera gente, nel nome di Dio Creatore, e che Esso vi guidi in perpetuo; e d'ora innanzi non lasciatevi indurre a codesti oziosi e inutili viaggi. Mantenete le vostre famiglie, lavorate ciascuno secondo la propria vocazione, istruite i vostri figliuoli e vivete come insegna il buon apostolo San Paolo. Ciò facendo avrete con voi la protezione di Dio, degli angeli e dei santi e non ci sarà peste o malanno che venga a danneggiarvi.
Franz Boas
"Kutenai Tales"

Gli uomini vivevano là, e un giorno venne un'epidemia.
Morivano. Morivano tutti. Andarono in giro e si diedero l'un l'altro la notizia. La malattia regnò fra tutti i Kutenai. Essi giungevano in un certo posto e si narravano gli uni agli altri ciò che accadeva. Era dappertutto lo stesso. In un posto non videro nessuno. Erano tutti morti. Restava solo una persona. Un giorno, quell'uno che era rimasto guarì. Era un uomo. Era solo.
Pensò: "Girerò per il mondo e vedrò se in qualche posto c'è ancora qualcuno. Se non c'è più nessuno, non voglio più tornare indietro. Qui non c'è nessuno, e nessuno viene in visita". Partì nella sua canoa e giunse all'ultimo accampamento dei Kutenai.
Quando giunse là dove solitamente la gente stava sulla riva, non c'era nessuno; e quando si mosse in giro vide soltanto morti, da nessuna parte tracce di esseri viventi. Seppe così che nessuno era sopravvissuto. Ripartì sulla sua canoa. Arrivò in un'altra località, scese, e di nuovo vide soltanto morti. Non c'era nessuno. Si mise sulla via del ritorno. Arrivò all'ultimo centro abitato dei Kutenai. Nelle tende c'erano unicamente mucchi di cadaveri. Così continuò a vagare in giro e sempre vide che tutti se n'erano andati. Camminando piangeva. "Sono l'unico che sia rimasto," si diceva "perfino i cani sono morti". Quando raggiunse il villaggio più lontano vide impronte di piedi umani. C'era una tenda. Dentro, non giaceva alcun cadavere. Il villaggio era lontano. Egli comprese allora che due o tre uomini dovevano essere rimasti in vita. Vide impronte più grandi e più piccole - non avrebbe potuto dire se fossero di tre persone.
Qualcuno, dunque, si era salvato. L'uomo ripartì sulla sua canoa e pensò: "Remerò in questa direzione. Coloro che prima abitavano qui, erano soliti remare in questa direzione. Se un uomo c'è, si è forse trasferito più lontano".
«Quando si sedette nella canoa, vide in alto, a una certa distanza, due orsi bruni che mangiavano delle bacche, e pensò: "Vado ad ucciderli. Quando li avrò uccisi li mangerò. Farò essiccare la loro carne. Poi mi guarderò intorno per scoprire se qualcuno è sopravvissuto. Prima essiccherò la carne, poi cercherò. D'altronde ho visto impronte umane. Saranno forse uomini o donne affamati. Anch'essi devono avere qualcosa da mangiare". Andò nella direzione degli orsi. Giunse vicino a loro e si accorse che non erano orsi, ma donne. Una era una ragazza, l'altra era più vecchia. Egli pensò: "Sono contento di vedere creature umane. Prenderò per moglie quella donna". Si fece più vicino e afferrò la ragazza. Questa disse alla madre: "Madre, vedo un uomo". La madre levò gli occhi e vide che la figlia diceva la verità. Vide che un uomo prendeva sua figlia. Allora pianse la madre, pianse la ragazza, pianse il giovane, poiché tutti i Kutenai erano morti. Si guardarono l'un l'altro e piansero insieme. La madre disse: "Non prendere mia figlia, è ancora piccola. Prendi me. Devi essere il mio sposo. Più tardi, quando mia figlia sarà cresciuta, diverrà tua moglie e avrai dei figli". Il giovane prese in moglie la donna più vecchia. Non passò molto tempo, e quella disse: "Ora mia figlia è cresciuta.
Ora può essere tua moglie.. E" bene che abbia dei figli, il suo corpo è ora forte". Allora il giovane prese in moglie la ragazza. E da allora i Kutenai si moltiplicarono».

Durante la spaventosa epidemia di colera che infierì su New York, avevo accettato l'invito di un parente a passare un paio di settimane di isolamento in un suo cottage sulle rive dell'Hudson. Disponevamo di tutto quanto normalmente può servire per le vacanze estive; eravamo attrezzati per le passeggiate e le escursioni nei boschi, per le gite in barca, per la pesca, i bagni, la musica e la lettura, avremmo potuto passare abbastanza piacevolmente il tempo se non fosse stato per le spaventose notizie che ci arrivavano tutti i giorni dalla popolosa città. Non passava giorno senza che ci portasse notizia della morte di qualche conoscente. Poi, con l'aumentare della mortalità, avevamo imparato ad aspettare l'annuncio giornaliero della morte di un amico. Finimmo così per tremare all'avvicinarsi di qualsiasi messaggero. L'aria stessa del sud ci sembrava recare odore di morte. Questo pensiero ossessionante s'impossessò a tal punto della mia anima che non riuscivo più a dire, pensare, persino sognare, altro.
Tito Livio
Storia di Roma

Dalle successive elezioni uscirono consoli Lucio Ebuzio e Publio
Servilio. Il primo agosto - data che allora rappresentava l'inizio
dell'anno - entrano in carica. Si era nella stagione malsana e il caso
volle che quello fosse un anno di pestilenza tanto a Roma quanto nelle
campagne, e sia per gli uomini che per il bestiame. Ad accrescere la
virulenza dell'epidemia contribuì poi la gente che, terrorizzata da
possibili saccheggi, cominciò a ricoverare in città mandrie e relativi
pastori. Questo miscuglio eterogeneo di animali tormentava col suo
insolito odore i cittadini, mentre la gente di campagna, stipata in dimore
anguste, soffriva per il caldo e la mancanza di sonno. E poi lo scambio di
servizi e il contatto stesso contribuivano a diffondere l'infezione. …. A Roma la strage dovuta
all'epidemia non fu di proporzioni minori di quella patita dagli alleati a
colpi di spada. L'unico console rimasto era nel frattempo deceduto. Così
come morti erano pure altri personaggi illustri quali gli àuguri Marco
Valerio e Tito Verginio Rutulo e il capo delle curie Servio Sulpicio. La
malattia aveva colpito con tutta la sua violenza anche la folla anonima. E
il senato, non potendo più contare sull'aiuto degli uomini, spinse il
popolo a rivolgere le preghiere agli dèi, ordinando che tutti, con mogli e
bambini, andassero nei templi a supplicare il cielo e a chiedere la pace.
Così, indotti dall'autorità pubblica a fare le cose a cui già li
costringevano le proprie sventure, i cittadini si affollarono in tutti i
santuari. Dovunque le matrone, piegate a spazzare coi capelli sciolti i
pavimenti dei templi, implorano gli dèi adirati e li supplicano di porre
fine alla pestilenza.
Ammiano Marcellino
Le Storie
_(14596243719).jpg)
Ma nella città, a causa dei morti sparsi per le vie che per il loro numero non si riusciva a seppellire, a tanti mali si aggiunse una pestilenza, che fu alimentata dal contagio diffuso dai corpi in preda ai vermi, dal caldo e dalle esalazioni nonché dalla debolezza della plebe, determinata da varie cause. Spiegherò in breve l’origine di questo tipo di malattie.
Filosofi ed illustri medici hanno insegnato che le pestilenze sono provocate da eccessi di caldo o di freddo, di umidità o di siccità. Perciò quanti abitano in zone paludose o umide sono affetti da tossi, da malattie agli occhi e da simili infermità, mentre coloro che vivono in regioni calde sono bruciati dall’ardore delle febbri. Ma quanto il fuoco è più efficace delle altre sostanze, tanto più velocemente la siccità distrugge. Per questa ragione, mentre la Grecia si affaticava in una guerra decennale per impedire che uno straniero1 che aveva distrutto un matrimonio regale, sfuggisse alla meritata punizione, infuriò una sciagura di questo genere e molti perirono colpiti dai dardi di Apollo (che è ritenuto il sole). Come narra Tucidide, quel tremendo disastro, che all’inizio della guerra del Peloponneso colpì gli Ateniesi a causa di una grave epidemia, era giunto nell’Attica propagandosi a poco a poco sin dalla bruciata regione dell’Etiopia. Altri ritengono che l’atmosfera (come avviene di solito) o le acque rese infette da cadaveri in decomposizione o da cause analoghe provochino la maggior parte delle malattie e che comunque non si possa dubitare che un improvviso cambiamento d’aria provochi morbi meno gravi. Certuni anche sostengono che l’aria, resa spessa da esalazioni terrestri più dense del solito, impedisca le secrezioni dei corpi provocando in tal modo la morte. Perciò è noto, in base a quanto dice Omero e ad altre numerose esperienze successive, che, quando scoppia una siffatta pestilenza, sono gli animali, che camminano continuamente chini in avanti, a perire prima degli uomini. Il primo tipo di contagio si chiama pandemico e causa soventi disturbi febbrili a coloro che vivono in regioni piuttosto aride; il secondo tipo è detto epidemico e si manifesta in determinati periodi dell’anno indebolendo la vista e provocando pericolose flussioni. Il terzo tipo, chiamato loemodes, è pure periodico, ma è mortale per la sua somma velocità.
Noi eravamo spossati da questa esiziale pestilenza e pochi erano morti per l’eccessivo calore accresciuto dalla moltitudine, quando finalmente durante la notte successiva alla decima giornata l’aria densa e spessa fu dispersa da una piccola pioggia ed in tal modo ricuperammo pienamente la salute.

Ma Kunta, per quanto lo riguardava, nonostante odiasse i taubob con
tutto il suo essere, non pensava più a ucciderli. Era così stremato e
dolorante che nemmeno gli importava di vivere o di morire.
Giù nella stiva si udiva parlare raramente, ormai. Non c'era più
niente da dire. Eppoi, era troppo
faticoso. Man mano che passavano i giorni Kunta si sentiva sempre
peggio. E non gli giovava certo
vedere le condizioni in cui versavano alcuni compagni più malandati di
lui, specie
quandòcominciarono a defecare un misto di sangue raggrumato e di muco
denso e giallastro
terribilmente fetido.
Non appena i taubob se n'accorsero si misero in allarme. Uno di loro
andò a chiamare il capo.
Questi ordinò di portar subito fuori coloro che avevano defecato
sangue e di lavare i tavolacci. Poi
fu versato aceto bollente dove essi eran giaciuti. Però tutto fu
inutile perché il contagio -che Kunta
sentì chiamare "dissenteria" dai taubob-continuava a diffondersi.
Presto anche Kunta fu scosso da brividi di freddo, poi si sentì ardere
e infine defecò sangue e muco fetido. Era come se insieme alle
eci gli uscissero i budelli. Fra uno spasimo e l'altro, fuori di sé,
gridava: "Omoro... Omar il
Secondo Califfo, terzo dopo Maometto il Profeta! Kairaba... Kairaba
significa pace!". In capo a due
giorni tutti gli uomini nella stiva erano affétti da dissenteria.
Nel delirio Kunta rivide nonna Yaisa e riudì le sue ultime parole.
Ripensò alla vecchia Nyo Boto e alle storie che gli aveva raccontato
da piccolo: come quella del
coccodrillo preso in trappola e del bambino che lo aveva liberato.
Presto gran parte degli uomini non furono più in grado di camminare e
i taubob erano costretti a
sorreggerli. Sul ponte, ogni giorno, il taubob dai capelli bianchi
applicava il suo inutile unguento;
ogni giorno qualcuno moriva e veniva gettato fuori bordo; morirono
diverse donne e due dei quattro
bambini. Morirono anche parecchi taubob, e di quelli rimasti molti non
erano quasi in grado di
muoversi; e uno reggeva il timone seduto su un secchio.
Francesco Berni
Rime – capitolo secondo della peste
Non fu mai malattia senza ricetta: la natura l'ha fatte tutt'e due: ella imbratta le cose, ella le netta. Ella trovò l'aratol, ella il bue, ella il lupo, l'agnel, la lepre, il cane, e dette a tutti le qualità sue; ella fece l'orecchie e le campane, fece l'assenzio amaro e dolce il mèle, e l'erbe velenose e l'erbe sane; ella ha trovato il buio e le candele, e finalmente la morte e la vita, e par benigna ad un tratto e crudele. Par, dico, a qualche pecora smarrita: vedi ben tu che da lei non si cava altro che ben, perch'è bontà infinita. Trovò la peste perché bisognava: eravamo spacciati tutti quanti, cattivi e buon, s'ella non si trovava, tanto multiplicavano i furfanti ….. E noi, balordi, facciam certi visi, come si dice: «La peste è in paese!»; ci lamentiam, che par che siamo uccisi, che dovrebbemo darle un tanto al mese, intertenerla come un capitano, per servircene al tempo a mille imprese. Come fan tutti i fiumi all'oceàno, così vanno alla peste gli altri mali a dar tributo e basciarle la mano; e l'accoglienze sue son tante e tali che di vassallo ogniun si fa suo amico, anzi son tutti suoi fratei carnali….
Se tu vuoi far le tue faccende corte, avendosi a morir, come tu sai, muori, maestro Pier, di questa morte: almanco intorno non arai notai che ti voglin rogare il testamento, né la stampa volgar del «come stai», che non è al mondo il più crudel tormento. La peste è una prova, uno scandaglio, che fa tornar gli amici ad un per cento: fa quel di lor che fa del grano il vaglio, ché quando ella è di quella d'oro in oro, non vale inacetarsi o mangiar l'aglio. Allor fanno li amanti i fatti loro: vedesi allor s'egli stava alla prova quel che dicea: «Madonna, io spasmo, io moro»; che se l'ammorba et ei la lasci sola, s'e' non si serra in conclavi con lei, si dice: «E' ne mentiva per la gola».
Roberto Esposito
Democrazia immunitaria
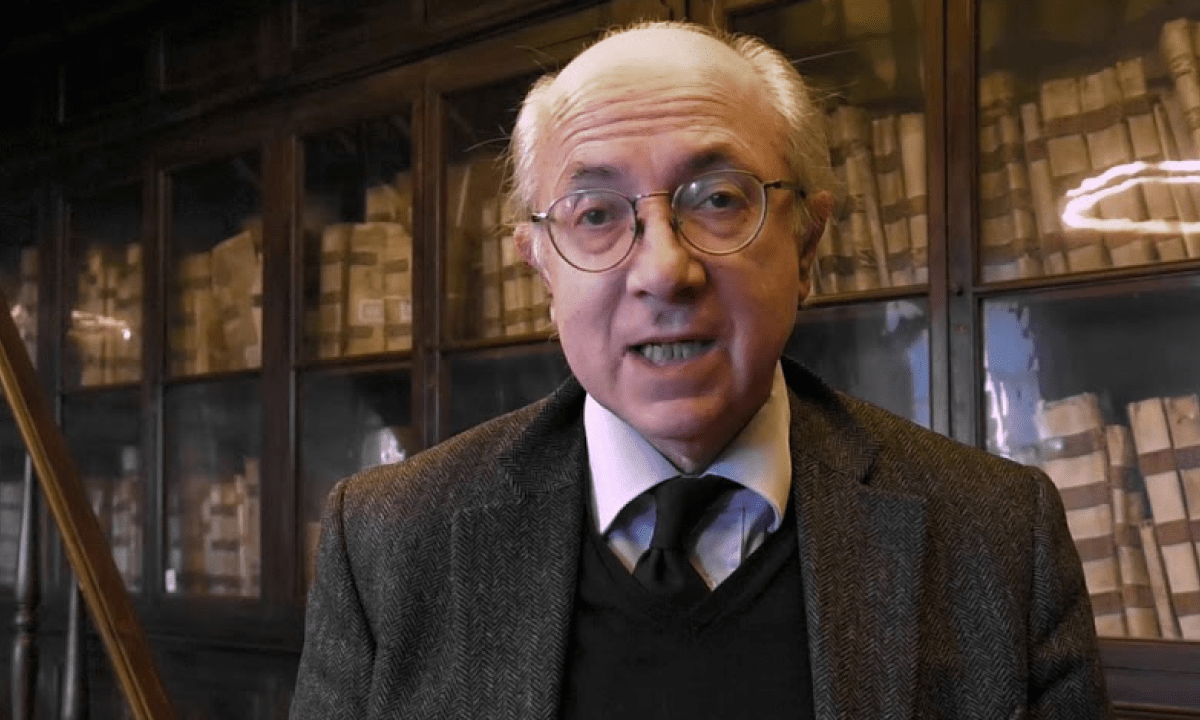
Senza poter entrare troppo nel merito di complesse questioni etimologiche, diciamo che l’immunità o, nella sua formulazione latina, l’immunitas, risulta il contrario, il rovescio, della communitas. Entrambi i vocaboli derivano dal termine munus – che significa “dono”, “uffico”, “obbligo” – ma l’uno, la communitas, in senso affermativo mentre l’altro, l’immunitas, in senso negativo. Per cui, se i membri della comunità sono caratterizzati da quest’obbligo donativo, da questa legge della cura nei confronti dell’altro, l’immunità implica l’esenzione o la deroga da tale condizione: è immune chi è a riparo dagli obblighi, e dai pericoli, che coinvolgono tutti gli altri. Chi spezza il circuito della circolazione sociale ponendosi al suo esterno. Ora le tesi di fondo che intendo sostenere sono essenzialmente due. La prima è che questo dispositivo immunitario – questa esigenza di esenzione e protezione –, originariamente attinente all’ambito medico e giuridico, si è andato progressivamente estendendo a tutti i settori e linguaggi della nostra vita, fino a diventare il punto di coagulo, reale e simbolico, dell’esperienza contemporanea. Certo, ogni società ha espresso un’esigenza di autoprotezione. Ogni collettività ha posto in essere una domanda radicale sulla conservazione della vita. Ma la mia impressione è che solo oggi, alla fine della stagione moderna, tale esigenza sia diventata il perno di rotazione intorno al quale si costruisce sia la pratica effettiva sia l’immaginario di un’intera civiltà. Per farsene una prima idea, basti guardare al ruolo che l’immunologia – cioè la scienza deputata allo studio e al rafforzamento dei sistemi immunitari – ha assunto non solo sotto il profilo medico, ma anche sotto quello sociale, giuridico, etico. Si pensi solo a cosa ha significato la scoperta della sindrome da immunodeficienza dell’Aids in termini di normalizzazione – cioè di assoggettamento a precise norme non solo igienico-sanitarie – dell’esperienza individuale e collettiva. Alle barriere, non solo profilattiche ma socio-culturali, che l’incubo della malattia ha determinato nella sfera di tutti i rapporti interrelazionali. Se si passa dall’ambito delle malattie infettive a quello, sociale, dell’immigrazione, se ne ha una prima conferma: il fatto che il crescente flusso immigratorio sia considerato, del tutto a sproposito, uno dei maggiori pericoli per le nostre società indica anche da questo lato la centralità che sta assumendo la questione immunitaria. Dovunque vanno sorgendo nuove transenne, nuovi posti di blocco, nuove linee di separazione rispetto a qualcosa che minaccia, o almeno pare minacciare, la nostra identità biologica, sociale, ambientale. È come se si fosse esasperata quella paura di essere sfiorati – anche inavvertitamente – che già Elias Canetti individuava all’origine della nostra modernità in un cortocircuito perverso tra tatto, contatto e contagio (cfr. E. Canetti, 1991). Il contatto, la relazione, l’essere in comune, appare immediatamente schiacciato sul rischio della contaminazione.
La stessa cosa può dirsi per quanto riguarda le tecnologie informatiche: anche qua il problema maggiore, il vero e proprio incubo di tutti gli operatori, è rappresentato dai cosiddetti virus dei computer – non dei nostri piccoli apparecchi, ma dei grandi apparati informatici che regolano i rapporti finanziari, politici, militari a livello mondiale. Ormai tutti i governi occidentali stanziano enormi cifre per la messa a punto di programmi antivirali in grado di immunizzare la rete informatica dall’infiltrazione di agenti patogeni, anche in ordine a possibili attacchi terroristici. Che anche al centro delle grandi controversie nazionali ed internazionali vi sia oggi la battaglia giuridica sull’immunità di alcuni personaggi politici – come è stato per Pinochet e Miloševic´, ma anche per tanti altri – è un’ulteriore riprova di quanto dicevo. Quello che si teme, aldilà degli specifici casi, è un indebolimento del potere sovrano dei singoli Stati, una rottura dei confini giuridici degli ordinamenti nazionali a vantaggio di una qualche forma, ancora tutta da costruire, di giustizia internazionale. Insomma, da qualsiasi lato si guardi a quanto sta succedendo oggi nel mondo, dal corpo individuale al corpo sociale, dal corpo tecnologico al corpo politico, la questione dell’immunità si insedia al crocevia di tutti i percorsi. Ciò che conta è impedire, prevenire, combattere con ogni mezzo la diffusione del contagio dovunque esso possa determinarsi.
Come dicevo, questa preoccupazione autoprotettiva non appartiene solo alla nostra epoca. Ma la soglia di consapevolezza nei confronti del rischio è stata molto diversa nel corso del tempo, fino a toccare l’apice proprio in questo periodo. Ciò è dovuto a una serie di concause non estranee a quello che si chiama globalizzazione: nel senso che quanto più gli uomini – ma anche le idee, i linguaggi, le tecniche – comunicano e s’intrecciano tra loro, tanto più si genera, come controspinta, un’esigenza di immunizzazione preventiva. I nuovi ripiegamenti localistici possono essere spiegati come una sorta di rigetto immunitario di quella contaminazione globale che è la globalizzazione. Quanto più il “sé” tende a farsi “globale”, quanto più si sforza di includere ciò che si situa al suo esterno, quanto più cerca di introiettare ogni forma di negatività, tanto più ne riproduce. È stato proprio l’abbattimento del grande muro, reale e simbolico, di Berlino a produrre l’innalzamento di tanti piccoli muri – fino a trasformare, e pervertire, l’idea stessa di comunità nella forma di una fortezza assediata. Ciò che conta è impedire un eccesso di circolazione e dunque di potenziale contaminazione. Da questo punto di vista il virus è diventato la metafora generale di tutti i nostri incubi. In realtà c’è stato un momento nelle nostre società in cui la paura – almeno quella di tipo biologico – si è attenuata. Parlo degli anni Cinquanta e Sessanta, quando si diffuse l’idea ottimistica che la medicina antibiotica potesse sradicare alcune malattie millenarie. Così fu, fin quando non apparve l’Aids. È stato allora che la diga psicologica è crollata. I virus, simbolici e reali, sono riapparsi invincibili – veri e propri demoni capaci di penetrare dentro di noi e trascinarci nel loro vuoto di senso. È allora che l’esigenza immunitaria è cresciuta a dismisura fino a diventare il nostro impegno fondamentale, la forma stessa che abbiamo dato alla nostra vita.
2. È proprio qui, tuttavia, che si innesta la mia seconda tesi – è cioè l’idea che l’immunità, necessaria a proteggere la nostra vita, se portata oltre una certa soglia, finisca per negarla. Nel senso che la costringe in una sorta di gabbia, o armatura, nella quale si perde non solo la nostra libertà, ma il senso stesso della nostra esistenza individuale e collettiva – vale a dire quella circolazione del senso, quell’affacciarsi dell’esistenza fuori di sé, che definisco con il termine communitas, alludendo al carattere costitutivamente esposto dell’esistenza. All’ex dell’existentia, come direbbe Heidegger. Ecco la terribile contraddizione su cui va puntata l’attenzione: ciò che salvaguarda il corpo individuale e collettivo è anche ciò che ne impedisce lo sviluppo. E che anzi, oltre un certo punto, finisce per distruggerlo. Si potrebbe dire – per usare il linguaggio di Walter Benjamin, egli stesso morto per la chiusura di un confine – che l’immunizzazione ad alte dosi sia il sacrificio del vivente, cioè di ogni forma di vita qualificata, alle ragioni della semplice sopravvivenza. La riduzione della vita alla sua nuda falda biologica, del bios alla zoe. Per restare tale, la vita è costretta a piegarsi ad una potenza estranea che la penetra e la schiaccia. Ad incorporare quel niente che vuole evitare, rimanendo presa nel suo vuoto di senso.
D’altra parte questa contraddizione – questa connessione antinomica tra protezione e negazione della vita – è implicita nella stessa procedura dell’immunizzazione medica: come è noto, per vaccinare un paziente nei confronti di una malattia, se ne immette nell’organismo una porzione controllata e sostenibile. Ciò significa che in questo caso la medicina è fatta dello stesso veleno da cui deve proteggere – quasi che per conservare qualcuno in vita sia necessario fargli assaggiare la morte. Del resto il vocabolo pharmakon contiene fin dall’origine il doppio significato di “cura” e di “veleno” – veleno come cura, cura attraverso il veleno. È come se i moderni procedimenti immunitari avessero portato alla sua massima intensificazione tale contraddizione: sempre più la cura si dà nella forma di un micidiale veleno. Se si riporta questa pratica immunologica all’interno del corpo sociale, si coglie la stessa antinomia, lo stesso paradosso controfattuale: alzare continuamente la soglia di attenzione della società nei confronti del rischio – come da tempo siamo abituati a fare – significa bloccarne la crescita o addirittura farla regredire al suo stadio primitivo. E come se, anziché adeguare il livello della protezione alla effettiva entità del rischio, si adeguasse la percezione del rischio alla crescente esigenza di protezione – vale a dire si creasse artificialmente rischio per poterlo controllare, come del resto fanno comunemente le compagnie di assicurazioni. Tutto ciò fa parte dell’esperienza moderna. Ma la mia impressione è che stiamo toccando un punto, un limite, a partire da cui questo meccanismo di reciproca ricarica tra assicurazione e rischio, tra protezione e negazione della vita, rischia di sfuggire di mano, di uscire dal controllo. Per farsene un’idea non metaforica, si pensi a quanto accade nelle cosiddette malattie autoimmuni, allorché il sistema immunitario è tanto potenziato da rivolgersi contro lo stesso organismo che dovrebbe difendere, distruggendolo (cfr. anche J. Derrida, 2003). Certo, i sistemi immunitari sono necessari. Nessun corpo individuale o sociale potrebbe farne a meno, ma quando crescono a dismisura finiscono per portare all’esplosione o all’implosione l’intero organismo.
Alessandro Manzoni
I Promessi Sposi

Per tutta adunque la striscia di territorio percorsa dall’esercito, s’era trovato qualche cadavere nelle case, qualcheduno sulla strada. Poco dopo, in questo e in quel paese, cominciarono ad ammalarsi, a morire, persone, famiglie, di mali violenti, strani, con segni sconosciuti alla piú parte de’ viventi. C’era soltanto alcuni a cui non riuscissero nuovi: que’ pochi che potessero ricordarsi della peste che, cinquantatre anni avanti, aveva desolata pure una buona parte d’Italia, e in ispecie il milanese, dove fu chiamata, ed è tuttora, la peste di san Carlo. Tanto è forte la carità! Tra le memorie cosí varie e cosí solenni d’un infortunio generale, può essa far primeggiare quella d’un uomo, perché a quest’uomo ha ispirato sentimenti e azioni piú memorabili ancora de’ mali; stamparlo nelle menti, come un sunto di tutti que’ guai, perché in tutti l’ha spinto e intromesso, guida, soccorso, esempio, vittima volontaria; d’una calamità per tutti, far per quest’uomo come un’impresa; nominarla da lui, come una conquista, o una scoperta.
Il protofisico Lodovico Settala, ché, non solo aveva veduta quella peste, ma n’era stato uno de’ piú attivi e intrepidi, e, quantunque allor giovinissimo, de’ piú riputati curatori; e che ora, in gran sospetto di questa, stava all’erta e sull’informazioni, riferí, il 20 d’ottobre, nel tribunale della sanità, come, nella terra di Chiuso (l’ultima del territorio di Lecco, e confinante col bergamasco), era scoppiato indubitabilmente il contagio. Non fu per questo presa veruna risoluzione, come si ha dal Ragguaglio del Tadino .
Ed ecco sopraggiungere avvisi somiglianti da Lecco e da Bellano. Il tribunale allora si risolvette e si contentò di spedire un commissario che, strada facendo, prendesse un medico a Como, e si portasse con lui a visitare i luoghi indicati. Tutt’e due, «o per ignoranza o per altro, si lasciorno persuadere da un vecchio et ignorante barbiero di Bellano, che quella sorte de mali non era Peste» ; ma, in alcuni luoghi, effetto consueto dell’emanazioni autunnali delle paludi, e negli altri, effetto de’ disagi e degli strapazzi sofferti, nel passaggio degli alemanni. Una tale assicurazione fu riportata al tribunale, il quale pare che ne mettesse il cuore in pace.
Ma arrivando senza posa altre e altre notizie di morte da diverse parti, furono spediti due delegati a vedere e a provvedere: il Tadino suddetto, e un auditore del tribunale. Quando questi giunsero, il male s’era già tanto dilatato, che le prove si offrivano, senza che bisognasse andarne in cerca. Scorsero il territorio di Lecco, la Valsassina, le coste del lago di Como, i distretti denominati il Monte di Brianza, e la Gera d’Adda; e per tutto trovarono paesi chiusi da cancelli all’entrature, altri quasi deserti, e gli abitanti scappati e attendati alla campagna, o dispersi: «et ci parevano, – dice il Tadino, – tante creature seluatiche, portando in mano chi l’herba menta, chi la ruta, chi il rosmarino et chi una ampolla d’aceto». S’informarono del numero de’ morti: era spaventevole; visitarono infermi e cadaveri, e per tutto trovarono le brutte e terribili marche della pestilenza. Diedero subito, per lettere, quelle sinistre nuove al tribunale della sanità, il quale, al riceverle, che fu il 30 d’ottobre, «si dispose», dice il medesimo Tadino, a prescriver le bullette, per chiuder fuori dalla Città le persone provenienti da’ paesi dove il contagio s’era manifestato; «et mentre si compilaua la grida», ne diede anticipatamente qualche ordine sommario a’ gabellieri.
Intanto i delegati presero in fretta e in furia quelle misure che parver loro migliori; e se ne tornarono, con la trista persuasione che non sarebbero bastate a rimediare e a fermare un male già tanto avanzato e diffuso.
Arrivati il 14 di novembre, dato ragguaglio, a voce e di nuovo in iscritto, al tribunale, ebbero da questo commissione di presentarsi al governatore, e d’esporgli lo stato delle cose. V’andarono, e riportarono: aver lui di tali nuove provato molto dispiacere, mostratone un gran sentimento; ma i pensieri della guerra esser piú pressanti: sed belli graviores esse curas. Cosí il Ripamonti, il quale aveva spogliati i registri della Sanità, e conferito col Tadino, incaricato specialmente della missione: era la seconda, se il lettore se ne ricorda, per quella causa, e con quell’esito. Due o tre giorni dopo, il 18 di novembre, emanò il governatore una grida, in cui ordinava pubbliche feste, per la nascita del principe Carlo, primogenito del re Filippo IV, senza sospettare o senza curare il pericolo d’un gran concorso, in tali circostanze: tutto come in tempi ordinari, come se non gli fosse stato parlato di nulla.
Era quest’uomo, come già s’è detto, il celebre Ambrogio Spinola, mandato per raddirizzar quella guerra e riparare agli errori di don Gonzalo, e incidentemente, a governare; e noi pure possiamo qui incidentemente rammentar che morí dopo pochi mesi, in quella stessa guerra che gli stava tanto a cuore; e morí, non già di ferite sul campo, ma in letto, d’affanno e di struggimento, per rimproveri, torti, disgusti d’ogni specie ricevuti da quelli a cui serviva. La storia ha deplorata la sua sorte, e biasimata l’altrui sconoscenza; ha descritte con molta diligenza le sue imprese militari e politiche, lodata la sua previdenza, l’attività, la costanza: poteva anche cercare cos’abbia fatto di tutte queste qualità, quando la peste minacciava, invadeva una popolazione datagli in cura, o piuttosto in balía.
Ma ciò che, lasciando intero il biasimo, scema la maraviglia di quella sua condotta, ciò che fa nascere un’altra e piú forte maraviglia, è la condotta della popolazione medesima, di quella, voglio dire, che, non tocca ancora dal contagio, aveva tanta ragion di temerlo. All’arrivo di quelle nuove de’ paesi che n’erano cosí malamente imbrattati, di paesi che formano intorno alla città quasi un semicircolo, in alcuni punti distante da essa non piú di diciotto o venti miglia; chi non crederebbe che vi si suscitasse un movimento generale, un desiderio di precauzioni bene o male intese, almeno una sterile inquietudine? Eppure, se in qualche cosa le memorie di quel tempo vanno d’accordo, è nell’attestare che non ne fu nulla. La penuria dell’anno antecedente, le angherie della soldatesca, le afflizioni d’animo, parvero piú che bastanti a render ragione della mortalità: sulle piazze, nelle botteghe, nelle case, chi buttasse là una parola del pericolo, chi motivasse peste, veniva accolto con beffe incredule, con disprezzo iracondo. La medesima miscredenza, la medesima, per dir meglio, cecità e fissazione prevaleva nel senato, nel Consiglio de’ decurioni, in ogni magistrato.
Trovo che il cardinal Federigo, appena si riseppero i primi casi di mal contagioso, prescrisse, con lettera pastorale a’ parrochi, tra le altre cose, che ammonissero piú e piú volte i popoli dell’importanza e dell’obbligo stretto di rivelare ogni simile accidente, e di consegnar le robe infette o sospette : e anche questa può essere contata tra le sue lodevoli singolarità.
Il tribunale della sanità chiedeva, implorava cooperazione, ma otteneva poco o niente. E nel tribunale stesso la premura era ben lontana da uguagliare l’urgenza: erano, come afferma piú volte il Tadino, e come appare ancor meglio da tutto il contesto della sua relazione, i due fisici che, persuasi della gravità e dell’imminenza del pericolo, stimolavan quel corpo, il quale aveva poi a stimolare gli altri.
Abbiam già veduto come, al primo annunzio della peste, andasse freddo nell’operare, anzi nell’informarsi: ecco ora un altro fatto di lentezza non men portentosa, se però non era forzata, per ostacoli frapposti da magistrati superiori. Quella grida per le bullette, risoluta il 30 d’ottobre, non fu stesa che il dí 23 del mese seguente, non fu pubblicata che il 29. La peste era già entrata in Milano.
Il Tadino e il Ripamonti vollero notare il nome di chi ce la portò il primo, e altre circostanze della persona e del caso: e infatti, nell’osservare i princípi d’una vasta mortalità, in cui le vittime, non che esser distinte per nome, appena si potranno indicare all’incirca, per il numero delle migliaia, nasce una non so quale curiosità di conoscere que’ primi e pochi nomi che poterono essere notati e conservati: questa specie di distinzione, la precedenza nell’esterminio, par che faccian trovare in essi, e nelle particolarità, per altro piú indifferenti, qualche cosa di fatale e di memorabile.
L’uno e l’altro storico dicono che fu un soldato italiano al servizio di Spagna; nel resto non sono ben d’accordo, neppur sul nome. Fu, secondo il Tadino, un Pietro Antonio Lovato, di quartiere nel territorio di Lecco; secondo il Ripamonti, un Pier Paolo Locati, di quartiere a Chiavenna. Differiscono anche nel giorno della sua entrata in Milano: il primo la mette al 22 d’ottobre, il secondo ad altrettanti del mese seguente: e non si può stare né all’uno né all’altro. Tutt’e due l’epoche sono in contraddizione con altre ben piú verificate. Eppure il Ripamonti, scrivendo per ordine del Consiglio generale de’ decurioni, doveva avere al suo comando molti mezzi di prender l’informazioni necessarie; e il Tadino, per ragione del suo impiego, poteva, meglio d’ogn’altro, essere informato d’un fatto di questo genere. Del resto, dal riscontro d’altre date che ci paiono, come abbiam detto, piú esatte, risulta che fu, prima della pubblicazione della grida sulle bullette; e, se ne mettesse conto, si potrebbe anche provare o quasi provare, che dovette essere ai primi di quel mese; ma certo, il lettore ce ne dispensa.
Sia come si sia, entrò questo fante sventurato e portator di sventura, con un gran fagotto di vesti comprate o rubate a soldati alemanni; andò a fermarsi in una casa di suoi parenti, nel borgo di porta orientale, vicino ai cappuccini; appena arrivato, s’ammalò; fu portato allo spedale; dove un bubbone che gli si scoprí sotto un’ascella, mise chi lo curava in sospetto di ciò ch’era infatti; il quarto giorno morí.
Il tribunale della sanità fece segregare e sequestrare in casa la di lui famiglia; i suoi vestiti e il letto in cui era stato allo spedale, furon bruciati. Due serventi che l’avevano avuto in cura, e un buon frate che l’aveva assistito, caddero anch’essi ammalati in pochi giorni, tutt’e tre di peste. Il dubbio che in quel luogo s’era avuto, fin da principio, della natura del male, e le cautele usate in conseguenza, fecero sí che il contagio non vi si propagasse di piú.
Ma il soldato ne aveva lasciato di fuori un seminío che non tardò a germogliare. Il primo a cui s’attaccò, fu il padrone della casa dove quello aveva alloggiato, un Carlo Colonna sonator di liuto. Allora tutti i pigionali di quella casa furono, d’ordine della Sanità, condotti al lazzeretto, dove la piú parte s’ammalarono; alcuni morirono, dopo poco tempo, di manifesto contagio.
Nella città, quello che già c’era stato disseminato da costoro, da’ loro panni, da’ loro mobili trafugati da parenti, da pigionali, da persone di servizio, alle ricerche e al fuoco prescritto dal tribunale, e di piú quello che c’entrava di nuovo, per l’imperfezion degli editti, per la trascuranza nell’eseguirli, e per la destrezza nell’eluderli, andò covando e serpendo lentamente, tutto il restante dell’anno, e ne’ primi mesi del susseguente 1630. Di quando in quando, ora in questo, ora in quel quartiere, a qualcheduno s’attaccava, qualcheduno ne moriva: e la radezza stessa de’ casi allontanava il sospetto della verità, confermava sempre piú il pubblico in quella stupida e micidiale fiducia che non ci fosse peste, né ci fosse stata neppure un momento. Molti medici ancora, facendo eco alla voce del popolo (era, anche in questo caso, voce di Dio?), deridevan gli augúri sinistri, gli avvertimenti minacciosi de’ pochi; e avevan pronti nomi di malattie comuni, per qualificare ogni caso di peste che fossero chiamati a curare; con qualunque sintomo, con qualunque segno fosse comparso.
Gli avvisi di questi accidenti, quando pur pervenivano alla Sanità, ci pervenivano tardi per lo piú e incerti. Il terrore della contumacia e del lazzeretto aguzzava tutti gl’ingegni: non si denunziavan gli ammalati, si corrompevano i becchini e i loro soprintendenti; da subalterni del tribunale stesso, deputati da esso a visitare i cadaveri, s’ebbero, con danari, falsi attestati.
Siccome però, a ogni scoperta che gli riuscisse fare, il tribunale ordinava di bruciar robe, metteva in sequestro case, mandava famiglie al lazzeretto, cosí è facile argomentare quanta dovesse essere contro di esso l’ira e la mormorazione del pubblico, «della Nobiltà, delli Mercanti et della plebe», dice il Tadino; persuasi, com’eran tutti, che fossero vessazioni senza motivo, e senza costrutto. L’odio principale cadeva sui due medici; il suddetto Tadino, e Senatore Settala, figlio del protofisico: a tal segno, che ormai non potevano attraversar le piazze senza essere assaliti da parolacce, quando non eran sassi. E certo fu singolare, e merita che ne sia fatta memoria, la condizione in cui, per qualche mese, si trovaron quegli uomini, di veder venire avanti un orribile flagello, d’affaticarsi in ogni maniera a stornarlo, d’incontrare ostacoli dove cercavano aiuti, e d’essere insieme bersaglio delle grida, avere il nome di nemici della patria: pro patriae hostibus, dice il Ripamonti.
Di quell’odio ne toccava una parte anche agli altri medici che, convinti come loro, della realtà del contagio, suggerivano precauzioni, cercavano di comunicare a tutti la loro dolorosa certezza. I piú discreti li tacciavano di credulità e d’ostinazione: per tutti gli altri, era manifesta impostura, cabala ordita per far bottega sul pubblico spavento.
Il protofisico Lodovico Settala, allora poco men che ottuagenario, stato professore di medicina all’università di Pavia, poi di filosofia morale a Milano, autore di molte opere riputatissime allora, chiaro per inviti a cattedre d’altre università, Ingolstadt, Pisa, Bologna, Padova, e per il rifiuto di tutti questi inviti, era certamente uno degli uomini piú autorevoli del suo tempo. Alla riputazione della scienza s’aggiungeva quella della vita, e all’ammirazione la benevolenza, per la sua gran carità nel curare e nel beneficare i poveri. E, una cosa che in noi turba e contrista il sentimento di stima ispirato da questi meriti, ma che allora doveva renderlo piú generale e piú forte, il pover’uomo partecipava de’ pregiudizi piú comuni e piú funesti de’ suoi contemporanei: era piú avanti di loro, ma senza allontanarsi dalla schiera, che è quello che attira i guai, e fa molte volte perdere l’autorità acquistata in altre maniere. Eppure quella grandissima che godeva non solo non bastò a vincere, in questo caso, l’opinion di quello che i poeti chiamavan volgo profano, e i capocomici, rispettabile pubblico; ma non poté salvarlo dall’animosità e dagl’insulti di quella parte di esso che corre piú facilmente da’ giudizi alle dimostrazioni e ai fatti.
Un giorno che andava in bussola a visitare i suoi ammalati, principiò a radunarglisi intorno gente, gridando esser lui il capo di coloro che volevano per forza che ci fosse la peste; lui che metteva in ispavento la città, con quel suo cipiglio, con quella sua barbaccia: tutto per dar da fare ai medici. La folla e il furore andavan crescendo: i portantini, vedendo la mala parata, ricoverarono il padrone in una casa d’amici, che per sorte era vicina. Questo gli toccò per aver veduto chiaro, detto ciò che era, e voluto salvar dalla peste molte migliaia di persone: quando, con un suo deplorabile consulto, cooperò a far torturare, tanagliare e bruciare, come strega, una povera infelice sventurata, perché il suo padrone pativa dolori strani di stomaco, e un altro padrone di prima era stato fortemente innamorato di lei , allora ne avrà avuta presso il pubblico nuova lode di sapiente e, ciò che è intollerabile a pensare, nuovo titolo di benemerito.
Ma sul finire del mese di marzo, cominciarono, prima nel borgo di porta orientale, poi in ogni quartiere della città, a farsi frequenti le malattie, le morti, con accidenti strani di spasimi, di palpitazioni, di letargo, di delirio con quelle insegne funeste di lividi e di bubboni; morti per lo piú celeri, violente, non di rado repentine, senza alcun indizio antecedente di malattia. I medici opposti alla opinion del contagio, non volendo ora confessare ciò che avevan deriso, e dovendo pur dare un nome generico alla nuova malattia, divenuta troppo comune e troppo palese per andarne senza, trovarono quello di febbri maligne, di febbri pestilenti: miserabile transazione, anzi trufferia di parole, e che pur faceva gran danno; perché, figurando di riconoscere la verità, riusciva ancora a non lasciar credere ciò che piú importava di credere, di vedere, che il male s’attaccava per mezzo del contatto. I magistrati, come chi si risente da un profondo sonno, principiarono a dare un po’ piú orecchio agli avvisi, alle proposte della Sanità, a far eseguire i suoi editti, i sequestri ordinati, le quarantene prescritte da quel tribunale. Chiedeva esso di continuo anche danari per supplire alle spese giornaliere, crescenti, del lazzeretto, di tanti altri servizi; e li chiedeva ai decurioni, intanto che fosse deciso (che non fu, credo, mai, se non col fatto) se tali spese toccassero alla città, o all’erario regio. Ai decurioni faceva pure istanza il gran cancelliere, per ordine anche del governatore, ch’era andato di nuovo a metter l’assedio a quel povero Casale; faceva istanza il senato, perché pensassero alla maniera di vettovagliar la città, prima che dilatandovisi per isventura il contagio, le venisse negato pratica dagli altri paesi; perché trovassero il mezzo di mantenere una gran parte della popolazione, a cui eran mancati i lavori. I decurioni cercavano di far danari per via d’imprestiti, d’imposte; e di quel che ne raccoglievano, ne davano un po’ alla Sanità, un po’ a’ poveri; un po’ di grano compravano: supplivano a una parte del bisogno. E le grandi angosce non erano ancor venute.
Nel lazzeretto, dove la popolazione, quantunque decimata ogni giorno, andava ogni giorno crescendo, era un’altra ardua impresa quella d’assicurare il servizio e la subordinazione, di conservar le separazioni prescritte, di mantenervi in somma o, per dir meglio, di stabilirvi il governo ordinato dal tribunale della sanità: ché, fin da’ primi momenti, c’era stata ogni cosa in confusione, per la sfrenatezza di molti rinchiusi, per la trascuratezza e per la connivenza de’ serventi. Il tribunale e i decurioni, non sapendo dove battere il capo, pensaron di rivolgersi ai cappuccini, e supplicarono il padre commissario della provincia, il quale faceva le veci del provinciale, morto poco prima, acciò volesse dar loro de’ soggetti abili a governare quel regno desolato. Il commissario propose loro, per principale, un padre Felice Casati, uomo d’età matura, il quale godeva una gran fama di carità, d’attività, di mansuetudine insieme e di fortezza d’animo, a quel che il seguito fece vedere, ben meritata; e per compagno e come ministro di lui, un padre Michele Pozzobonelli, ancor giovine, ma grave e severo, di pensieri come d’aspetto. Furono accettati con gran piacere; e il 30 di marzo, entrarono nel lazzeretto. Il presidente della Sanità li condusse in giro, come per prenderne il possesso; e, convocati i serventi e gl’impiegati d’ogni grado, dichiarò, davanti a loro, presidente di quel luogo il padre Felice, con primaria e piena autorità. Di mano in mano poi che la miserabile radunanza andò crescendo, v’accorsero altri cappuccini; e furono in quel luogo soprintendenti, confessori, amministratori, infermieri, cucinieri, guardarobi, lavandai, tutto ciò che occorresse. Il padre Felice, sempre affaticato e sempre sollecito, girava di giorno, girava di notte, per i portici, per le stanze, per quel vasto spazio interno, talvolta portando un’asta, talvolta non armato che di cilizio; animava e regolava ogni cosa; sedava i tumulti, faceva ragione alle querele, minacciava, puniva, riprendeva, confortava, asciugava e spargeva lacrime. Prese, sul principio, la peste; ne guarí, e si rimise, con nuova lena, alle cure di prima. I suoi confratelli ci lasciarono la piú parte la vita, e tutti con allegrezza.
… Anche nel pubblico, quella caparbietà di negar la peste andava naturalmente cedendo e perdendosi, di mano in mano che il morbo si diffondeva, e si diffondeva per via del contatto e della pratica; e tanto piú quando, dopo esser qualche tempo rimasto solamente tra’ poveri, cominciò a toccar persone piú conosciute. E tra queste, come allora fu il piú notato, cosí merita anche adesso un’espressa menzione il protofisico Settala. Avranno almen confessato che il povero vecchio aveva ragione? Chi lo sa? Caddero infermi di peste, lui, la moglie, due figliuoli, sette persone di servizio. Lui e uno de’ figliuoli n’usciron salvi; il resto morí. «Questi casi, – dice il Tadino, – occorsi nella Città in case Nobili, disposero la Nobiltà, et la plebe a pensare, et gli increduli Medici, et la plebe ignorante et temeraria cominciò stringere le labra, chiudere li denti, et inarcare le ciglia».
Ma l’uscite, i ripieghi, le vendette, per dir cosí, della caparbietà convinta, sono alle volte tali da far desiderare che fosse rimasta ferma e invitta, fino all’ultimo, contro la ragione e l’evidenza: e questa fu bene una di quelle volte. Coloro i quali avevano impugnato cosí risolutamente, e cosí a lungo, che ci fosse vicino a loro, tra loro, un germe di male, che poteva, per mezzi naturali, propagarsi e fare una strage; non potendo ormai negare il propagamento di esso, e non volendo attribuirlo a que’ mezzi (che sarebbe stato confessare a un tempo un grand’inganno e una gran colpa), erano tanto piú disposti a trovarci qualche altra causa, a menar buona qualunque ne venisse messa in campo. Per disgrazia, ce n’era una in pronto nelle idee e nelle tradizioni comuni allora, non qui soltanto, ma in ogni parte d’Europa: arti venefiche, operazioni diaboliche, gente congiurata a sparger la peste, per mezzo di veleni contagiosi, di malíe. Già cose tali, o somiglianti, erano state supposte e credute in molte altre pestilenze, e qui segnatamente, in quella di mezzo secolo innanzi. S’aggiunga che, fin dall’anno antecedente, era venuto un dispaccio, sottoscritto dal re Filippo IV, al governatore, per avvertirlo ch’erano scappati da Madrid quattro francesi, ricercati come sospetti di spargere unguenti velenosi, pestiferi: stesse all’erta, se mai coloro fossero capitati a Milano. Il governatore aveva comunicato il dispaccio al senato e al tribunale della sanità; né, per allora, pare che ci si badasse piú che tanto. Però, scoppiata e riconosciuta la peste, il tornar nelle menti quell’avviso poté servir di conferma al sospetto indeterminato d’una frode scellerata; poté anche essere la prima occasione di farlo nascere.
Ma due fatti, l’uno di cieca e indisciplinata paura, l’altro di non so quale cattività, furon quelli che convertirono quel sospetto indeterminato d’un attentato possibile, in sospetto, e per molti in certezza, d’un attentato positivo, e d’una trama reale. Alcuni, ai quali era parso di vedere, la sera del 17 di maggio, persone in duomo andare ungendo un assito che serviva a dividere gli spazi assegnati a’ due sessi, fecero, nella notte, portar fuori della chiesa l’assito e una quantità di panche rinchiuse in quello; quantunque il presidente della Sanità, accorso a far la visita, con quattro persone dell’ufizio, avendo visitato l’assito, le panche, le pile dell’acqua benedetta, senza trovar nulla che potesse confermare l’ignorante sospetto d’un attentato venefico, avesse, per compiacere all’immaginazioni altrui, e piú tosto per abbondare in cautela, che per bisogno, avesse, dico, deciso che bastava dar una lavata all’assito. Quel volume di roba accatastata produsse una grand’impressione di spavento nella moltitudine, per cui un oggetto diventa cosí facilmente un argomento. Si disse e si credette generalmente che fossero state unte in duomo tutte le panche, le pareti, e fin le corde delle campane. Né si disse soltanto allora: tutte le memorie de’ contemporanei che parlano di quel fatto (alcune scritte molt’anni dopo), ne parlano con ugual sicurezza: e la storia sincera di esso, bisognerebbe indovinarla, se non si trovasse in una lettera del tribunale della sanità al governatore, che si conserva nell’archivio detto di san Fedele; dalla quale l’abbiamo cavata, e della quale sono le parole che abbiam messe in corsivo.
La mattina seguente, un nuovo e piú strano, piú significante spettacolo colpí gli occhi e le menti de’ cittadini. In ogni parte della città, si videro le porte delle case e le muraglie, per lunghissimi tratti, intrise di non so che sudiceria, giallognola, biancastra, sparsavi come con delle spugne. O sia stato un gusto sciocco di far nascere uno spavento piú rumoroso e piú generale, o sia stato un piú reo disegno d’accrescer la pubblica confusione, o non saprei che altro; la cosa è attestata di maniera, che ci parrebbe men ragionevole l’attribuirla a un sogno di molti, che al fatto d’alcuni: fatto, del resto, che non sarebbe stato, né il primo né l’ultimo di tal genere. Il Ripamonti, che spesso, su questo particolare dell’unzioni, deride, e piú spesso deplora la credulità popolare, qui afferma d’aver veduto quell’impiastramento, e lo descrive12. Nella lettera sopraccitata, i signori della Sanità raccontan la cosa ne’ medesimi termini; parlan di visite, d’esperimenti fatti con quella materia sopra de’ cani, e senza cattivo effetto; aggiungono, esser loro opinione, che cotale temerità sia piú tosto proceduta da insolenza, che da fine scelerato: pensiero che indica in loro, fino a quel tempo, pacatezza d’animo bastante per non vedere ciò che non ci fosse stato. L’altre memorie contemporanee, raccontando la cosa, accennano anche, essere stata, sulle prime, opinion di molti, che fosse fatta per burla, per bizzarria; nessuna parla di nessuno che la negasse; e n’avrebbero parlato certamente, se ce ne fosse stati; se non altro, per chiamarli stravaganti. Ho creduto che non fosse fuor di proposito il riferire e il mettere insieme questi particolari, in parte poco noti, in parte affatto ignorati, d’un celebre delirio; perché, negli errori e massime negli errori di molti, ciò che è piú interessante e piú utile a osservarsi, mi pare che sia appunto la strada che hanno fatta, l’apparenze, i modi con cui hanno potuto entrar nelle menti, e dominarle.
La città già agitata ne fu sottosopra: i padroni delle case, con paglia accesa, abbruciacchiavano gli spazi unti; i passeggieri si fermavano, guardavano, inorridivano, fremevano. I forestieri, sospetti per questo solo, e che allora si conoscevan facilmente al vestiario, venivano arrestati nelle strade dal popolo, e condotti alla giustizia. Si fecero interrogatòri, esami d’arrestati, d’arrestatori, di testimoni; non si trovò reo nessuno: le menti erano ancor capaci di dubitare, d’esaminare, d’intendere. Il tribunale della sanità pubblicò una grida, con la quale prometteva premio e impunità a chi mettesse in chiaro l’autore o gli autori del fatto. Ad ogni modo non parendoci conueniente, dicono que’ signori nella citata lettera, che porta la data del 21 di maggio, ma che fu evidentemente scritta il 19, giorno segnato nella grida stampata, che questo delitto in qualsiuoglia modo resti impunito, massime in tempo tanto pericoloso e sospettoso, per consolatione e quiete di questo Popolo, e per cauare indicio del fatto, habbiamo oggi publicata grida, etc. Nella grida stessa però, nessun cenno, almen chiaro, di quella ragionevole e acquietante congettura, che partecipavano al governatore: silenzio che accusa a un tempo una preoccupazione furiosa nel popolo, e in loro una condiscendenza, tanto piú biasimevole, quanto piú poteva esser perniciosa.
Mentre il tribunale cercava, molti nel pubblico, come accade, avevan già trovato. Coloro che credevano esser quella un’unzione velenosa, chi voleva che la fosse una vendetta di don Gonzalo Fernandez de Cordova, per gl’insulti ricevuti nella sua partenza, chi un ritrovato del cardinal di Richelieu, per spopolar Milano, e impadronirsene senza fatica; altri, e non si sa per quali ragioni, ne volevano autore il conte di Collalto, Wallenstein, questo, quell’altro gentiluomo milanese. Non mancavan, come abbiam detto, di quelli che non vedevano in quel fatto altro che uno sciocco scherzo, e l’attribuivano a scolari, a signori, a ufiziali che s’annoiassero all’assedio di Casale. Il non veder poi, come si sarà temuto, che ne seguisse addirittura un infettamento, un eccidio universale, fu probabilmente cagione che quel primo spavento s’andasse per allora acquietando, e la cosa fosse o paresse messa in oblío.
C’era, del resto, un certo numero di persone non ancora persuase che questa peste ci fosse. E perché, tanto nel lazzeretto, come per la città, alcuni pur ne guarivano, «si diceua» (gli ultimi argomenti d’una opinione battuta dall’evidenza son sempre curiosi a sapersi), «si diceua dalla plebe, et ancora da molti medici partiali, non essere vera peste, perché tutti sarebbero morti»13. Per levare ogni dubbio, trovò il tribunale della sanità un espediente proporzionato al bisogno, un modo di parlare agli occhi, quale i tempi potevano richiederlo o suggerirlo. In una delle feste della Pentecoste, usavano i cittadini di concorrere al cimitero di San Gregorio, fuori di Porta Orientale, a pregar per i morti dell’altro contagio, ch’eran sepolti là; e, prendendo dalla divozione opportunità di divertimento e di spettacolo, ci andavano, ognuno piú in gala che potesse. Era in quel giorno morta di peste, tra gli altri, un’intera famiglia. Nell’ora del maggior concorso, in mezzo alle carrozze, alla gente a cavallo, e a piedi, i cadaveri di quella famiglia furono, d’ordine della Sanità, condotti al cimitero suddetto, sur un carro, ignudi, affinché la folla potesse vedere in essi il marchio manifesto della pestilenza. Un grido di ribrezzo, di terrore, s’alzava per tutto dove passava il carro; un lungo mormorío regnava dove era passato; un altro mormorío lo precorreva. La peste fu piú creduta: ma del resto andava acquistandosi fede da sé, ogni giorno piú; e quella riunione medesima non dové servir poco a propagarla.
In principio dunque, non peste, assolutamente no, per nessun conto: proibito anche di proferire il vocabolo. Poi, febbri pestilenziali: l’idea s’ammette per isbieco in un aggettivo. Poi, non vera peste; vale a dire peste sí, ma in un certo senso; non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome. Finalmente, peste senza dubbio, e senza contrasto: ma già ci s’è attaccata un’altra idea, l’idea del venefizio e del malefizio, la quale altera e confonde l’idea espressa dalla parola che non si può piú mandare indietro. Non è, credo, necessario d’esser molto versato nella storia dell’idee e delle parole, per vedere che molte hanno fatto un simil corso. Per grazia del cielo, che non sono molte quelle d’una tal sorte, e d’una tale importanza, e che conquistino la loro evidenza a un tal prezzo, e alle quali si possano attaccare accessòri d’un tal genere. Si potrebbe però, tanto nelle cose piccole, come nelle grandi, evitare, in gran parte, quel corso cosí lungo e cosí storto, prendendo il metodo proposto da tanto tempo, d’osservare, ascoltare, paragonare, pensare, prima di parlare.
Ma parlare, questa cosa cosí sola, è talmente piú facile di tutte quell’altre insieme, che anche noi, dico noi uomini in generale, siamo un po’ da compatire.
























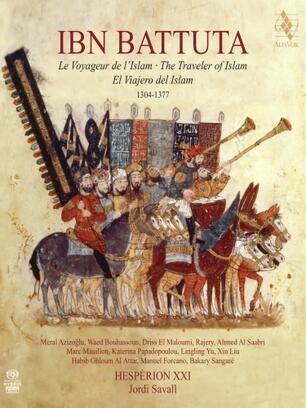




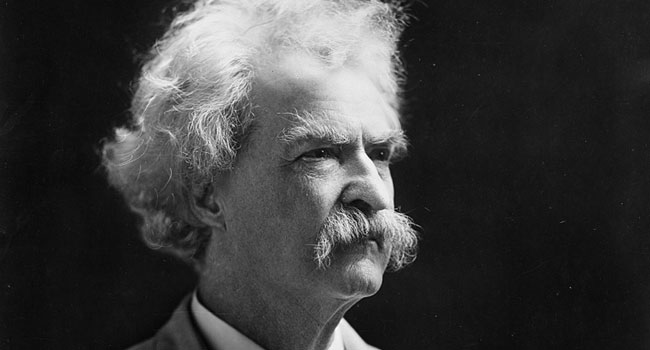












.jpg)





_(14596243719).jpg)